Concetti Chiave
- Il teatro borghese dell'Ottocento rappresenta i drammi e le debolezze della nuova classe emergente, offrendo una funzione sociale e culturale significativa.
- Henrik Ibsen e August Strindberg sono figure chiave del dramma borghese, introducendo temi come l'emancipazione femminile e la critica sociale attraverso la psicologia individuale.
- Oscar Wilde e George Bernard Shaw hanno influenzato il teatro inglese, introducendo il dramma borghese con ironia e profondi spunti di riflessione sociale.
- In Italia, il dramma borghese si sviluppa con autori come Giuseppe Giacosa, mentre il melodramma verista si afferma con opere di Giovanni Verga e Pietro Mascagni.
- Il simbolismo e il realismo si intrecciano nel teatro europeo, con autori come Maurice Maeterlinck e Anton Cechov che esplorano la natura umana e la critica sociale.
In questo appunto di Italiano si tratterà del diffondersi, in Europa nella seconda metà dell'Ottocento, del teatro borghese, che mette in scena i drammi, i segreti e le debolezze della nuova classe sociale emergente.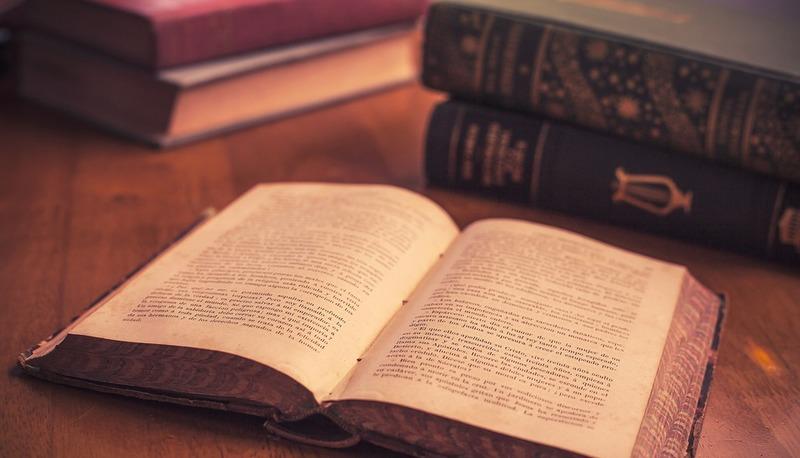
Indice
Il teatro moderno come espressione della borghesia
Nel corso del’800 il teatro andò sempre più assumendo una spiccata funzione sociale: era il luogo di aggregazione della media e alta borghesia, il luogo in cui una società nazionale si riconosceva e stabiliva i parametri della propria identità, ed era anche la sede di appassionati dibattiti culturali. Le opere teatrali fanno riferimento alla realtà, hanno come temi l'amore e il denaro e rispecchiano le manie ed i gesti dell'epoca con l'intento di far sorridere.Nel dramma borghese si trovano richiami al Positivismo e al Naturalismo; si analizza come i personaggi interagiscano tra di loro e con l'ambiente che li circonda. I loro comportamenti, la psicologia, l'influenza dell'educazione sul carattere, i vizi e le virtù. La drammatizzazione della vita del ceto borghese permise la descrizione di interni familiari, di tragedie domestiche, di vicissitudini di personaggi non più "grandiosi" o "eroici" come in passato, ma più vicini al nuovo ceto rampante: i sentimenti nobili non erano più appannaggio di regine o imperatori ma divenivano elementi caratteristici del nuovo stile.
I rappresentati europei del nuovo genere teatrale
I drammi di Henrik Ibsen presentavano intrecci dove si dava rilevanza alla naturalezza delle vicende e dei personaggi. Maestro nel mettere in luce le paure e i turbamenti del borghese europeo, come l’emancipazione della donna dalla sua condizione di subalterna, i difficili rapporti familiari e le problematiche legate al denaro. Da una parte a minacciare la solidità della famiglia vi sono le incomprensioni tra coniugi, le reciproche menzogne e l’adulterio, dall’altra il collasso economico, l’indebitamento, il rischio di impoverimento e la perdita di rispettabilità che ne segue. Il teatro di Ibsen non vuole essere mero intrattenimento, ma stimolare spunti di riflessione e dibattiti.In “Casa di bambola” i due elementi si intersecano e danno origine all’improvviso “risveglio” della coscienza della protagonista, Nora, la quale d’un tratto si rende conto di essersi adeguata ad un genere di vita che il marito e l’etica borghese le avevano cucito addosso e in cui non si riconosce più. In “Spettri” viene svelata l’ipocrisia borghese: i protagonisti, dietro le loro buone maniere e il loro perbenismo, nascondono le loro nefandezze e scandali.Attraverso la psicologia individuale Ibsen muove una critica alla società contemporanea.
Di una generazione successiva rispetto a Ibsen, lo svedese August Strindberg è considerato uno dei fondatori del teatro moderno, in cu ciò che conta non è tanto il susseguirsi degli eventi, quanto la verità interiore; è in essa che risiedono i motivi delle decisioni. Nel teatro di Strindberg si passa dal naturalismo delle prime opere al simbolismo di quelle della maturità, in cui l’elemento onirico e visionario diventano dominanti. Di particolare importanza, come espressione di questa poetica, è "Il sogno", in cui la rappresentazione dello spazio e del tempo non segue criteri oggettivi ma la logica irrazionale delle fantasie notturne.
Il Simbolismo penetrò nel teatro in lingua francese grazie al belga Maurice Maeterlinck; trasportò nelle sue opere l’atmosfera poetica degli elementi simbolici, la forza delle suggestioni, il tutto con uno stile artificiale ma allo stesso tempo ingenuo e seducente. Diede corpo e consistenza alle personali fantasticherie attraverso personaggi evanescenti ma che restavano impressi nell’immaginario per la loro forza tragica.
A partire della seconda metà del secolo, in età vittoriana, con gli impetuosi venti del romanticismo e l’apertura ai nuovi ideali del neoclassicismo, il teatro inglese riprende vigore, anche grazie ad autori come Oscar Wilde. È proprio lui a introdurre in Inghilterra il dramma borghese, trattandolo con leggerezza nel mondo austero del periodo vittoriano. Tra le sue commedie più importanti vi sono: "L'importanza di chiamarsi Ernesto", "Il ventaglio di Lady Windermere", "Una donna senza importanza", "Un marito ideale" e il dramma "Salomè" dai molteplici significati religiosi.
Altra personalità di spicco, di origini irlandesi, è George Bernard Shaw. Nato come critico teatrale e grande ammiratore di Ibsen (di cui diffuse la produzione in Gran Bretagna), affrontò il mestiere d’autore impegnandosi in diversi generi. Scrisse ben sessantasei drammi, più o meno mescolati delle sue idee socialiste, trattando dai temi religiosi e politici fino alla satira sociale. Per lui il teatro era "una fucina di pensieri, una guida per la coscienza, un commentario della condotta sociale, una corazza contro la disperazione e la stupidità e un tempio per l'Elevazione dell'Uomo". Parlava apertamente di prostituzione, alcolismo, sfruttamento del lavoro, arrivismo sociale. Con le sue commedie dense di ironia e di spunti di riflessioni, attaccava le istituzioni, i pregiudizi, le storture della società, l'ipocrisia del perbenismo moralistico inglese.
Tra i maggiori esponenti del teatro di lingua tedesca abbiamo Gerhart Hauptmann, i cui drammi familiari fotografano la decadenza della società borghese; alla fine del secolo, primi del Novecento, troviamo l’austriaco Hugo von Hofmannstahl, che si accostò alla drammaturgia mettendo in scena opere ricche di simbolismo, in cui i personaggi sono spinti dal desiderio di fuggire dalla realtà che li circonda per andare alla ricerca della "bellezza". Le sue opere finali denotano una profondità inconsueta, di forte influenza freudiana. Infine troviamo Frank Wedekind; il suo primo attacco al conformismo della società tedesca dell'epoca avvenne alla fine dell’Ottocento, in cui affrontò in chiave tragica il problema dell'educazione sessuale repressiva degli adolescenti ("Il vaso di Pandora").
In Russia il dramma realistico cominciò ad emergere nei primi dell’Ottocento, e uno dei suoi esponenti più importanti, non solo nella letteratura ma anche nel teatro, fu Lev Tolstoj, che con la sua produzione (non solo narrativa) tentò costantemente di trasmettere realisticamente la società russa in cui viveva.
Insieme a Henrik Ibsen e August Strindberg, il russo Anton Cechov è spesso indicato come una delle tre figure fondamentali nella nascita del primo modernismo nel teatro. Nelle sue opere le vicende familiari vengono analizzate in profondità, spesso rivelando la grettezza e lo scarso coraggio di chi, per timore del giudizio altrui, non prende le giuste decisioni, prediligendo la forma alla sostanza. La natura umana, nei suoi aspetti più profondi, viene portata alla luce, esposta nei suoi difetti. I dialoghi sono semplici e discorsivi (che richiamano anche quelli di Ibsen), e spesso si risolvono in confronti su problemi, in discussioni in cui le questioni che stanno a cuore ai protagonisti sono analizzate sotto tutti gli aspetti. Troviamo anche qui monologhi in cui il personaggio si sottopone ad un’indagine introspettiva per cercare le cause profonde del proprio agire o le cause della propria condizione presente; emblematica è l'opera "Il Gabbiano"
Per approfondimenti sul simbolismo vedi qua
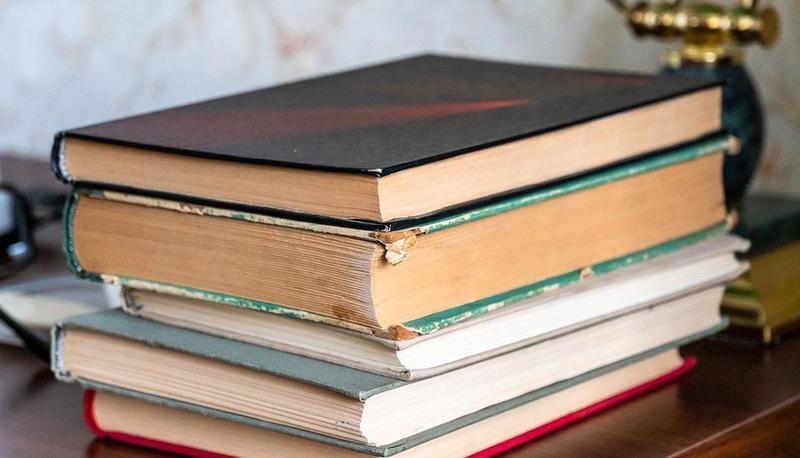
Il dramma borghese in Italia e il melodramma verista
Anche in Italia nella seconda metà dell’Ottocento si afferma il dramma borghese, che condivide con la narrativa la tendenza ad aderire al “vero”. I temi prevalenti sono quelli legati al denaro (i debiti compromettono l’onore e la rispettabilità) o a situazioni sentimentali (il triangolo amoroso con la dinamica amore, tradimento, onore sessuale). L’ambientazione è borghese nel Nord Italia, popolare nel Sud.Uno dei primi rappresentanti del dramma borghese italiano è Giuseppe Giacosa; la maggior parte dei suoi drammi sono fondati «sull’osservazione minuziosa della vita e sulla rappresentazione dei fatti di ogni giorno» come scriveva lo stesso Giocosa, mettendo in luce l’inquietudine e il disagio morale della classe media. Minuziosa è anche la sua descrizione degli ambienti, dei luoghi, che serve a far emergere il dramma narrato, che spesso ruota sul perno del triangolo amoroso. Giacosa scrisse anche i libretti di alcune opere di Giacomo Puccini tra cui "La Bohème", "Tosca" e "Madama Butterfly".
In Italia poi si diffuse il melodramma verista, caratterizzato da colori accesi e toni vibranti, nasce con “Cavalleria rusticana”, con cui Pietro Mascagni mette in musica l’opera di Verga. I drammi veristi di Giovanni Verga sono ambientati in contesti popolari, prevalentemente contadini; l’autore punta sull’oggettività e sulla coralità, portando in scena i costumi arcaici della Sicilia con uno stile rapido e un’azione violenta e drammatica. Anche Luigi Capuana vide nel teatro la possibilità di rappresentare l’oggettività perseguita dal Verismo; la sua è una rappresentazione della realtà spietata e sincera, senza però indagarne le problematiche sociali. La stagione del melodramma verista è l’ultima di genere del dramma borghese, che entrerà in crisi all’inizio del nuovo secolo.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del teatro borghese nella società dell'Ottocento?
- Chi sono alcuni dei principali rappresentanti europei del teatro borghese?
- Quali temi affronta il dramma borghese in Italia?
- Come si differenzia il teatro di August Strindberg rispetto a quello di Henrik Ibsen?
- Qual è l'importanza del melodramma verista in Italia?
Il teatro borghese dell'Ottocento fungeva da luogo di aggregazione per la media e alta borghesia, riflettendo i drammi e le debolezze della nuova classe sociale emergente, e stimolando dibattiti culturali.
Tra i principali rappresentanti europei del teatro borghese ci sono Henrik Ibsen, August Strindberg, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Gerhart Hauptmann, Hugo von Hofmannstahl, Frank Wedekind, Lev Tolstoj e Anton Cechov.
In Italia, il dramma borghese affronta temi legati al denaro e alle situazioni sentimentali, spesso ambientati nel Nord Italia borghese o nel Sud popolare, con un'attenzione particolare alla rappresentazione del "vero".
Il teatro di Strindberg si evolve dal naturalismo al simbolismo, concentrandosi sulla verità interiore e l'elemento onirico, mentre Ibsen si focalizza sulla critica sociale e l'emancipazione individuale attraverso intrecci realistici.
Il melodramma verista in Italia, rappresentato da opere come "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni, è caratterizzato da colori accesi e toni vibranti, portando in scena la realtà popolare e contadina con un'azione drammatica e violenta.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo