...a Proposito Di Donne.. Arte, Colore, Calore, Dolore, Emozioni
Premium
Un percorso attraverso le immagini per arrivare allo stato puro dell'essere donna. Biografie, pensieri, opere e parole di cinque donne diverse per cultura, estrazione sociale e collocazione nel mondo ma simili nell'anima e sicuramente straordinarie
…continua
...e Se Dio Suonasse Il Violino: La Teoria Delle Stringhe
Premium
Questa tesina affronta la stupefacente teoria delle stringhe.
…continua
...Gioco Il Jolly!!!
Premium
Una tesina, viaggio nel Solitario della Vita per imparare a vivere da jolly l'immensità di ogni singolo istante, senza lasciarsi vivere dalla quotidianità, dimentichi di sé stessi.
…continua
...la Bocca Mi Baciò Tutto Tremante..
Premium
Tesina - Premio maturità 2009 Titolo: ...la bocca mi baciò tutto tremante.. Autore: Cicala Luana Descrizione: la tesina tratta il tema d
…continua
"C'è Expo Ed Expo" Tesina
Premium
Tesina di maturità per Istituto tecnico commerciale che vuole approfondire il discorso delle esposizioni universali attraverso l'analisi finanziaria e patrimoniale di Expo Milano 2015.
…continua
"Energeticamente": Il Sole Una Risorsa Di Vita, Tesina
Tesina di maturità 2017. Con il titolo ["Energeticamente": il sole una risorsa di vita andrò a spiegare il ruolo delle energie rinnovabili; risaltando in particolar modo quella del fotovoltaico.
…continua
"Energeticamente": Il Sole Una Risorsa Di Vita, Tesina
Premium
Tesina di maturità 2017. Con il titolo ["Energeticamente": il sole una risorsa di vita andrò a spiegare il ruolo delle energie rinnovabili; risaltando in particolar modo quella del fotovoltaico.
…continua
"Giocare In Modo Rigoroso"
Premium
Tesina - Premio maturità 2009 Titolo: "Giocare in modo rigoroso" Autore: Bizzotto Chiara Scuola: Liceo scientifico Descrizione: applicazione della teoria matematica a "situazioni tipicamente umane". Come argomento dell'a
…continua
"Il Cinema Negli Anni '50-'60"
Premium
Tesina - Premio maturità 2009 Titolo: "Il cinema negli anni '50-'60" Autore: Guglietti Ambra Descrizione: ho svolto la presen
…continua
"Il Peso Della Leggerezza"
Premium
Tesina sulla precarietà dell'esistenza, sulla scelta tra sopportazione del dolore e felicità.
…continua
"Imputato Alzatevi!" Processo Ai Giusti
Premium
La tesina prende in considerazione i processi ai quali furono sottoposti Socrate, Gesù e Dreyfus. Al di là della distanza cronologica che li separa, questi processi pongono questioni comuni e sempre attuali: il rapporto tra un ideale di giustizia assolu
…continua
"L'amore è Universale Ma Alcuni Amori Sono Più Universali Di Altri" Tesina
Premium
Tesina esame maturità Liceo scientifico sull'omosessualità. Collegamenti:
…continua
"La Dolce Vita"? - Anni Sessanta E Postmoderno
Premium
Tesina - Premio maturità 2009 Titolo: "La dolce vita"? - anni sessanta e postmoderno Autore: Asta Carlo Descrizione: questo lav
…continua
"Nessun Bambino Dovrebbe Mai Impugnare Strumenti Di Lavoro"
Tesina per scuola media - Incentrata sul lavoro minorile,tema che accomuna anche i paesi più industrializzati del mondo,questo percorso interdisciplinare prende il titolo da una famosa citazione di Iqbal Masih,il bambino simbolo della lotta contro il lavo
…continua
"Nessun Bambino Dovrebbe Mai Utilizzare Strumenti Di Lavoro"
Tesina per scuola media - Incentrato sullo sfruttamento minorile,tema che accomuna anche paesi industrializzati,il mio percorso interdisciplinare prende il titolo da una famosa citazione di Iqbal Masih,il bambino simbolo della lotta contro il lavoro infan
…continua
"Oh Cielo Sopra Di Me! Tu Sei Per Me"
Tesina - Premio maturità 2008 Titolo: ?‚«oh cielo sopra di me! tu sei per me Autore: Marco Giampaolo Descrizione: il caso nella storia del pensiero scientifico, nell'arte e nella letteratura. Materie trattate: matematica, f
…continua
"Oh Cielo Sopra Di Me! Tu Sei Per Me"
Premium
Tesina - Premio maturità 2008 Titolo: ?‚«oh cielo sopra di me! tu sei per me Autore: Marco Giampaolo Descrizione: il caso nella storia del pensiero scientifico, nell'arte e nella letteratura. Materie trattate: matematica, f
…continua
"Ove Tende Questo Vagar Mio Breve [...]?"
Premium
Tesina - Premio maturità 2009 Titolo: "Ove tende questo vagar mio breve [...]?" Autore: Castellari Valentina Scuola: Liceo scientifico Descrizione: "Ove tende questo vagar mio breve [ ] ?" Gli uomini, nel corso dei vari secoli,
…continua
"S"Composizione- Tesina Maturità
Premium
Percorso multidisciplinare per l'esame di Maturità.Storia della guerra civile spagnola raccontata partendo dal quadro Guernica di Picasso e breve storia della scomposizione psicanalitica del pensiero Freudiano con analisi della coscienza di Zeno
…continua
"S"Composizione- Tesina Maturità
Percorso multidisciplinare per l'esame di Maturità.Storia della guerra civile spagnola raccontata partendo dal quadro Guernica di Picasso e breve storia della scomposizione psicanalitica del pensiero Freudiano con analisi della coscienza di Zeno
…continua




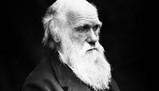
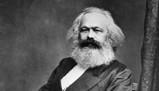


 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo