
C'è un momento nella storia contemporanea in cui il mondo cambia volto. Un prima e un dopo netti, brutali, scolpiti nella carne viva di un'intera generazione: la Prima guerra mondiale. Più che un capitolo di storia, è uno spartiacque culturale, politico, artistico. Un detonatore di trasformazioni che, oltre alle trincee, ha attraversato le pagine dei poeti, i manifesti delle avanguardie, i laboratori scientifici e i corridoi della diplomazia.
Per questo motivo, quando si parla di interdisciplinarità alla Maturità 2025, la Grande Guerra continua a offrire uno dei punti di partenza più fertili. Non perché “capita spesso all’orale” – anche se è vero –, ma perché si presta a collegamenti trasversali che parlano di ieri, ma anche di oggi: conflitti armati, nazionalismi in risalita, tecnologia applicata alla guerra, propaganda, migrazioni forzate.
In questo articolo esploriamo alcuni collegamenti originali e stimolanti tra la Prima guerra mondiale e le principali materie scolastiche, andando oltre gli accostamenti più ovvi, per aiutarti a costruire un discorso personale, attuale, consapevole.
Indice
- Italiano: la guerra scritta in versi (e in silenzi)
- Storia dell’arte: la guerra tra futurismo, rovine e disincanto
- Inglese: Hemingway e il trauma che scrive
- Francese: Apollinaire, ferito tra parole e nazionalità
- Filosofia: la crisi della ragione e la riflessione sulla guerra
- Scienze: la guerra che accelera l’innovazione (e la medicina)
Italiano: la guerra scritta in versi (e in silenzi)
Quando si pensa alla Prima guerra mondiale in letteratura italiana, il primo nome che viene in mente è Giuseppe Ungaretti. Ma c’è di più da dire rispetto al semplice fatto che combatté sul fronte del Carso. Ungaretti trasforma il dolore individuale in parola scarna e assoluta, rompendo con le forme retoriche del passato. Le sue poesie sono fendenti: brevi, silenziose, taglienti come baionette.
Accanto a lui si può evocare Gabriele D’Annunzio, che della guerra fa invece spettacolo, estetica, eroismo. La sua partecipazione al conflitto culmina nel gesto teatrale dell’impresa di Fiume.
Un terzo nome? Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo e teorico della “guerra come igiene del mondo”. Tre visioni della guerra: tragica, eroica, glorificata. Tutte, in fondo, attualissime se lette alla luce delle narrazioni contemporanee sui conflitti.
Storia dell’arte: la guerra tra futurismo, rovine e disincanto
Nel campo artistico, la guerra è musa e mostro, insieme. Il Futurismo, corrente tutta italiana, celebra il movimento, la velocità, la modernità bellica. Le tele di Balla, Boccioni, Carrà e Severini sono manifesti d’energia e patriottismo, proiettili pittorici sparati contro la tradizione.
Ma dopo il 1918, lo slancio si spegne. Nella pittura europea emergono correnti di disillusione come la Nuova Oggettività tedesca o i paesaggi spettrali di Otto Dix, veterano di guerra, che racconta con crudezza la devastazione e la follia.
Allo stesso modo, anche in Inghilterra, pittori come Paul Nash raffigurano le trincee abbandonate, gli alberi spezzati, i crateri causati dai bombardamenti, trasformando la natura stessa in simbolo di un’umanità ferita.
Anche le rovine diventano quindi soggetto artistico: memoria della caduta dell’uomo e monito per il futuro. Un contrasto tra entusiasmo e trauma, che si presta a una riflessione profonda su come l’arte rifletta – o anticipi – le derive della storia.
Inglese: Hemingway e il trauma che scrive
Tra le penne più iconiche del primo dopoguerra, Ernest Hemingway ha vissuto il conflitto come volontario della Croce Rossa in Italia. Ferito, ne porta il trauma nella scrittura asciutta e limpida che lo renderà celebre. "Addio alle armi", romanzo ispirato alla sua esperienza, è più di una cronaca: è il rifiuto della retorica, il ritratto di un’umanità che crolla sotto il peso dell’insensatezza bellica.
Hemingway è anche il precursore di un intero filone di narrativa disillusa, quella "Lost Generation" che nel 2025 possiamo rileggere alla luce dei tanti giovani che oggi vivono in contesti di guerra o post-conflitto, tra Ucraina, Medio Oriente e non solo. Un ponte diretto tra passato e presente.
Francese: Apollinaire, ferito tra parole e nazionalità
Guillaume Apollinaire, poeta francese di origini polacche, rappresenta un altro sguardo sul conflitto. Ferito alla testa durante la guerra, conia il termine "surrealismo" e scrive versi che oscillano tra patriottismo e sperimentazione. Le sue Calligrammes, poesie visive che giocano con la forma, sono frutto dell’esperienza al fronte, ma anche tentativo di rigenerare il linguaggio in un mondo devastato.
Nel contesto 2025, Apollinaire è un autore interessante anche per la sua identità mista, in un’Europa in cui i concetti di nazione e confine tornano a essere dibattuti, proprio come ai tempi delle guerre mondiali.
Filosofia: la crisi della ragione e la riflessione sulla guerra
La Prima guerra mondiale rappresenta un punto di svolta anche nel pensiero filosofico, segnando la crisi delle certezze ottocentesche e l'emergere di nuove riflessioni sul conflitto e sulla natura umana.
Bertrand Russell, filosofo e matematico britannico, si oppose fermamente alla guerra, sostenendo che il conflitto fosse il risultato di errori politici e morali. La sua posizione pacifista lo portò a essere incarcerato e a perdere la cattedra a Cambridge. Russell rappresenta la voce della ragione che si oppone alla follia bellica.
Henri Bergson, invece, interpretò la guerra come uno scontro tra lo spirito creativo e la meccanicità. Nelle sue opere, come L'energia spirituale, egli contrappone la vitalità della coscienza alla rigidità della materia, vedendo nel conflitto un'occasione per il rinnovamento spirituale.
Arriviamo così a Ludwig Wittgenstein che, durante il servizio militare, scrisse i Quaderni 1914-1916, che influenzarono profondamente il suo Tractatus logico-philosophicus. In queste opere, Wittgenstein esplora i limiti del linguaggio e della realtà, riflettendo sulla possibilità di esprimere l'ineffabile, un tema acuito dall'esperienza della guerra.
Altro nome da scomodare è quello di Vladimir Lenin: nei suoi Quaderni filosofici, analizza la dialettica hegeliana e la applica alla realtà rivoluzionaria. La guerra, per Lenin, è il risultato delle contraddizioni del capitalismo, e solo attraverso la rivoluzione proletaria è possibile superare le ingiustizie sociali.
Scienze: la guerra che accelera l’innovazione (e la medicina)
Non c’è guerra senza tecnologia. E quella del 1914-1918 inaugura una nuova era. È il momento in cui la chimica diventa arma, con i gas tossici usati nelle trincee. Ma è anche il tempo in cui la medicina fa passi da gigante: la gestione dei feriti porta alla nascita della chirurgia plastica moderna, alle prime ambulanze motorizzate, allo sviluppo delle trasfusioni.
La fisica, intanto, progredisce sul versante delle comunicazioni: la radio diventa cruciale nei telegrafi da campo, e l’elettricità comincia a essere utilizzata sistematicamente anche in ambito bellico. Un'accelerazione della ricerca che ricorda, per certi versi, quella che abbiamo visto durante l’emergenza pandemica o nei recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale in campo militare. Anche qui, la Prima guerra mondiale ha segnato l'inizio di qualcosa che ci riguarda ancora oggi.


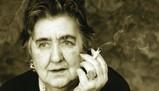




 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo