Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
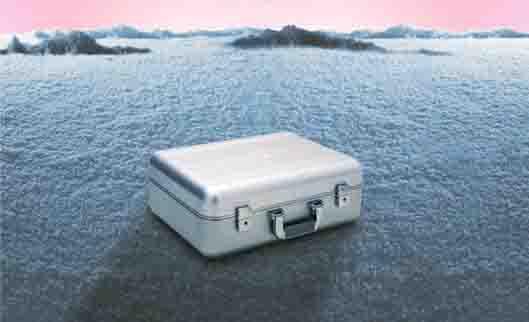
Sintesi Tesina sul viaggio
La tesina sul viaggio descrive il viaggio secondo un percorso multidisciplinare. Il viaggio da sempre è considerato come fonte di svago, un mezzo attraverso cui conoscere nuove culture, sperimentare nuove forme di comunicazione, conoscere il diverso, le tradizioni e il folklore di un luogo. Questo però può essere inteso però anche come riscoperta della bellezza della natura, magari visitando parchi e paesaggi naturali. Molto importante in tal senso è l'analisi dell'Io decadente attraverso Pascoli, Pirandello e Svevo. L'io di Pascoli è un io scisso; Svevo invece analizza l'incapacità di vivere dell'uomo moderno in un'era segnata dalla crisi del passaggio tra due secoli. Pirandello invece afferma che l'Io abbia un rapporto con sè stesso e con la realtà esterna; egli afferma come l'umanità sia fragile. Il legame con il decadentismo è testimoniato attraverso l'opera "Il ritratto di Dorian Gray" in cui Oscar Wilde descrive il tema della bellezza estetica attraverso la figura di Dorian Gray, che ama il bello, rappresentando l'icona dell'uomo dandy.
Nell'ambito letterario francese invece molto importante è Charles Baudelaire che, nell'opera "Les fleurs du mal", descrive la condizione ideale che potrà essere raggiunta dall'uomo sdolo attraverso la morte. L'artista, secondo il poeta francese, deve liberare il suo popolo dall'oppressione della monarchia. In ambito artistico il viaggio viene rappresentato come scoperta, come fuga e come evasione. L'artista De Nittis afferma che il viaggio sia utile al fine di conoscere il nuovo, mentre Paul Gauguin lo intende come un'evasione alla riscoperta di popoli primitivi, sconosciuti. Il viaggio può essere anche organizzato da un'agenzia, ma non deve essere inteso solo come un pacchetto turistico che si sta vendendo, ma anche come un'esperienza positiva alla scoperta di nuovi luoghi, come ad esempio la Valle d'Itria, in Puglia.
Importante, in connessione al viaggio, è la scelta che generalmente avviene tra mutuo e leasing; un importante criterio di scelta è quello della preferenza assoluta che si può adottare se il risultato della scelta è evidente. Molto importante è anche la scelta tra investimenti finanziari e investimenti industriali. In questa tesina di maturità quindi viene analizzato il tema del viaggio sotto vari punti di vista.
Tesina sul viaggio, collegamenti
Italiano: L'io in Pirandello, Svevo e Pascoli.
Inglese: Il ritratto di Dorian Gray (Oscar Wilde).
Francese: Les fleurs du mal di Baudelaire.
Sociologia: Il viaggio come conoscenza del diverso.
Storia dell'arte: Il viaggio come evasione, come conoscenza del nuovo.
Turismo: La Valle d'Itria.
Economia: Le modalità di scelta.
Altre tesine sul viaggio
Viaggio nella storia - Tesina Maturità- tesina multidisciplinare sul viaggio.
Belle époque: viaggio tra arte e letteratura- Tesina multidisciplinare sul viaggio nella Belle Epoque.
Viaggio - Verso una meta: il viaggio come esperienza fisica e morale- Tesina multidisciplinare sul viaggio come esperienza fisica e morale.
Alla ricerca di Itaca- Tesina per liceo classico sul viaggio.
Australia e colonialismo - Tesina per scuola media sul viaggio alla conoscenza dell'Australia.
Viaggio: Metafora della vita- Tesina che tratta del viaggio attraverso vari autori.
Viaggio nei sogni- Tesina in Power Point sul viaggio attraverso il sogno.
Viaggio verso l'ignoto- Tesina che descrive il viaggio come spostamento nello spazio e nel tempo.
Viaggio: ricerca di esperienze dentro e fuori di sè - Tesina sul viaggio come esperienza.
Viaggio, un modo per conoscersi- Tesina che tratta del viaggio come mezzo per fare conoscenze.
Pink Floyd, il lato oscuro della luna- Tesina che tratta del viaggio attraverso la musica dei Pink Floid.
Coca-Cola, ieri e oggi- Tesina per istituto professionale per grafico pubblicitario che effettua un viaggio tra le tappe più importanti dell'azienda Coca-cola.
Viaggio - Ottocento e Novecento- Tesina di maturità sul viaggio.
L’I O DECADENTE ATTRAVERSO
PASCOLI SVEVO E PIRANDELLO
Nel periodo compreso tra fine ‘800 e inizio ‘900, una vera e propria rivoluzione
investe i più diversi campi del sapere e sancisce il passaggio dall’uomo moderno
all’uomo contemporaneo. Questa svolta epocale in letteratura si esprime nel
decadentismo che ha apportato un profondo cambiamento nel modo di concepire
l’arte, i suoi scopi, suoi strumenti. Utilizzando il criterio dell’ “arte per l’arte”, i
decadenti, tendono ad emarginarsi dalla società,fuggire dalla realtà, a crearsi un
proprio mondo, di bellezza fuori dalla storia, senza giustificazioni esterne e
considerando volgare un opera destinata al vasto pubblico. Se prima quindi, il fine
eteròs
dell’arte era (diverso) dall’arte, stava cioè nella religione, nella scienza ecc.,
autòs).
adesso il fine dell’arte è l’arte stessa ( L’arte non deve più mantenersi fedele
al vero; ciò che è artificiale è preferibile a ciò che è reale, ciò che è estetico vale
molto più di ciò che è pratico. Il compito della poesia è quello suggerire, rivelare,
l’Io
piuttosto che comunicare o dire. Un questo clima è al centro di una generale
discussione che si esprimerà attraverso i principali autori decadenti italiani: Giovanni
Pascoli esprimerà l’inquietudine del profondo dietro l’innocenza; Italo Svevo parlerà
Io Uno,
di inettitudine umana, Luigi Pirandello di un di cui non esiste e che è “
nessuno centomila”.
Il percorso di Pascoli, per la quale autobiografia più che per altri, è la chiave per
comprendere a fondo la sua poetica, potrebbe
essere definito più una marcia sul posto che un
vero e proprio itinerario. Per il poeta, l’io
dell’uomo, è scisso. Esiste una parte che si
trasforma con il passare del tempo, invece
un'altra fanciullesca che rimane identica a se
stessa. Nella poesia, l’Io normale, quotidiano,
non viene accettato, e lascia il posto all’Io
“fanciullino”. Questa scissione, diviene la base
per un umanitarismo dei buoni e innocenti
sentimenti che secondo lui permetterebbe di
risolvere i conflitti sociali. Il fanciullino, infatti,
non conosce differenze di classe: egli è nel
contadino, nell’operaio, nel banchiere ecc… Nella
sua poesia “moderna”, il poeta sceglie la 5
“regressione”, intesa come ritorno all’infanzia come fase di ingenuità e innocenza.
Questo rappresenta “l’Io” immobile. La fuga dalla realtà e la ricerca poetica
intesa come strumento di conoscenza sono i temi ricorrenti nella poetica
pascoliana. La sua produzione, è un continuo girare intorno al nucleo dell’angoscia
infantile, un tuffarvisi dentro, un cercare continuamente calore, la sicurezza, l’affetto,
<<Fanciullino>>
la protezione che il Pascoli non aveva mai potuto provare. È proprio
nella celebre prosa “Il Fanciullino” che troviamo espressa con grande chiarezza la
concezione poetica che pervade tutta la produzione pascoliana. Dietro questa
celebre prosa, troviamo un mondo inquietante e ricco di sofferenze. Per il poeta, la
poesia, è essenzialmente ricordo in quanto la conoscenza del presente consiste nel
riconoscere e ritrovare i segni che portano dal dolore presente al dolore passato,
come avviene nel componimento L’Assiuolo, dove il Pascoli vuole esprimere
l’incombere dei ricordi e della morte, che impedisce al poeta di godere pienamente la
magia di una notte di luna perché è avvolto dal mistero e dall’angoscia della morte. Il
paesaggio de “L’assiuolo” è uno dei più intensi e suggestivi di tutta la produzione
pascoliana.
Le immagini si susseguono prive di ordine logico, come rivelazioni improvvise via via
più profonde. Il vero filo conduttore è il verso dell’assiuolo, un piccolo rapace
notturno, simile alla civetta, che va ripetendo il suo verso lamentoso: in quella voce
sembra concentrarsi tutta la tristezza dell’universo, tutto il dolore, dell’esistenza nel
suo fatale destino di morte. Dov’era la luna? ché il cielo
notava in un’alba di perla,
ed ergersi il mandorlo e il melo
parevano a meglio vederla.
Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggiù;
veniva una voce dai campi:
chiù...
Le stelle lucevano rare
tra mezzo alla nebbia di latte:
sentivo il cullare del mare,
sentivo un fru fru tra le fratte;
sentivo nel cuore un sussulto,
com’eco d’un grido che fu.
Sonava lontano il singulto:
chiù...
Su tutte le lucide vette
tremava un sospiro di vento:
squassavano le cavallette
finissimi sistri d’argento
(tintinni a invisibili porte
che forse non s’aprono più?...);
e c’era quel pianto di morte...
chiù...
La poesia esteriormente è la descrizione di un notturno lunare. reso attraverso una
serie di sensazioni visive e uditive, ma come sempre il quadro impressionistico si
rivela immerso in un’atmosfera misteriosa.
La natura aspetta la comparsa della luna e le immagini sono quiete, sirene, ma poi si
delinea un’immagine inquietante: il verso delle nubi e il verso dell’assiuolo che a
poco a poco diventa un canto di morte. 6
Il rumore del mare cullare rievoca sensazioni di abbandono infantile alla dolcezza
materna.
Per quanto riguarda il testo de “Il fanciullino”, lo possiamo analizzare a più livelli:
A livello conoscitivo, il fanciullino rappresenta un'altra forma di conoscenza, in
quanto egli si rapporta con il mondo esterno, “sentendo” la natura prima ancora di
conoscerla, in quanto questi, sembrano essere fusi insieme. Non esiste distinzione
netta tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto: il “fanciullino” avverte in tutto la
vita che sente scorrere in sé. La sua conoscenza, di conseguenza, è dominata da un
senso di meraviglia, perché le cose sembrano apparirgli per la prima volta ed è il
“Nuovo Adamo” che da i nomi alle cose per la prima volta, le trasforma in un proprio
mondo mentale.
A livello sensazionale, fanciullino,sono
invece, le sensazione del nettamente
differenti da quelle dell’uomo adulto, anzi, sono decisamente capovolte: il piccolo
diventa grande, il buio diventa visibile… La scissione dell’io si trasforma cosi in
dissociazione sensoriale, nel senso che Pascoli, che da ascolto a questa voce segreta,
ritrovando una capacità sensoriale che ha radici nel passato. È una dimensione
aurorale che nel linguaggio poetico si manifesta con l’uso della sinestesia e
dell’onomatopea.
A livello sentimentale, il mondo del fanciullino è alternativo a quello adulto: la sua
figura svolge un duplice ruolo, ovvero , uno ideologico e uno intimo e personale,
legato fortemente alla condizione psicologica pascoliana. Sul piano ideologico egli
cerca di attutire gli attriti tra le classi con il fine di evitarne lo scontro.
Sul piano intimo invece, la teoria del fanciullino, assume il significato del rifiuto della
crescita, dell’età adulta, della maturità (quella che oggi si chiama sindrome di Peter
Pan) e particolarmente nella sessualità nei confronti della quale Pascoli sembra
avvertire un blocco. La figura del fanciullino, quindi, che il poeta universalizza, in
realtà e tutta e solo sua. Egli è quindi non il poeta della innocenza o dell’ingenuità,
ma usa la dimensione infantile da adulto per purificare i turbamenti di un’ anima che
si trova a disagio nel “mondo dei grandi”.
Invece, a differenza di Pascoli, la narrativa di I. Svevo si configura
come un analisi dell’incapacità di vivere dell’uomo moderno,
collocato in un contesto storico segnato dalla crisi del passaggio
tra i 2 secoli. Secondo lo scrittore , dietro i comportamenti
razionali dell’uomo agiscano spinte inconsapevoli di cui non si
conosce la forza, mutuato da Schopenhauer. Secondo questo suo
modo di pensare, la popolazione è divisa in coloro che agiscono,
lottatori contemplatori,
e coloro che rinunciano, che formano il
inettitudine
nucleo dell’uomo inetto. Per concetto di Svevo
intende l’incapacità e l’estraneità di fronte alla vita, sia perché
essa appare imprevedibile e procede secondo una sua casualità,
sia perché nell’uomo, al di sotto del mondo interiore (la
coscienza), si agitano forze oscure che lo rendono imprevedibile
e estraneo a se stesso. Chi prende coscienza di questa posizione,
di trova bloccato di fronte alla vita, si sente indifferente nei suoi
confronti, non lotta ma contempla divenendo sempre più “inetto”. La coscienza
nell’estraneità della vivere si traduce in indifferenza per la vita, che si mostra quasi
come uno sdoppiamento dell’Io: una parte si lascia coinvolgere dalle illusioni, l’altra
Una Vita,
invece riflette sul vuoto che tormenta l’esistenza. In sin dall’esordio,
l’inettitudine umana si manifesta concretamente con l’incapacità del protagonista
(Alfonso Nitti) di uscire da se stesso, con il suo perenne commiserarsi per
giustificarsi, e rigettando sugli altri tutti gli egoismi e soprusi. Il “mancato
riconoscimento” del protagonista è ancora circoscritto nelle coordinate del 7
verosimile sociale, ma già annuncia l’incapacità del protagonista di fare i conti con la
realtà, il suo malessere interiore e, persino, la scelta del suicidio.
Senilità,
In il suo secondo romanzo, Emilio Brentani, il protagonista, è un Alfonso Nitti
che non si è suicidato , anzi ha realizzato il sogno di pubblicare un proprio romanzo.
Realizzata l’aspirazione letteraria però si apre per lui la percezione del vuoto
esistenziale, ben rappresentata dal titolo. Per un po’ riesce ad entrare nella vita
grazie alla frequentazione delle ragazza, ma proprio in ciò scopre definitivamente la
propria malattia: il sentirsi inadatto alla vita. Sceglie cosi di restarne ai margini,
contemplare quella altrui e rimpiangere come irreversibilmente tramontata la sua
senilità, Una vita
giovinezza. È questa intesa come vecchiezza dell’anima. Se in la
letteratura era il sogno atteso, in questo romanzo essa diventa a sua volta una
malattia, perché costituisce per Brentani una sorta di filtro attraverso cui entrare in
contatto con la realtà fin quasi a diventarne un sostituto. Cosi alla fine ci si sente
vecchi anche senza aver vissuto. Nel terzo romanzo, “la coscienza di Zeno”, Svevo
sottolinea ancor di più la condizione di inettitudine umana: chi prende coscienza di
questo stato, si trova bloccato di fronte alla vita, se ne sente indifferente, non lotta
ma la contempla, divenendo ancor di più inetto. Ma il contemplatore, ha la voglia,
anche, di capire, analizzare e auto analizzarsi. È proprio il senso di estraneità alla vita
che viene messo in risalto nel romanzo. Pirandello si colloca a
livello dei grandi
innovatori del pensiero e
dell’arte del 900 europeo
per quanto riguarda il
rapporto dell’io con se
stesso e con la realtà
esterna e pone al centro
della sua analisi il
problema della
soggettività: attraverso
un attento esame della
realtà egli dimostra
come l’umanità è fragile.
Dato che il mondo
esterno è vissuto da tanti
soggetti e visto, di
conseguenza, attraverso
il filtro della soggettività, è impossibile che la conoscenza di questo sia univoca. È
inutile quindi cercare al di fuori di noi una realtà capace di contrastare la fragilità
umana, perché la realtà esterna è diversa per tutti che si sviluppa con la diretta
esperienza personale. L’umorismo
In questo clima di relativismo Pirandello scrive in cui contrappone la
letteratura umoristica che rappresenta le contraddizioni della realtà, a quella
“sublime” che tende invece a offrire una visione armoniosa e rasserenante.
L’obiettivo dello scrittore non quello di fare ridere il lettore, bensì di farlo riflettere:
l’umorismo che descrive e che definisce sentimento del contrario, consiste nello
scoprire i lati sofferenti che si possono nascondere dietro le persone, di vedere ciò
che va al di la delle apparenze. Di conseguenza le apparenze della vita fanno si che
questa risulti un enorme pupazzata: l’ideologia pirandelliana, quindi, ha lo scopo di
decostruire, di distruggere la forza dell’individuo che si reputa essere coerente e
se vedo una
determinato nei proprio propositi. Lo scrittore propone un esempio: “
vecchia signora coi capelli tinti e tutta imbellettata, avverto che è il contrario di ciò








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









