In questo appunto di algebra sulle equazioni di secondo grado, rivediamo tutta la teoria di base per la comprensione dell'argomento. La dimostrazione della formula risolutiva per l'equazione completa e la formula ridotta sempre vantaggiosa. Vedremo poi come determinare le radici per le equazioni pure, spurie e monomie. Ripassiamo anche le relazioni tra i coefficienti e le radici reali, per scrivere un equazione nella forma analoga a quella del trinomio particolare, già visto nella scomposizione in fattori dei polinomi.
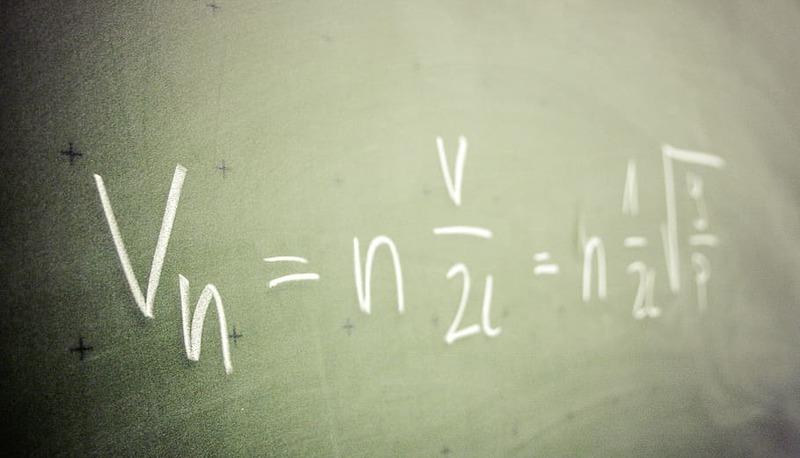
Indice
Forma e termini dell’equazione di secondo grado
La forma generica di una equazione di secondo grado è quella di un polinomio ordinato secondo le potenze decrescenti di x:
Le lettere a, b e c rappresentano numeri reali o espressioni letterali e si chiamano primo, secondo e terzo coefficiente dell’equazione; c è anche detto termine noto.
È necessario supporre che sia sempre
Nelle equazioni di secondo grado la variabile x ha grado massimo 2.
Sono equazioni di secondo grado le seguenti:
Un’equazione di secondo grado è detta:
- completa, se tutti i coefficienti sono non nulli,
- incompleta, se manca b, oppure c.
- se il termine noto c è nullo è detta spuria [math]\to 2x^2-5x=0[/math];
- se è nullo il coefficiente b è detta pura [math]\to x^2-4=0[/math];
- se sono nulli i coefficienti b e c è detta monomia [math]\to 5x^2=0[/math].
Un’equazione può essere ancora classificata in base al tipo di lettere che sono presenti in essa:
-
numerica, se contiene solo l’incognita
letterale, le contiene anche dei parametri
In base alla posizione dell'incognita le equazioni si distinguono in:
-
intere quando l'incognita non compare nei denominatori delle eventuali frazioni;
frazionarie o fratte, quando l'incognita si trova in almeno uno dei denominatori.
Formula risolutiva dell’equazione completa
Risolvere un’equazione di secondo grado significa cercarne le radici, ovvero quei valori che sostituiti alla variabile x verificano l’identità:
In genere, le soluzioni sono valori dell’insieme R dei numeri reali. La formula risolutiva dell’equazione completa è la seguente:
Riportiamo di seguito la dimostrazione che si svolge applicando il metodo del completamento del quadrato di binomio:
- Consideriamo l’equazione di secondo grado nella sua forma generale:: [math]ax^2+bx+c=0[/math];
- Moltiplichiamo ambo i membri dell’equazione per il fattore [math]4a \ \ essendo \ \ a\neq0[/math]ed otteniamo[math]4a^2 x^2+4abx+4ac=0[/math]
- Sommiamo e sottraiamo al primo membro [math]b^2[/math]ed otteniamo[math]4a^2 x^2+4abx+4ac+b^2-b^2=0[/math]
- Riordiniamo ora i termini dell’equazione trasportandone alcuni al secondo membro [math]4a^2 x^2+4abx+b^2=b^2-4ac[/math]
- Notiamo che il primo membro dell’equazione è lo sviluppo di un quadrato di binomio, riscriviamo allora l’uguaglianza come segue: [math](2ax+b)^2=b^2-4ac[/math]
- Risolviamo adesso rispetto all’incognita x: [math]x={-b \pm \sqrt{b^2-4ac}\over 2a}[/math]
-
[math]b^2-4ac > 0[/math]l’equazione ammette due soluzioni reali e distinte[math]\to x_1\neq x_2\in R[/math];
-
[math]b^2-4ac=0[/math]l’equazione ammette due soluzioni reali coincidenti[math]\to x_1=x_2=x-{b\over a}[/math](oppure una sola soluzione, ma con molteplicità due);
-
[math]b^2-4ac > 0[/math]l’equazione, non ha soluzioni in R, ma ammette due soluzioni complesse e coniugate,[math]x_{1,2}\in C.[/math]
Formula ridotta dell’equazione di secondo grado
Quando nell’equazione completa il coefficiente b, è un numero pari, quindi multiplo di 2, è utile applicare una formula, detta ridotta. Per ricavarla, dividiamo tutti i termini dell’equazione per 2:
ora applichiamo la formula risolutiva:
da cui, con le dovute semplificazioni si ha:
ponendo:
la formula ridotta si può scrivere anche in maniera più compatta:
La formula ridotta semplifica notevolmente i calcoli.
Spuria pura e monomia
Per trovare le radici dell’equazione spuria si raccoglie x a fattor comune e si applica la legge di annullamento del prodotto: il prodotto di due o più fattori è zero se almeno uno dei fattori è uguale a zero.
da cui le due soluzioni:
La spuria ha sempre una soluzione nulla.
Un’equazione di secondo grado pura, del tipo
che ha significato solo se:
perciò, come anticipato, i due coefficienti devono essere discordi in segno.
Le due soluzioni hanno la forma:
Un’equazione di secondo grado monomia, del tipo
Equazione a radici complesse, esempio svolto
Risolviamo, a titolo di esempio, una delle equazioni scritte all'inizio:
L’equazione è completa e quindi applichiamo la formula risolutiva vista:
Valutiamo il segno del discriminante:
Il
Ricordando che l’unità immaginaria è:
Le due radici, complesse e coniugate, vanno scritte come segue:
da cui:
Quindi:
Relazioni fra le radici e i coefficienti di un’equazione di secondo grado
Le radici di una equazione di secondo grado sono legate da una relazione di somma s è di prodotto p.La somma s delle radici di un’equazione di secondo grado a discriminante non negativo è uguale al rapporto, cambiato di segno, fra i coefficienti b ed a:
Il prodotto p delle radici di un’equazione di secondo grado a discriminante non negativo è uguale al rapporto fra il termine noto c e il coefficiente a:
Scriviamo allora che:
Queste relazioni servono a risolvere problemi inerenti alle radici di un’equazione senza risolvere l’equazione stessa.
Se scriviamo un’equazione di secondo grado in forma normale, è possibile mettere in relazione i coefficienti a, b e c con la somma s e il prodotto p delle radici.
In un’equazione di secondo grado ridotta a forma normale, in cui il primo coefficiente sia 1, il secondo coefficiente è la somma s delle radici cambiata di segno e il termine noto è il prodotto p delle radici:
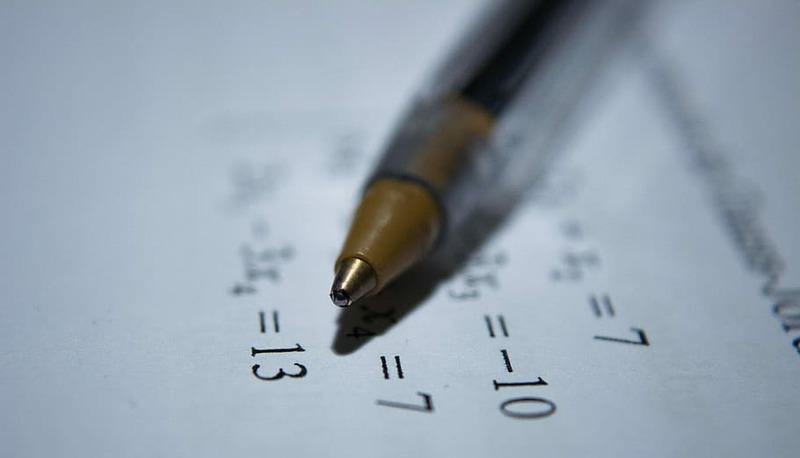
In questo modo dati due numeri qualunque, è possibile scrivere l’equazione di secondo grado che ha come radici quei due numeri.
Esempio:
Scriviamo l’equazione che ha come radici i numeri 3 e 7.
Scriviamo le due relazioni tra le radici fornite:
Ed ora l'equazione richiesta.
Per ulteriori approfondimenti sulle equazioni di secondo grado vedi anche qui







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo