Indice
Il Positivismo e la sua diffusione
Ecco quali sono le principali caratteristiche del positivismo da tenere in considerazione:- Il nome venne coniato in Francia alla fine del 1820 da Saint-Simon, per indicare un metodo di conoscenza della realtà modellato sulle scienze positive, basato sull’osservazione di fenomeni concreti e sul principio della verifica della teoria (prova dei fatti).
- Il movimento filosofico del positivismo venne fondato grazie al sociologo francese Auguste Comte, il quale attraverso la pubblicazione del suo “Corso di filosofia positiva” designò una fase evolutiva della storia dell’umanità: bisognava superare gli stadi teologici (spiegare fenomeni attraverso entità sovrannaturali) e metafisici (sostituire le entità sovrannaturali con principi astratti) per arrivare allo stadio scientifico (o positivo) dove si cerca una spiegazione razionale dei fatti studiando i rapporti di causa-effetto (la concatenazione dei fatti). Comte inoltre affermava che l’uomo andava studiato per quello che è: una specie naturale i cui costumi sono soggetti a leggi determinate come quelle degli altri esseri viventi. Nacque dunque la sociologia: scienza del comportamento umano per individuare i fattori determinanti dell’equilibrio sociale e favorire una continua e pacifica evoluzione della civiltà all’insegna della ragione scientifica.
- Il positivismo francese si allargò negli anni successivi nel campo degli studi storici (Taine) e sociologi (Durkheim)

Altri aspetti del positivismo
Ecco altri aspetti del positivismo:- Secondo Taine l’opera d’arte è il frutto di 3 fattori fondamentali: ambiente, razza e momento storico.
- Il tema centrale del pensiero di Durkheim era il problema delle relazioni tra individuo e società. Secondo lui la “coscienza collettiva” determina le azioni dei singoli individui. Quindi secondo lui l’individuo è generato dalla società.
- In Italia va ricordato Ardigò, il quale propugnò una concezione scientifica della percezione e del pensiero.
- In Inghilterra Charles Darwin elabora la teoria dell’evoluzionismo attraverso le sue opere “L’origine della specie” e “L’origine dell’uomo”. Attraverso l’evoluzionismo ogni specie naturale produce nel tempo piccole variazioni casuali di cui solo alcune permangono a causa della selezione naturale, dove si tende a trasmettere ed esaltare solo le variazioni favorevoli attraverso la sopravvivenza del più forte. Inoltre secondo questa teoria l’uomo è visto come una specie più evoluta nella catena biologica come risultato di una lunga storia naturale e non come un essere creato da Dio.
Nascerà quindi il “Darwinismo sociale”, grazie alla lettura ed interpretazione data da Spencer, il quale interpretò l’evoluzionismo naturale e sociale in cui vi è concorrenza fra le classi, che eleverà il principio della selezione naturale a criterio dei rapporti fra individui o fra popoli attraverso la lotta per la sopravvivenza del più forte (quelli evoluti e non primitivi).
Correnti letterarie e correnti filosofiche
Il Naturalismo ed il Verismo, prosecuzioni del Realismo del 1830.Romanzo Realista
Romanzo Naturalista (Francia)
Verismo (Italia)
Generalità: rappresentazione oggettiva (impersonalità dell’arte) e concreta della realtà.
Applicare alla rappresentazione letteraria e artistica i metodi di ricerca impiegati nelle scienze. Ogni uomo è prima di tutto materia ed istinto.
Personaggi: descrizione della nuova società industriale: la classe borghese.
Rappresentazione delle classi umili, per mostrare il degrado prodotto dall’industrializzazione.
Descrizione: descrizione estremamente precisa di ambientazioni e comportamenti.
Ambiente urbano e industriale, sottoproletariato e bassifondi di Parigi.
Ambiente rurale, misero e arretrato del Meridione italiano.
Narratore onnisciente in 3° persona che commenta e giudica le azioni dei personaggi.
Impersonalità: non conosce i pensieri dei personaggi e non sa cosa succederà loro. Verga per applicare tale tecnica crea quattro strategie:
- Eclissi dell’autore: deve emergere solamente la visione oggettiva della realtà per dare al lettore l’impressione di vivere l’avvenimento. Sono i soli personaggi a narrare la situazione poiché il narratore non può esprimere il suo punto di vista.
- Regressione: dopo che si eclissa si ha un narratore interno alla rappresentazione, deve assimilarsi al livello culturale della comunità del narratore mediante la regressione. Per esempio usa un narratore popolare nei “Malavoglia” ed uno borghese in “Mastro-don Gesualdo”.
- Straniamento: consiste nel rappresentare come “strano” ciò che in realtà non lo è o viceversa. Viene evidenziato così il divario tra la visione del mondo del narratore e quella dell’autore.
- Discorso indiretto libero: gli avvenimenti sono presentati direttamente dai personaggi.
Gli elementi grammaticali per individuare questa strategia sono:
- Assenza di verbi dichiarativi (Dire – Pensare).
- Assenza della congiunzione “che”.
- L’uso della terza persona. In questo caso il linguaggio deve adeguarsi al vero.
Funzione: Prosa piana ed accessibile ad un pubblico non necessariamente dotato di grande cultura letteraria. Funzione sociale della letteratura (lo scrittore può contribuire a migliorare la società).
Visione pessimistica e statica della realtà (lo scrittore non può influire sulla società).
Attenzione alla realtà sociale per il miglioramento sociale delle classi subalterne, rivelando la vera natura umana: la determinazione. Secondo il manifesto dei fratelli Goncourt: “dare dignità letteraria alle “miserie” degli umili e dei poveri”.
Autori: Stendhal, Balzac, Dickens,
Flaubert è ritenuto il continuatore e innovatore del Realismo narrativo ma anche l’iniziatore del Naturalismo poichè (come possiamo vedere in “Madame Bovary“) alcuni caratteri appartengono maggiormente al romanzo naturalista: il narratore è impersonale ed i personaggi sono la piccola borghesia di provincia.
I fratelli Goncourt: scrissero numerosi romanzi ambientati a Parigi che descrivono la vita delle classi inferiori, principali vittime del processo di industrializzazione (specialmente si focalizzano sugli aspetti più degradanti della realtà sociale).
Émile Zola: intellettuale del periodo e caposcuola, scrisse un piccolo saggio: “Il romanzo sperimentale” analizzare i prodotti dell’uomo con un processo scientifico specifico. Il suo romanzo fu influenzato da Polito Teen poiché vivevano nella stessa area geografica ed erano della stessa razza.
Scrisse “Teresa Raquin” definito dallo stesso Zola un romanzo-studio "psicologico e fisiologico", in riferimento alla complessità caratteriale dei personaggi, sui cui comportamenti si incentra l'analisi dello scrittore.
Capuana
Secondo lui lo scrittore deve:- Sostituire al romanzo storico-politico il romanzo di costumi contemporanei.
- Scegliere la realtà italiana.
- Narratore impersonale.
- Non trascurare fantasia e immaginazione.
Verga: Caposcuola ed esponente che scrisse i manifesti più diffusi del Verismo: “Fantasticheria”, “L’amante di Gramigna” e “I Malavoglia” di Verga.
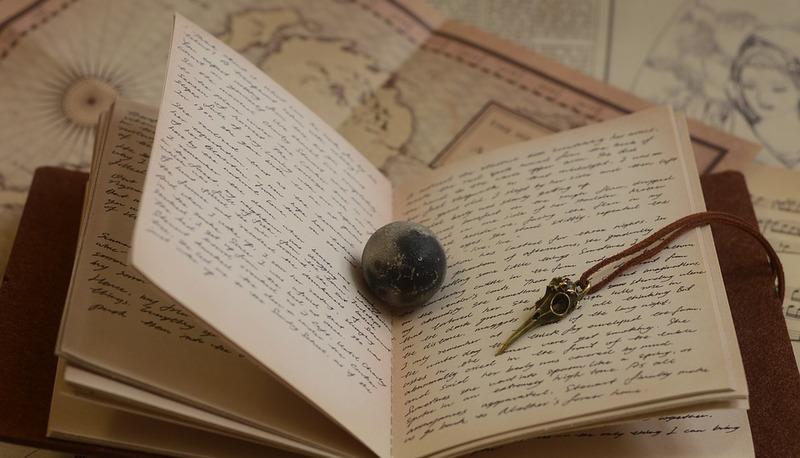







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo