Concetti Chiave
- Dante Alighieri scelse il titolo Commedia per il suo poema, basandosi su una tradizione medievale che differenziava tra commedia e tragedia per tono e contenuto.
- Il titolo "Divina" Commedia fu aggiunto da Boccaccio per sottolineare la bellezza poetica e l'altezza morale del poema, che tratta del viaggio ultraterreno di Dante.
- Il contesto storico e le idee politiche di Dante, tra cui l'amarezza per l'esilio e la critica alla decadenza delle istituzioni, influenzarono profondamente la sua opera.
- La Divina Commedia si ispira a grandi poemi classici come l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide, adottando strutture poetiche e tematiche di viaggio già consolidate.
- Dante utilizza simbolismi numerici e riferimenti a testi sacri e medievali per arricchire il suo poema, integrando elementi come la simbologia trinitaria e influenze da opere come il Tesoretto di Brunetto Latini.
Questo appunto di italiano sulla Divina Commedia spiega la genesi dell’opera nel pensiero dell’autore e affronta l’argomento della scelta del titolo, con un’analisi approfondita del periodo storico in cui l’opera è stata scritta.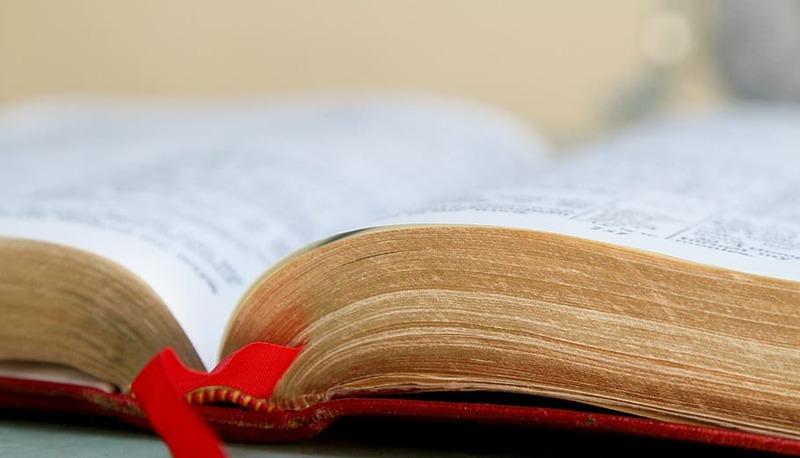
Indice
L’origine del titolo: commedia o tragedia?
La storia dell'origine del titolo dell’opera è abbastanza controversa, infatti i titolo è stato tratto dall’epistola che Dante Alighieri scrive a Cangrande della Scala, a cui vuole dedicare l’opera. Invia quest’epistola una volta terminato il Paradiso, dedicandolo a Cangrande che gli ha dato la possibilità, ospitandolo, di portare a termine un’opera di tanta importanza. Dalla frase dell’epistola “qui inizia la comedia di Dante Alighieri fiorentino per natali ma non per costumi”, si pensò che Dante volesse attribuire al poema il titolo Commedia.Nel medioevo si considerava la commedia un genere basso ed umile, legato alla comicità, riguardante argomenti leggeri e i cui protagonisti fossero dei personaggi del volgo, ovvero del popolo. La parola “commedia”, deriva dal termine greco “comodia” che significa canto o corteo festoso in onore della divinità, spesso il dio del vino Dioniso (Bacco a Roma), per il quale venivano celebrati “riti orgiastici”.
La tragedia era contrapposta alla commedia. Dai greci veniva chiamata “tragodia” e l’origine è sconosciuta. Inizialmente si pensava avesse origine all’epoca degli antichi cori greci come deriva dal termine “tragos” cioè “capro”. Riprende questo nome perché i coreuti, coloro che cantavano, indossavano una maschera (caprina) o perché veniva dato in dono a coloro che partecipavano un capro.
Il genere della commedia venne codificato dai greci e indica ancora oggi un genere divertente, con personaggi comici e un finale lieto. Corrisponde a spettacoli leggeri con stile basso ed umile. La tragedia invece è un componimento molto più elevato e sublime, i cui personaggi non sono umili ma sono principi, regine, re e nobili. Gli argomenti poi sono importanti, il finale è tragico e lo stile è sublime ed elevato.
Secondo gli antichi greci e romani, infatti, ad argomenti elevati e sublimi doveva corrispondere un linguaggio elevato e sublime, così come per gli argomenti bassi ed umili doveva corrispondere uno stile umile e basso.
La Divina Commedia: la storia del titolo
Dante ritiene la materia del poema importante, anche con tratti drammatici, ma con un lieto fine che riporta quindi alla Commedia. L’aggettivo “Divina” fu in seguito attribuito da Boccaccio, nel trattato In lode di Dante. Boccaccio definisce l’opera “Divina” per la tematica, poiché tratta del viaggio di Dante e si conclude con la visione di Dio. Questo termine venne affidato all’opera anche per la bellezza poetica e l’altezza del significato. Nel 1555 verrà pubblicata la prima edizione dell’opera con l’attribuzione del titolo Divina Commedia.Sempre nel trattato In lode di Dante, Boccaccio ci comunica che il poeta, prima dell’esilio, avesse già scritto sette canti dell’inferno e in seguito, durante il suo periodo d’esilio, se li sarebbe fatti mandare e avrebbe proseguito l’opera. Quest’ipotesi però è poco accreditata, mentre si ritiene che Dante avesse iniziato a scrivere l’opera dopo l’esilio e che tra il 1307 e 1309 avesse già concluso la prima cantica dell’Inferno. Con certezza si sa che, durante l’ascesa di Enrico VII (1313), l’Inferno era già stato concluso. Dal 1318 e 1319 conclude il Purgatorio e infine dal 1319 fino al 1321 conclude il Paradiso.
I temi e il periodo storico: mappa per comprendere l’opera
Una mappa di comprensione del testo è sicuramente quella che guarda al periodo storico in cui Dante visse e alle sue idee politiche. Queste concezioni sono alla base del suo pensiero poetico e sono anche la causa scatenante della composizione dell’opera. Alla base del poema c’è, infatti, una visione di Dante del tutto pessimistica della realtà: il poeta era fortemente amareggiato a causa dell’esilio e della situazione politica dei Comuni italiani. Infatti, all’interno degli stessi comuni persistevano lotte interne tra schieramenti politici che si contendevano il dominio della città, i Guelfi e i Ghibellini e, a loro volta, lotte tra guelfi neri e bianchi. Si verificò quindi una completa assenza di pace, di cui la causa fu l'aver perso di vista il proprio obiettivo da parte della Chiesa e dell’Impero, che avrebbero dovuto porsi come guide spirituali e temporali dell’umanità. La Chiesa era troppo rivolta alle cose mondane, cercando di impossessarsi del potere temporale senza avere il compito e le capacità di gestirlo. Corrompendosi in tal modo, aveva abbandonato il suo scopo di condurre l’umanità verso la felicità ultraterrena. L’Impero, invece, si era disinteressato della tragica situazione, abbandonando la cura del popolo e preoccupandosi unicamente di ciò che accadeva in Germania. Così aveva dato la possibilità alla Chiesa di impossessarsi del potere che gli apparteneva. Queste due grandi istituzioni avevano quindi portato alla decadenza e provocato una grave confusione, coinvolgendo tutto il popolo. Dante poi vedeva condannava apertamente l’ascesa della borghesia mercantile, che definiva “gente nova” (in senso dispregiativo), a Firenze.Dante si sentì, quindi, investito di una missione importantissima ricevuta dalla grazia divina, sentendosi così un prescelto: il suo ruolo consisteva nel compimento di un viaggio ultraterreno, attraverso l’Inferno e il Purgatorio per essere infine ammesso in Paradiso, e per poi ritornare sulla Terra. Un volta sulla Terra, avrebbe avuto il compito di condividere questa sua esperienza con tutta l’umanità e redimerla quindi dal peccato. Dante ritiene quindi di essere caduto nel peccato (la selva oscura rappresenta il peccato) insieme a tutta l’umanità, e di avere una missione profetica.
Fonti d’ispirazione e modelli di riferimento di Dante
L'opera poi, presenta tutte le caratteristiche dei grandi poemi del passato, in particolare dell’Iliade, dell’Odissea e dell’Eneide (modello principe). Dante quindi adotta il metro dei precedenti, cioè l’esametro.Importante è la simbologia numerica persistente nel poema. L’opera infatti si divide in 3 cantiche (numero perfetto perché rappresenta la trinità), che allora volta si dividono in 33 canti (multipli di tre, altrettanto perfetti), tranne per la prima che ne ha 34, poiché il primo canto funge da proemio alle tre cantiche. Così arrivò a 99 canti + 1 (il proemio) e quindi 100 canti. Anche l’1 è simbolo di perfezione poiché rappresenta l’unità divina, visto che Dio è uno e trino. Egli scrive quindi il poema in terzine e utilizza la rima incatenata, che probabilmente riprende dai sonetti.
La tematica basilare dell’opera è il viaggio. Quest’ultima è una tematica ricorrente nella letteratura greca e latina. Anche questa tematica prende come modello di riferimento l’opera greca dell’Odissea, il viaggio di Ulisse di ritorno a Itaca. Ma, in questo caso, il viaggio di Dante scaturisce da una missione di salvataggio dell’umanità ordinatagli da Dio, e non intrapresa in nome del suo egoismo e individualismo, mentre il viaggio di Ulisse – che Dante collocherà tra i fraudolenti (cattivi consiglieri), nell’Inferno - è frutto del suo orgoglio personale e della presunzione di soddisfare la voglia di conoscenza e di superiorità rispetto gli altri. Il canto dedicato ad Ulisse è uno dei più famosi, dove si racconta come l’eroe con una “picciol orazione” (“fatti non fosse per viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza”), convinse i suoi uomini a superare le colonne di Ercole, e a spingersi dove nessun altro si era mai spinto, e dove si pensava terminasse il mondo. Il viaggio di Ulisse, viaggio per eccellenza dell’epoca antica, è compiuto per la sete di conoscenza e indica come l’uomo si differenzia dagli altri esseri per il fortissimo desiderio di conoscere, vedere e apprendere cose nuove.
Un altro dei modelli più importanti a cui Dante si rivolge è il viaggio di Enea nell’oltretomba (VI Libro dell'Eneide) raccontato da Virgilio.
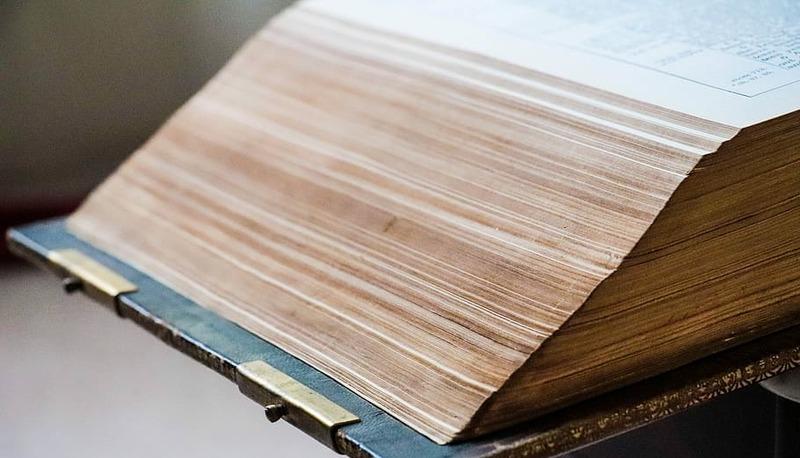
Anche San Paolo compì un viaggio nell’oltretomba ma, come Dante, lo fece per volere divino.
Le fonti e i modelli dell’opera, oltre ai poemi Omerici e al poema di Virgilio, sono le sacre scritture, soprattutto il libro dell’apocalisse e le lettere di San Paolo, e una serie di opere medievali come il Tesoretto di Brunetto Latini, i bestiari (riguardanti creature del regno animale) e i lapidari (riguardanti le pietre preziose).
Per ulteriori approfondimenti sulla Divina Commedia vedi anche qua.
Domande da interrogazione
- Qual è l'origine del titolo "Divina Commedia"?
- Quali sono le differenze tra commedia e tragedia nel contesto medievale?
- Come influisce il periodo storico sulla composizione della Divina Commedia?
- Quali sono le fonti d'ispirazione principali per Dante nella Divina Commedia?
- Qual è il significato del viaggio nella Divina Commedia?
Il titolo "Commedia" deriva da un'epistola di Dante a Cangrande della Scala, mentre l'aggettivo "Divina" fu aggiunto da Boccaccio per la tematica e la bellezza poetica dell'opera.
La commedia era considerata un genere basso e umile con un finale lieto, mentre la tragedia era elevata e sublime, con personaggi nobili e un finale tragico.
Il periodo storico di lotte politiche e l'esilio di Dante influenzano la sua visione pessimistica della realtà e la composizione dell'opera come missione profetica.
Le fonti principali includono l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, le sacre scritture, e opere medievali come il Tesoretto di Brunetto Latini.
Il viaggio rappresenta una missione di salvataggio dell'umanità ordinata da Dio, in contrasto con il viaggio di Ulisse, che è motivato dall'orgoglio e dalla sete di conoscenza.

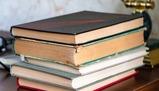





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo