Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
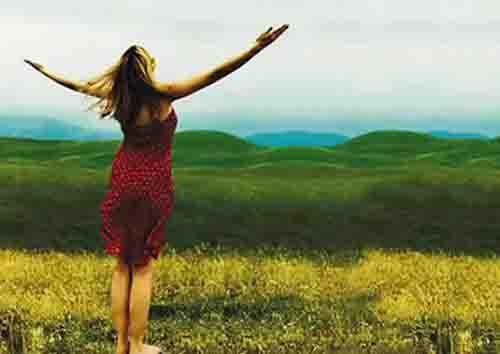
Sintesi Tesina sulla felicità
Nella tesina sulla felicità viene analizzato il tema della felicità. Nell'ambito mitologico Erodoto ricorda come alla domanda posta al re Creso su chi fosse l'uomo più felice del mondo, lui rispose che questi era Telbo, un ateniese che morì coraggiosamente in battaglia. Seguirono Cleobi e Bitone che morirono nel sonno in età giovanile. Nonostante fossero morti i tre uomini vissero una vita breve, ma felice e vissuta con pienezza. Con la morte di Cristo invece la concezione della felicità cambiò e veniva vista in legame al dolore, ovvero quello provato da Cristo sulla croce. La tesina mostra come nell'accezione filosofica antica invece Epicuro sosteneva che le persone compiono tutte le loro azioni con l'obiettivo di non soffrire e di non avere l’animo turbato. La felicità era quindi caratterizzarta dal piacere stabile e non in movimento, intesa come un vero e proprio “esercizio spirituale”. Un'altra concezione molto importante della felicità era quella elaborata da Seneca che affermava: "La felicità è un bene vicinissimo, alla portata di tutti: basta fermarsi e raccoglierla". Seneca criticava tutti coloro che si abbandonavano al piacere, senza fare un uso adeguato della propria ragione. Nell'accezione filosofica moderna era invece molto importante la concezione della felicità di Schopenhauer, che affermava come vi sia "un unico errore innato, ed è quello di credere che noi esistiamo per essere felici". Il filosofo sosteneva inoltre che la felicità la si poteva cogliere nell'attimo, intendeola come una temporanea cessazione del dolore. Schopenhauer quindi affermava come lo stato di felicità non poteva essere duraturo.
Collegamenti
Tesina sulla felicità
Mitologia: L'uomo più felice del mondo.
Filosofia: La felicità in Epicuro, Seneca e Schopenhauer.
Felicità - Alla ricerca della felicità- Tesina per il liceo socio pscico pedagogico sul tema della felicità.
Ricerca della Felicità (18846) - Tesina per liceo classico sulla ricerca della felicità.
Ricerca della felicità - Tesina di maturità che analizza la ricerca della felcità attraverso vari autori.
Ricerca della Felicità (23797)- Tesina sulla ricerca della felicità secondo varie accezioni.
Ricerca della Felicità (18990)- Tesina che affronta il tema della felicità attraverso Schopenhauer, Seneca, Primo Levi.
Ricerca della Felicità (19093) - Tesina che analizza la felicità sotto vari aspetti.
Ricerca della felicità nella storia e nelle arti
- Tesina per liceo scientifico che analizza il tema della felicità attraverso Apuleio, Nietzsche, Wilde.
Prodotto interno lordo o Felicità interna lorda? - Tesina che affronta il tema della felicità attraverso una critica al PIL.
La visione cristiana della felicità rimane fondamentalmente intatta per tutto il
Rinascimento e non si modifica nemmeno con l’Umanesimo.
Successivamente, con gli sviluppi scientifici delle tecniche produttive,
l’attenzione degli uomini torna a spostarsi sull’utilità personale e l’arricchimento.
Felicità diventa rapidamente il massimo del piacere con il minimo del dolore. Il
dolore, la forza d’animo, la virtù e l’equilibrio classico perdono interesse nella
visione della felicità in cui riemerge la capacità di accumulare ricchezze.
Un secolo dopo, in piena rivoluzione industriale, saranno i beni materiali ad
acquisire un grande potere nella vita degli uomini.
Con gli orrori della guerra, la crisi del Novecento e il divario tra occidente e
terzo mondo cambia nuovamente l’idea di felicità, che non può più provenire dalla
ricchezza economica, ma da quella affettiva, relazionale: è la capacità di mettersi in
gioco, raccontarsi, scambiarsi idee e opinioni.
Circa duemila anni dopo la disputa tra Creso e Solone si riscopre dunque che la
felicità non coincide con la ricchezza e che, come aveva dimostrato Gesù, non può
ignorare il dolore dell’altro. 3
La felicità è una condizione (emozione) fortemente positiva, percepita
soggettivamente, sempre secondo criteri soggettivi. L'etimologia fa derivare felicità
da: felicitas, deriv. felix-icis 'felice', la cui radice "fe-" significa abbondanza,
ricchezza, prosperità. La nozione di felicità, intesa come condizione (più o meno
stabile) di soddisfazione totale, occupa un posto di rilievo nelle dottrine morali
dell'antichità classica, tanto è vero che si usa indicarle come dottrine etiche
eudemonistiche (dal greco eudaimonìa) solitamente tradotto come "felicità".
4
LE ORIGINI
Quando gli esseri umani uscirono dalle tenebre della semplice animalità e
cominciarono a chiedersi e a darsi spiegazioni sul loro destino, cominciarono anche
ad abbozzare un quadro della possibile felicità. Per qualche secolo essi sostennero
che la felicità non dipendesse da loro, ma da una volontà superiore. Tutte le civiltà del
Mediterraneo, Asia Minore, Egitto, fino alla Persia e alla Mesopotamia, hanno la
stessa concezione fatalistica. Anche la Grecia ha della vita questa concezione tragica
e ineluttabile: sono gli Dei a decidere della nostra felicità o infelicità e, al di sopra
degli Dei stessi, il Fato. É però proprio in Grecia che comincia a farsi strada l’idea
che la felicità possa essere conquistata dall’uomo e che la sua azione, individuale e
collettiva, possa avvicinarlo a questa meta. È Socrate a porsi per primo “il problema
delle condizioni necessarie alla felicità”. Mentre gli altri pensatori dell’antichità si
concentrano sullo studio delle scienze naturali, e si interrogano sulla natura del
mondo e sulla possibilità di conoscerlo, Socrate si interessa all’etica e indaga il modo
migliore per vivere la nostra vita. Così comincia a parlare di felicità. Quando Socrate
parla di felicità non si riferisce al semplice edonismo: il suo ideale di felicità è più
alto, più nobile del semplice soddisfacimento dei nostri sensi e del godimento dei
nostri beni. Platone nel Simposio gli fa affermare che la felicità dipende da noi, ma
non va cercata nelle direzioni in cui uomini e donne si sentono spinti a cercarla dai
propri desideri mal controllati: il piacere, il potere, la ricchezza, la fama, persino gli
affetti familiari. Cioè l’effimero, ciò di cui approfittare al momento, nel mondo
tragico dominato da altre volontà che la nostra. Socrate predica la Filosofia,
sostenendo che solo un’anima ben ordinata e l’elevazione di Eros, il desiderio, può
avvicinarci alla nostra meta. Eros, che è a metà strada tra saggezza e follia, può essere
disciplinato e la sua forza può essere diretta verso il vero bene e la vera bellezza: la
norma morale custodita dentro di noi, il rispetto della nostra voce più autentica, la
disciplina del desiderio e l’ordine dell’anima portano felicità. E Platone ci propone di
ri-orientare i nostri desideri, per cambiare la parte più “pesante” ed opaca della nostra
natura umana. 5
Aristotele, invece, si pone in una posizione differente. Nell’Etica Nicomachea
afferma che ogni creatura persegue un suo fine: quello dell’uomo è coltivare la
facoltà che ci distingue da tutte le altre creature, cioè il ragionamento, e agire di
conseguenza. Essere un uomo buono significa vivere secondo la nostra particolare
virtù umana: la ragione. E l’uomo buono è un uomo felice.
La felicità è una “attività dell’anima conforme a virtù”. La virtù “è una vita seria e
non giocosa [...]. Chi opera in modo ponderato e coltiva questa attitudine non solo
conquista la miglior disposizione d’animo, ma è anche più amato dalla divinità [...].
E anche per questo motivo, dunque, il saggio è il più felice”. Egli rifiuta l’idea di
Socrate e Platone che la virtù sia sufficiente ad assicurare il raggiungimento del fine
ultimo della creatura umana. “Qualcuno potrebbe possedere la virtù ma soffrire i
peggiori dei mali e delle disgrazie del mondo. Costui non può essere felice”, dice
Aristotele. Una felicità sia pure approssimativa può consistere per Aristotele anche in
salute, sicurezza, piacere e prosperità, onori e riconoscimenti, buoni amici e buona
fortuna. Di questa felicità però non bisogna accontentarsi, l’uomo deve tendere ad
una felicità più completa, la sola che rappresenti lo scopo della sua presenza al
mondo. E chiunque, attraverso l’apprendimento e l’attenzione alla sua ragione, potrà
raggiungere questa felicità superiore. Tutti coloro che per loro natura siano mancanti
di ragione e quindi della capacità di usarne per raggiungere la virtù, non
raggiungeranno mai la vera felicità aristotelica. Tra questi privi di ragione per
Aristotele ci sono: gli schiavi, le donne, i bambini e coloro che sono privi dei mezzi
necessari per avere del tempo libero da dedicare alla riflessione, all’istruzione e
all’esercizio della loro ragione. Epicuro afferma invece che una filosofia che non
allontani le sofferenze dell’anima è come un medicamento inutile per il corpo. Gli
esseri umani sono responsabili della loro felicità, ma in accordo alla loro natura. È
questa la parola chiave: natura. A partire dalla sua concezione fisica radicalmente
materialistica Epicuro insiste sulla centralità del piacere, ponendosi in contrasto con
Socrate, Platone e Aristotele. Secondo Epicuro l’universo è composto interamente
dalla combinazione di materia e vuoto, atomi e nulla. Gli dei beati e immortali non si
6
occupano del mondo o dei suoi abitanti. Gli esseri umani sono semplici aggregati di
materia e le sensazioni sono la fonte d’ ogni esperienza e di conseguenza la fonte di
ogni bene e di ogni male. La dottrina epicurea é però una dottrina ascetica, che
comporta una precisa regolamentazione dei desideri. Il piacere di cui parla Epicuro
non è edonismo spiccio, ma ASSENZA DI DOLORE FISICO (aponia) e ASSENZA
DI ANGOSCIA O ANSIA MENTALE (atarassia). Questi sono i veri fini, non eccessi
di piacere o sottrazioni della coscienza. Epicuro lo dice esplicitamente nella Lettera a
Meneceo:
“Quando diciamo che il fine è il piacere, non parliamo del piacere degli
edonisti o dei sensuali, come pensano gli ignoranti(...), ma della libertà dal dolore
fisico e dalla sofferenza spirituale....”
Per Epicuro la felicità consiste nel piacere, che identifica, con un
rovesciamento di valori, nel bene primo, connaturato a noi stessi. L’uomo è quindi
felice secondo natura, a meno che non gli manchi qualcosa. Infatti il piacere è la
felice sensazione di pienezza che l’uomo prova naturalmente se non è limitato da
piaceri insoddisfatti. L’infelicità degli uomini deriva dal fatto che essi temono le cose
che non devono essere temute e desiderano ciò che non è necessario desiderare.
Anziché rappresentarci i mali prima di subirli dobbiamo concentrarci sui piaceri,
7
allontanando lo sguardo dalle cose dolorose. Noi compiamo tutte le nostre azioni,
secondo Epicuro, al fine di non soffrire e di non avere l’animo turbato. La felicità
consiste quindi nel piacere stabile e non in movimento ed è una sorta di “esercizio
spirituale”: contemplazione della natura, pensiero del piacere passato e presente e
infine amicizia, in cui si trova una serenità superiore anche a quella dell’amore,
poiché si può considerare libera da sentimenti che procurano dolore, quali la gelosia o
la paura di non essere ricambiati. Secondo Epicuro il piacere però non è sempre bene
in sé. Alcuni piaceri, infatti, possono turbare l’animo, o perché troppo violenti o per
la loro breve durata. Quindi è necessario scegliere, con l’ausilio della ragione, i
piaceri stabili, quelli facilmente raggiungibili, quelli che non provocano dolore futuro
e non privano di piaceri maggiori.
“Per questo noi riteniamo il piacere principio e fine della vita felice, perché lo
abbiamo riconosciuto bene primo e a noi congenito. A esso ci ispiriamo per ogni atto
di scelta o di rifiuto, e scegliamo ogni bene in base al sentimento del piacere e del
dolore. È bene primario e naturale per noi, per questo non scegliamo ogni piacere.
Talvolta conviene tralasciarne alcuni da cui può venirci più male che bene, e
giudicare alcune sofferenze preferibili ai piaceri stessi se un piacere più grande
possiamo provare dopo averle sopportate a lungo. Ogni piacere dunque è bene per
sua intima natura, ma noi non li scegliamo tutti. Allo stesso modo ogni dolore è
male, ma non tutti sono sempre da fuggire. Bisogna giudicare gli uni e gli altri in
base alla considerazione degli utili e dei danni. Certe volte sperimentiamo che il
bene si rivela per noi un male, invece il male un bene”
Epistola a Meneceo, 122-23, in Opere, Milano, Tea, 1991, p. 196
8
Il calcolo dei piaceri, in quanto soddisfacimento del bisogno, si basa su una
teoria dei bisogni, che si traducono in desideri.
“Bisogna anche considerare che dei desideri alcuni sono naturali, altri vani; e
tra quelli naturali alcuni sono anche necessari, altri naturali soltanto; tra quelli
necessari poi alcuni sono in vista della felicità, altri allo scopo di eliminare la
sofferenza fisica, altri ancora in vista della vita stessa. Una sicura conoscenza di essi
sa rapportare ogni atto di scelta o di rifiuto al fine della salute del corpo e della
tranquillità dell’anima, dal momento che questo è il fine della vita beata; è in vista di
ciò che compiamo le nostre azioni allo scopo di sopprimere sofferenze e
perturbazioni” Epistola a Meneceo, 127-28
I desideri veramente necessari sono estremamente limitati (la felicità richiede
poche cose): cibi e bevande frugali, un rifugio e un minimo di sicurezza. “Colui che
non è soddisfatto di poco non è soddisfatto di nulla”. Egli distingue inoltre i piaceri
naturali e quelli non naturali. Tra i primi, alcuni sono necessari, come il mangiare e il
bere. Questi dovranno necessariamente essere soddisfatti, per evitare la sofferenza e
la morte. I bisogni naturali, ma non necessari sono, ad esempio, mangiare cibi
raffinati o bere bevande piacevoli. Esistono infine i bisogni né naturali, né necessari,
come il desiderio di gloria o di ricchezza. Da essi bisogna guardarsi, perché sono la
fonte principale del turbamento dell’anima.
“Una ferma conoscenza dei desideri fa ricondurre ogni scelta o rifiuto al
benessere del corpo e alla perfetta serenità dell'animo, perché questo è il compito
della vita felice, a questo noi indirizziamo ogni nostra azione, al fine di allontanarci
dalla sofferenza e dall'ansia.
Una volta raggiunto questo stato ogni bufera interna cessa, perché il nostro
organismo vitale non è più bisognoso di alcuna cosa, altro non deve cercare per il
9
bene dell'animo e del corpo. Infatti proviamo bisogno del piacere quando soffriamo
per la mancanza di esso. Quando invece non soffriamo non ne abbiamo bisogno”.
Epistola a Meneceo
Il compito dell’insegnamento filosofico di Epicuro è quello di addestrare a








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









