Concetti Chiave
- Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo, subisce una crisi d'identità dopo che sua moglie gli fa notare un difetto fisico, portandolo a riflettere sulla sua immagine agli occhi degli altri.
- La storia esplora il tema della molteplicità dell'identità umana, con Moscarda che si rende conto di essere percepito in modi diversi dalle persone che lo circondano, conducendo a una ricerca di autenticità.
- Le azioni inusuali di Moscarda, come liquidare la banca ereditata e donare beni ai poveri, sono tentativi di distruggere le false immagini di sé e trovare la propria vera identità.
- Il romanzo rappresenta una critica alla società e ai suoi stereotipi, mostrando come le convenzioni sociali creino maschere che soffocano la vera natura individuale.
- La narrazione introspezione del romanzo e l'uso di soliloqui sottolineano la frustrazione del protagonista con la realtà frammentata e le sue riflessioni esistenziali sulla vita e l'identità.
In questo appunto viene descritto il celebre romanzo di Luigi Pirandello dal titolo Uno, Nessuno, centomila è un romanzo molto conosciuto e tra i più famosi dello scrittore siciliano Luigi Pirandello, in cui si racconta la storia del protagonista principali, Vitangelo Mosca, un ricco ereditiere di un banchiere. Il nodo cruciale del romanzo si ritrova in particolare modo nell'osservazione che la moglie fa a Vitangelo Mosca, ovvero che anche lui avrebbe un difetto fisico: il suo naso infatti penderebbe leggermente verso destra e lui non se ne sarebbe mai reso conto nel corso degli anni. Questo aspetto messo in risalto con una semplice frase della moglie diventerà per il Mosca una fissazione ai limiti dell'ossessione, spingendolo a compiere gesti che prima di allora non aveva mai compiuto, in modo tale quindi da cambiare l'opinione che la gente sta avendo su di lui. La sua vita cambia improvvisamente, avendo ripercussioni sul rapporto tra il protagonista e la moglie e sui suoi affari familiari. Vitangelo sta precipitando nella follia. Questo romanzo di Pirandello rappresenta in maniera molto abile la crisi d'identità dell'uomo del Novecento, il quale rasenta i limiti della follia.
Indice
- Uno, Nessuno, centomila, recensione
- Uno, Nessuno, centomila, riassunto
- Uno, Nessuno, centomila, trama
- Uno, Nessuno, centomila, analisi
- Uno, Nessuno, centomila, spiegazione
- Storia di Uno, Nessuno, centomila
- Uno, Nessuno, centomila, descrizione
- Sintesi di Uno, Nessuno, centomila
- Uno, Nessuno, centomila, commento
- Uno, Nessuno, centomila di Pirandello
- Il punto sull'autore: Pirandello
Uno, Nessuno, centomila, recensione
Il libro Uno, Nessuno, Centomila ha come protagonista Vitangelo Moscarda, detto Gengè, è un uomo benestante che abita nel piccolo paesino di Richieri.Una mattina sua moglie Dida gli fa notare un suo piccolo difetto: Vitangelo ha il naso che pende leggermente verso destra.
 Viene così a conoscenza di altre sue piccole imperfezioni e capisce che, dei piccoli difetti, ignorati da lui stesso, erano invece familiari a chi gli stava intorno. Moscarda si rende allora conto di non essere più lui, ma un altro, anzi, uno per ogni persona che incontra e per ogni azione che compie.
Viene così a conoscenza di altre sue piccole imperfezioni e capisce che, dei piccoli difetti, ignorati da lui stesso, erano invece familiari a chi gli stava intorno. Moscarda si rende allora conto di non essere più lui, ma un altro, anzi, uno per ogni persona che incontra e per ogni azione che compie.In un crescente bisogno di autenticità, Vitangelo compie atti del tutto inusuali agli occhi di chi lo conosceva prima della crisi: sfratta una famiglia per poi regalarle un appartamento nuovo; decide di liquidare la banca ereditata dal padre per riavere indietro i suoi risparmi; esplode improvvisamente dall’ira, pronunciando strani discorsi, sino a sembrare matto, tanto da far fuggire sua moglie e rischiare di venire interdetto.
Un’amica della moglie, Annarosa, lo avvisa delle pratiche in corso, attuate dalla stessa Dida e da altri suoi amici, per farlo rinchiudere in manicomio.
Per difendersi da questo complotto, Vitangelo diventa amico di Annarosa e, spinto dal desiderio di avere qualcuno con cui confidarsi, le svela le conclusioni che ha tratto dalla sua vita. Anch’ella, donna buona ma troppo semplice per capire l’animo di Moscarda, ne rimane talmente sconvolta da tentare di ucciderlo.
Vitangelo troverà pace solo dopo essersi rivolto al vescovo Mons. Partanna, il quale gli consiglia di donare tutti i suoi beni ai poveri.
Moscarda finirà i suoi giorni in un ospizio per i poveri, fondato da lui stesso, paradossalmente più felice di prima, nel tentativo di liberarsi di quell’Uno e di quei Centomila, allo scopo di diventare, per tutti e per se stesso, Nessuno.
Ambienti e luoghi della narrazione: La vicenda raccontata nel romanzo Uno, Nessuno, Centomila si svolge a Richieri, che probabilmente è un piccolo paese della Sicilia,regione natale di Pirandello, ma del quale non si può accertare l’esistenza. La scelta di quest’ambientazione così ambigua è giustificabile perché ha lo scopo di accentuare il fatto che il romanzo vuole parlare di una condizione generale diffusa in ogni tempo e in ogni luogo.
Personaggi di Uno, nessuno e centomila di Pirandello: Vitangelo Moscarda: detto Gengè, è il protagonista della vicenda. La sua caratteristica è proprio la sua aspirazione a non essere richiudibile in schemi. E’ un personaggio dinamico e a tutto tondo. E’ interessato all’assurdità delle cose più che alla loro situazione oggettiva e cerca di penetrare nei suoi centomila spetti diversi. Ma quando si accorge che nessuno può essere lo stesso per tutti e che è impossibile capirsi e perfino conoscersi, trova la soluzione nel diventare Nessuno.
Dida: moglie di Vitangelo; è colei che dà inizio alla storia facendo notare a suo marito i suoi difetti. A parte questo, non è un personaggio di rilevante importanza nel racconto.
Marco Didio: artista che Vitangelo decide di sfrattare da una catapecchia di sua proprietà per togliersi la maschera di usuraio che si era creato con la pretesa di partecipare attivamente alla gestione della banca. E’ un personaggio dinamico e a tutto tondo; Pirandello ironizza sull’arte mediocre di Marco Didio, la quale è il simbolo dell’arte contemporanea che lo scrittore reputa inutile e fittizia.
Annarosa: amica della moglie di Vitangelo; è una donna eterea, semplice e buona che aiuta Vitangelo, il quale le confida tutte le conclusioni della sua vita, poiché sente bisogno di autenticità. E’ un personaggio dinamico e a tutto tondo che emerge in una seconda parte del libro.
Vescovo Monsignor Partanna e il Canonico Sclepis: clericali che consigliano a Vitangelo di donare tutti i suoi beni ai poveri. Sono dei personaggi secondari in quanto compaiono solo alla fine del racconto per chiudere il romanzo.
Amici di Moscarda: uomini che gestiscono la banca che quest’ultimo ha ereditato dal padre; sono dei personaggi secondari.
Fabula e Intreccio: Il libro Uno, Nessuno e Centomila può essere diviso in due parti:
- In una prima parte il romanzo ha una trama molto povera che è caratterizzata dal rovello interiore di Vitangelo. I pensieri del protagonista vengono trasmessi con continui soliloqui;
- In una seconda parte, la trama si arricchisce, la fabula coincide con l’intreccio, ma continuano tuttavia ad esserci pause e riflessioni.
- In una prima parte l’unico punto di vista riportato è quello di Vitangelo, i cui pensieri sono contenuti nei soliloqui (focalizzazione interna fissa);
- In una seconda parte viene adottata una focalizzazione interna multipla perché Mostarda viene a conoscenza del fatto che non tutti hanno la stessa opinione su di lui.
- Vitangelo Moscarda: è il protagonista e allo stesso tempo in narratore, che parla di sé.
- Dida: moglie di Vitangelo; secondo Vitangelo Dida non ama lui, ma un’immagine di lui che si è creata e che affettuosamente chiama “Gengè”.
- Francesco Antonio Moscarda: padre di Vitangelo, compare nel racconto solo sotto forma di ricordo; è stato lui a lasciare in eredità al figlio il nome di “usuraio”.
- Firbo e Quantorzo: amici di Vitangelo, guidano e fanno prosperare la banca di cui è proprietario; approfittano dell’indifferenza di Vitangelo per condurre i propri affari.
- Marco di Dio: povero un po’ matto, che crede che si arricchirà con le sue invenzioni; vive abusivamente in una delle proprietà di Vitangelo. Vitangelo prima lo sfratterà, poi gli darà in dono la casa.
- Diamante: moglie di Marco di Dio.
- Notaro Stampa: notaio di cui si avvale Vitangelo per sfrattare e poi donare la casa a Marco di Dio.
- Anna Rosa: amica di Dida, è convinta che Vitangelo sia innamorato di lei e, sparando per caso un colpo con la sua rivoltella, per poco non gli causa la morte.
Punto di vista della narrazione e il Narratore in Uno, Nessuno, Centomila di Pirandello
Anche per questa analisi il romanzo Uno, Nessuno e Centomila può essere diviso in due parti:
Tempo della scrittura e dell’avventura: Il tempo della vicenda è indefinito perché, proprio come l’ambientazione del libro, simboleggia l’attualità nel tempo della situazione di Moscarda.
Inoltre nella prima parte del romanzo il tempo dell’avventura è minimo perché sono presenti numerose analisi; in alcuni momenti, il rallentamento arriva fino all’arresro della storia e si hanno, quindi, delle pause.
Messaggio del libro e riflessioni personali: Lo scopo del romanzo è mettere in evidenza gli stereotipi e gli schemi che ci vengono imposti dalla società; Moscarda sente il bisogno di autenticità proprio perché si rende conto che la sua vita è impregnata dalla casualità:
“(…) vi sentii dentro tutto lo sgomento delle necessità cieche, delle cose che non si possono mutare: la prigione del tempo, il nascere ora, e non prima e non poi,; il nome e il corpo che ci è dato; la catena delle cause; il seme gettato da quell’uomo: mio padre senza volerlo; il mio venire al mondo dal quel seme, frutto involontario di quell’uomo, legato a quel ramo e espresso da quelle radici (…)”.
Pirandello vuole far capire al lettore in Uno, Nessuno, Centomila che i corpi delle persone sono animati dalle forme che ci impone la società; ognuno di noi è quindi un corpo mortificato che assume continui aspetti diversi a seconda del punto di vista di chi lo anima.
Lo scrittore ha saputo trasmettere con grande abilità i sentimenti del protagonista, destabilizzato da questa nuova realtà che scopre casualmente con degli “atti gratuiti”.
Inoltre ho apprezzatoli libro perché il suo contenuto spinge a riflettere; infatti espone una situazione sempre attuale che, quindi, interessa anche gli uomini d’oggi.
Mi è piaciuta particolarmente la conclusione del romanzo; infatti Vitangelo ha sperimentato il vuoto e decide di accettare la condizione di “personaggio fuori”: “vive non vivendo”; cerca di convivere con il suo nessuno, rifiutando anche il proprio nome; il suo ideale diviene abbandonarsi al flusso della vita, accetta di non essere.
Uno, Nessuno, centomila, riassunto
Scheda bibliografica: “Uno, nessuno e centomila” è un romanzo psicologico di Luigi Pirandello edito inizialmente a puntate nella rivista “Fiera letteraria” nel 1926 e ristampato dalla casa editrice “Biblioteca ideale Giunti” nel 2011 in un edizione che conta 188 pagine includendo anche l'introduzione all'autore e quella al libro di Rita Guerricchio, la storia è divisa in otto libri, segmentati a loro volta in diversi capitoli, numerati e titolati.
La narrazione: Il protagonista è Vitangelo Moscarda, figlio di un banchiere di Richieri che gli ha lasciato in eredità la sua banca grazie alla quale permette a Vitangelo di vivere di rendita senza nemmeno lavorarvi poiché, gli affari, vengono amministrati da Firbo e Quantorzo, ex collaboratori del padre. Un giorno, in seguito all'appunto della moglie che gli fa notare quanto il suo naso penda verso destra, nasce in lui una crisi d'identità che lo porta a rendersi conto di come sia diversa l'immagine che gli altri hanno di lui rispetto a quella che lui ha di sé stesso. Da quel momento l'obiettivo per Vitangelo è dunque quello di scoprire chi è veramente lui e di distruggere i Vitangelo altrui cioè le idee erronee che gli altri hanno di lui. Decide dunque di provare a estinguere la fama di usuraio che lo caratterizza tra la gente regalando una delle sue case e un ingente somma di denaro a Marco di Dio e la moglie che da tempo non riuscivano a pagare l'affitto. Questo gesto però non fece altro che alimentare voci sulla sua pazzia oltre che mandare su tutte le furie Firbo e Quantorzo poiché aveva rischiato la rovina economica e il fallimento della banca. Successivamente Vitangelo decide di liberarsi dello stesso istituto bancario facendo crollare così
l'innocente Gengè della moglie (cioè l'alter ego che quella gli aveva affibbiato) e lo sciocco incapace “caro Vitangelo” che apparteneva alle idee di Quantorzo. La moglie scappa di casa e, insieme ad altre persone, inizia un'azione legale contro Vitangelo forti dell'idea di pazzia che pendeva sulla sua testa e che gli ultimi eventi avevano aggravato. Solo un'amica della moglie, Anna Rosa, rimane dalla parte del malcapitato che però si ritrova vittima dei colpi di pistola della sua stessa alleata, spaventata dai ragionamenti suoi ragionamenti sulle mille personalità di ognuno. Vitangelo sembra trovar tregua ai suoi pentimenti solo nel conforto di Monsignor Pantanna che gli consiglia di rinunciare ai suoi beni in favore dei meno fortunati. L'uomo si rifugia dunque nell'ospizio che egli stesso ha donato alla città dove può ritrovare la serenità a contatto con la natura e lontano dalle mille maschere che gli altri gli hanno imposto.
Tempo e spazio: La storia si sviluppa interamente in uno spazio reale entro le mura della città di Richieri in un epoca non ben definita, nello spazio di qualche anno seguendo l'ordine cronologico degli avvenimenti. Grazie all'uso dei sommari il tempo del racconto è inferiore rispetto a quello della storia che però si ferma quando vengono presentate le riflessioni di Vitangelo mediante l'uso dello stratagemma narrativo della pausa, inoltre è presente l'uso delle scene (dove il tempo del racconto e uguale a quello della storia) per presentare le parti narrate e quelle dialogate. Oltre a ciò bisogna dire che sono presenti anticipazioni e retrospezioni che denotano la non coincidenza fra fabula e intreccio.
Personaggi: Il personaggio su cui si impernia la vicenda è Vitangelo Moscarda, giovane sulla trentina, appartenente alla media borghesia cittadina che, all'interno della storia rappresenta un personaggio a tutto tondo e dinamico poiché passa dalla tranquillità iniziale al tormento psicologico che caratterizza il libro. Pirandello lo descrive come un uomo non molto alto con i capelli rossicci e gli occhi verdastri caratterizzato da dei baffi anch'essi rubicondi nonché da un naso aquilino leggermente pendente verso destra e da altri difetti ravvisabili in una gamba più arcuata dell'altra e nelle sue mani non proprio perfette. Sotto il profilo psicologico Vitangelo ci appare come un personaggio di rara complessità poiché egli manifesta uno sconvolgimento interiore fuori dal comune che ha la sua genesi nel riconoscimento, da parte del personaggio stesso, di non essere “uno” come egli credeva bensì “nessuno”, poiché, nel rapporto con gli altri, assumeva le sembianze di “centomila” diversi Vitangelo. Dalla presa coscienza di ciò egli diventa schiavo del proprio pensiero e volge la sua vita all'“eliminazione” dei suoi alter ego e alla ricerca di un'identità personale assoluta che lo liberasse dalla sua percezione di subordinazione rispetto agli altri ravvisabile nella similitudine con cui Vitangelo, durante una riflessione, si riferisce a sé stesso: “come un cieco davo il mio corpo in mano agli altri”.
Altro personaggio che da subito riveste un ruolo importante è Dida, la moglie di Vitangelo che era solita chiamare suo marito Gengè, appellativo che identificava una visione dell'uomo come di un individuo ingenuo e tutt'altro che scaltro. Anch'ella si figura come un personaggio dinamico poichè trasforma l'apatia iniziale dimostrata nei confronti di Vitangelo in avversione quando si tratta di salvaguardare i propri interessi economici.
Di rilievo è anche il ruolo di Quantorzo, personaggio pratico e materialista, anch'egli appartenente alla borghesia cittadina in quanto banchiere che, all'interno della vicenda, figura dapprima come comparsa e poi si trasforma, insieme a Dida, al padre di lei e al suo collega Firbo, in un antagonista sviluppando lo stesso tipo d'avversione scaturita da interessi economici che caratterizza ogni personaggio nominato poc'anzi.
Verso la fine del romanzo entra in scena Anna Rosa, zitella venticinquenne amica di Dida e alleata di Vitangelo nel momento della solitudine dovuta alle accuse di pazzia. E' affascinata dalle scoperte di Gengè ma allo stesso tempo ne è impaurita perché ne riconosce la validità. Lo spavento la porta a sparare a Vitangelo e a prendere le caratteristiche del personaggio dinamico poiché cade, nel momento dell'aggressione, la tranquillità che l'aveva caratterizzata.
Narratore: Gli interventi dell'autore nella narrazione sono assenti, il narratore è interno e coincide col protagonista della vicenda che parla in prima persona e non si può considerare onnisciente poiché non guarda nella mente degli altri personaggi e non può dunque conoscerne il pensiero e le idee.
Tecniche narrative, usi linguistici e stilistici: viene utilizzato un registro linguistico medio che non esclude però né vocaboli prestati dalla lingua parlata né espressioni abbastanza ricercate. Le sequenze riflessive abbinate allo stratagemma narrativo del monologo interiore preponderano in tutto il romanzo ma non mancano parti narrative e descrittive così come i dialoghi fra personaggi. La struttura sintattica è prevalentemente ipotattica e ciò ben sta con la con la complessità generale ravvisabile nel romanzo.
Temi: Il tema fondamentale è essenzialmente uno ed è racchiuso in una frase del settimo libro dove si capisce anche la vera e profonda origine del dissesto psicologico di Vitangelo; egli si rivolge ad Anna Rosa con queste parole: “Lei non può conoscersi che atteggiata: statua: non viva. Quando uno vive, vive e non si vede. Conoscersi è morire”. Da queste parole possiamo evincere dunque l'impossibilità di ognuno di conoscere il proprio “io” interiore che è l'argomento principale sviluppato lungo tutto il romanzo. Il problema sollevato dallo stesso Vitangelo non è altro che il culmine dei suoi ragionamenti che si dipartono dalla presa coscienza della pluralità dell'“io”. Ciò avviene a seguito del tentativo di individuare una propria identità, cosa che lo pone davanti a tre domande: Chi siamo? Cosa crediamo di essere? Cosa siamo per gli altri? Su queste basi inizia la ricerca dell'“io”, altro tema fondamentale del romanzo. Entrambe queste questioni si possono configurare come attuali poiché l'io è da sempre argomento centrale delle riflessioni dell'uomo e attorno ad esso ruotano i grandi interrogativi che l'umanità si è posta già dalle sue origini.
Messaggi e contesto: Lo scopo del romanzo è dimostrare quanto la vita di ognuno sia stereotipata e vittima del giudizio degli altri che la privano di un'autenticità intesa come l'identità unica e personale di ognuno. Il libro vuole mettere in risalto anche la casualità della vita che si esprime nelle parole di Vitangelo: “vi sentii dentro tutto lo sgomento delle necessità cieche, delle cose che non si possono mutare: la prigione del tempo, il nascere ora,e non prima e non poi; il nome e il corpo che ci è dato; la catena delle cause; il seme gettato da quell’uomo:mio padre senza volerlo;il mio venire al mondo dal quel seme, frutto involontario di quell’uomo, legato a quel ramo e espresso da quelle radici”. La visione del mondo di Pirandello risentì in maniera profonda della crisi del Positivismo e nacque sia dall’analisi della società contemporanea, che egli andò sviluppando in maniera autonoma, sia dalla lettura delle opere di Henry Bergson, Georg Simmel e di Alfred Binet (filosofi) dai quali prese la dottrina dello slancio vitale e cioè la visione della vita come di un perpetuo divenire.
Giudizi: Il libro Uno, nessuno centomila non è di immediata comprensione vista la sua complessità dovuta alla tematica psicologica e alla ricchezza di riflessioni, praticamente onnipresenti nel libro. D'altro canto è doveroso far riferimento alla straordinaria attualità degli argomenti trattati che lo rendono interessante e fonte di riflessioni. L'aria di novità che aleggiava intorno al romanzo al tempo della sua uscita è il propulsore del suo successo e della sua accettazione tra le file della borghesia nonché della successiva affermazione a livello internazionale.
Uno, Nessuno, centomila, trama
Titolo: "Uno, nessuno e centomila"
Autore: Luigi Pirandello
Argomento come tema fondamentale: La presa di coscienza della prigionia delle "forme", la rivolta e la distruzione delle forme: la pazzia; sconfitta e guarigione; lo specchio.
Riassunto in breve: Tutto parte quando Vitangelo è di fronte allo specchio e la moglie Dida gli fa notare che gli pende il naso a destra; così si “squarcia il teatrino”, si trova inserito nel gioco delle maschere. Non riconosce più se stesso, né suoi amici, né la moglie, né la sua condizione.
Vitangelo è il prototipo dell’inetto, non ha mai fatto nulla, vive di rendita perché il padre aveva una banca, che lui formalmente manda avanti, ma di cui se ne occupano la moglie e degli “amici” che sono i direttori e che se ne approfittano.
Personaggi principali: il protagonista assoluto di questo romanzo è Vitangelo Mostarda. Interessante è la descrizione che Vitangelo si fa guardandosi allo specchio. Ma non credo che l’autore abbia voluto soffermarsi particolarmente sul ritratto fisico del protagonista anche perché nella descrizione emergono tratti irrilevanti dell’aspetto, anche se la "crisi" di Vitangelo scoppia con la presa di coscienza di un difetto fisico la sua mente che ci interessa e che viene accuratamente scrutata e vediamo che il protagonista si arrovella, perde il sonno pur di trovare una risposta ai suoi quesiti, per vedere in definitiva più chiaro. Bisogna per Vitangelo vivere di attimo in attimo, in perenne mutazione, e ciò è una condizione esaltante, gioiosa. Spesso ho come avuto la sensazione che Vitangelo non fosse un vero personaggio, ma una sorta di voce della coscienza che ha il compito di redarguirci e di farci capire la realtà delle cose e, anche in quest’ambito, non risultano importanti le vicende in cui il protagonista è coinvolto quanto ciò che ci dice e ciò che vuole comunicare.
Personaggi secondari: La moglie d Dida, Il padre di Dida, Anna Rosa, un’amica di Dida, Firbo e Quintorzo, La folla, Monsignor Partanna
Luogo in cui si svolge l'azione: gli avvenimenti si svolgono nella nobile città inventata di Richieri e si articolano in ambienti sia interni che esterni: la casa del protagonista, la banca, le vie della città, la Badia Grande; di questi luoghi l’autore ci fornisce particolari descrizioni; l’ambiente che prevale è cittadino, e la folla è importante perché alimenta le dicerie sulla pazzia di Vitangelo, che si sente continuamente osservato e giudicato da tutti come un usuraio. I luoghi sono presentati dal punto di vista del protagonista.
Tempo in cui si svolge l'azione: fabula e intreccio sostanzialmente coincidono perché gli avvenimenti seguono l’ordine cronologico. Sono presenti alcune digressioni, incisi filosofici, anticipazioni; il romanzo è ambientato nei primi anni del novecento. Il tempo della storia è sicuramente minore rispetto al tempo del racconto.
Riflessioni personali: personalmente ho trovato questo libro molto interessante, gli argomenti trattati sono abbastanza attuali e anche curioso per il metodo stilistico utilizzato da Pirandello, anche se in alcune parti, soprattutto gli esempi filosofici, erano piuttosto complicati da comprendere.
per ulteriori approfondimenti su Uno, Nessuno, centomila vedi anche qua
Uno, Nessuno, centomila, analisi
Vitangelo Moscarda scopre un giorno come l'immagine che lui ha di se stesso sia diversa da quella che gli altri hanno di lui, come egli sia, contemporaneamente, uno, nessuno e centomila Moscarda. Meta del libro è una speculazione su questo tema, mentre la restante parte è il racconto del conseguente sgretolamento della personalità di Moscarda, a cominciare dalla decisione di chiudere la banca paterna per non essere più un usuraio agli occhi degli altri sino alla miseria (in ospizio) ed al processo per tentata violenza ad un'amica della moglie. La prima parte si dilunga troppo su un tema banale, quasi adolescenziale, mentre la seconda è del tutto immotivata ed improbabile.
Uno, Nessuno, centomila, spiegazione
"Uno, Nessuno e Centomila" è una narrazione retrospettiva condotta da una prima persona che è nello stesso tempo voce narrante e protagonista della vicenda.Il romanzo narra la storia di un uomo, Vitangelo Moscarda, detto Gengè, figlio di un ricco usuraio, tranquillo provinciale, che grazie all'osservazione della bella e fatua moglie Dida sul suo naso che "pende verso destra" mentre egli si guarda allo specchio, si accorge per la prima volta che la sua vita banale e senza veri ideali né responsabilità, non ha una "forma fissa" neanche nel suo aspetto fisico. Egli propone quindi a se stesso "sette comandamenti"per tentare di scoprire il suo vero io,basati sulle riflessioni chiave che Vitangelo esprime e sono la spiegazione concreta della tragedia del personaggio. Tra queste le più importanti sono:il sentirsi diverso da quello che aveva creduto di essere fino ad allora e il non potersi veder vivere. Vitangelo Moscarda è un uomo inetto, impossibilitato a realizzare la propria identità e non si ama. Si è sposato per convenzione, si ribella contro il padre e contro l'amministratore Quantorzo che ne è un "fax-simile". Al mondo che lo circonda egli si ribella in maniera attiva, come è provato dal furto degli incartamenti di una casa da cui vuole sfrattare l'inquilino. Incolpa il padre perché, come lui, era divenuto un usuraio, spiegando:"Vivevo come un cieco nelle condizioni in cui ero stato messo, senza considerare quali fossero, perché in esse ero nato e cresciuto e m'erano perciò naturali". Questa, dunque, non è altro che un'ulteriore dimostrazione, assieme a quella del furto, che Vitangelo Moscarda è un esemplare personaggio dei primi del '900 che prova, cioè, rigetto nella figura paterna fino a desiderarne l'omicidio. Non più usuraio;non più Gengè; questi erano i suoi scopi principali.
E li raggiunge liquidando la banca e divenendo un estraneo per la moglie. Finalmente era quello che voleva lui. Il famoso sentimento del contrario si configura anche in quest'ultima opera pirandelliana tant'è che Moscarda finisce col beneficare l'inquilino che ha precedentemente sfrattato e, ferito da Anna Rosa, ne sostiene la difesa presentandosi in tribunale con la divisa dell'ospizio costruito coi propri soldi.Siamo passati, così, attraverso i tre momenti riassunti dal titolo: Moscarda è stato "uno"(l'unicità della persona)cercando di darsi una collocazione convenzionale sociale in cui si riflettono i "centomila"aspetti della massa e finisce col diventare "nessuno" annullandosi per vivere senza identità, adottando una delle sole due soluzioni dell'uomo pirandelliano: la pazzia.
Così, beandosi di non aver più coscienza d'essere, di rinascere attimo per attimo ,come una pietra, un albero o una pianta, sdraiato sull'erba a contemplare le nuvole e il vento riuscendo, finalmente, ad acquietare "in lucida follia"il suo tormentoso pensare.
per ulteriori approfondimenti sul romanzo di Luigi Pirandello vedi anche qua
Storia di Uno, Nessuno, centomila
Il romanzo pirandelliano rispecchia fedelmente la psicologia dell’autore presentandola nel tema principale: la frantumazione dell’io, la follia, l’inettitudine e lo smarrimento. Il protagonista, Vitangelo Moscarda, ha una posizione assoluta nella narrazione. I suoi pensieri e riflessioni sovrastano le vicende e le rallentano. Il romanzo è quindi principalmente un romanzo introspettivo, psicologico. Nonostante ciò, lo stile è scorrevole e il linguaggio semplice. La trama è invece piuttosto complicata, soprattutto nella seconda parte, simbolo della crescente crisi interiore di Vitangelo, che si sente sempre più smarrito e frantumato. Ciò che colpisce è la costanza del sarcasmo e dell’ironia utilizzati da Pirandello, che aiutano ad evidenziare la frantumazione dell’interiorità di Vitangelo. Il protagonista, Vitangelo Moscarda, entra in crisi quando gli viene fatto notare dalla moglie di avere il naso diverso da come lui se lo vedeva: questa banale constatazione lo porterà gradualmente alla pazzia.Questo romanzo mette in evidenza quindi come noi ci vediamo e come gli altri ci vedono, non solo esteriormente ma anche interiormente. Ciascuno non è uno, ma centomila, tante quante sono le immagini che gli altri si fanno di lui. Non esiste un io autentico e oggettivo. Scoprire di non essere per gli altri quell’Uno che crede di essere accende in lui il desiderio di distruggere queste forme a lui estranee per scoprire il vero sé. Tenta di distruggere le errate convinzioni della gente, a cominciare da quelle della moglie.Come tutti i personaggi di Pirandello, anche Vitangelo è un perdente, un inetto, tuttavia egli si adatta alla sconfitta finale e accetta di vivere in un’alienazione perenne da sé stesso, rifiuta la propria identità e il proprio nome, mentre inizialmente la consapevolezza di una realtà frammentata in centomila realtà soggettive lo aveva messo in un’angoscia insopportabile: perfino la moglie lo chiamava Gengé, un soprannome simbolo della maschera che portava quotidianamente.
Personalmente ho trovato il romanzo particolarmente interessante per quanto riguarda le tematiche che rivelano una grande capacità di analisi interiore dell’autore, capace anche di trasmetterle attraverso lo stile narrativo, il che è un grande pregio. Tuttavia la narrazione può risultare spesso pesante e rallentata, quindi di difficile lettura. Confrontando il personaggio di Vitangelo con Mattia Pascal, credo che la differenza stia nel fatto che Mattia Pascal fugge dalla realtà in cui vive perché sente in prima persona di non riuscire più a sopportarne la maschera; Vitangelo, invece, vive molto bene nelle sue condizioni: è ricco e non ha bisogno di lavorare. Sono gli altri, infatti, che lo portano a rendersi conto di quanto la sua concezione della realtà non sia la sola oggettiva, ma che si trova a far parte di un mondo ormai sempre più relativo e ostile. Entrambi i personaggi, alla fine del romanzo, accettano le convenzioni sociali e tornano a vivere la propria vita: è la sconfitta degli inetti.
per approfondimenti sulla storia di Uno, Nessuno, centomila vedi anche qua
Uno, Nessuno, centomila, descrizione
Personaggi:
Analisi del romanzo: Si tratta di un monologo narrativo, in cui l’autore, facendo parlare in prima persona Vitangelo, non mira alla descrizione oggettiva della realtà, ma all’analisi dei sentimenti e delle riflessioni del proprio personaggio, attraverso forme stilistiche che spaziano dal romanzo filosofico (soprattutto nei libri I e II del romanzo, quando il protagonista espone e cerca di dimostrare le proprie tesi) al romanzo d’introspezione (in particolare quando Vitangelo analizza lucidamente l’evolversi della sua follia). Inoltre, la narrazione in prima persona coinvolge direttamente nella vicenda il lettore, che l’autore interpella in continuazione con domande retoriche ed esclamazioni, senza contare che il fatto banalissimo da cui prende spunto l’opera (l’osservazione, da parte del protagonista, del proprio naso) rende la storia molto vicina alla realtà quotidiana del lettore.
L’autore, con quest'opera, vuole analizzare il rapporto praticamente indispensabile che intercorre tra l’uomo e la società: egli infatti evidenzia come l’uomo non viva “tra” gli altri ma “per” gli altri, e ciò determina una dissoluzione della sua personalità in base ai tanti e diversi modi in cui ogni persona lo vede. È proprio la consapevolezza di non essere “uno”, ma “tanti”, a seconda del punto di vista e dell’idea che ognuno si è costruito, a condurre il protagonista alla follia, perché insieme alla coscienza della propria frammentazione egli si rende anche conto di non essere nessuno in sé stesso, ma di essere solo quello che gli altri pensano di lui. L’uomo quindi è tale in base alla sua posizione nella società, ai suoi doveri, a ciò che gli altri credono e si aspettano da lui, e Moscarda capisce che talvolta è stato proprio lui stesso a contribuire alla costruzione della propria immagine presso gli altri. Ecco che allora il protagonista cerca di fermare il flusso continuo della vita e di riflettere, di trovare sé stesso, di inserire un’immagine che sia solamente sua, distaccata dai giudizi altrui; ma è praticamente impossibile “vedersi vivere” attraverso i propri occhi e non attraverso quelli delle persone con cui veniamo in contatto. Moscarda tenta di “vedersi” come se fosse un estraneo, senza tuttavia riuscirci, perché nel momento in cui si percepisce prende coscienza di essere sé stesso e perde quindi ogni spontaneità.
Alla fine il protagonista si ritrova svuotato: il tentativo di dimostrare anche agli altri le sue teorie lo ha condotto all’allontanamento dalla società, che lo addita come “pazzo”. Moscarda ora vive attimo per attimo, senza più un proprio “io”, senza ricordi e senza che il suo pensiero si smarrisca di nuovo in mezzo alle sue stesse speculazioni, come se rinascesse, in ogni momento.
Forse era proprio questo che l’autore voleva comunicare, la drammatica instabilità della vita dell’uomo, che o scorre inconsapevole di sé stessa, senza pensieri, presa dal vortice della propria quotidianità, o, quando si ferma a osservarsi, non può fare altro che rendersi conto della propria superficialità e fragilità.
Sintesi di Uno, Nessuno, centomila
Libro Primo:Parte I: Mia moglie e il mio naso: Vitangelo Moscarda (Gengè per gli amici) è il protagonista.
Un giorno, guardandosi allo specchio, si rende conto di avere il naso pendente dal lato destro. Questo difetto viene sottolineato dalla moglie e ciò lo infastidisce; la donna aggiunge che questo non è il suo unico difetto. Infatti, anche le sopracciglia sono troppo folte, le gambe sono storte e le orecchie sono attaccate male.
Moscarda inizia così a riflettere sulla sua vita, in cui non ha mai lavorato e che ha sempre passato oziando; egli ha ereditato dal padre una banca che due amici (Firbo e Quantorzo) amministrano lasciando che il protagonista si occupi pochissimo dei suoi affari. Ad ogni modo, Moscarda si ritiene un uomo libero da vincoli padronali e da responsabilità, ma senza sapere cosa fare e dove andare nella vita. Dopo le riflessioni, Moscarda torna a pensare ai suoi difetti pensando di non conoscere nemmeno il suo corpo.
Parte II: E il vostro naso?: Lo stesso giorno, preso dal nervosismo, comincia ad importunare un amico chiedendogli se si sia mai reso conto del suo naso storto e in più, per rivalsa, comincia a mettere in evidenza i difetti fisici del suo amico, puntualizzando di non essere l'unico con delle imperfezioni.
Parte III: Bel modo di essere soli!: Dal giorno in cui ha preso coscienza dei suoi difetti Moscarda desidera stare solo. La vicinanza della moglie e dei suoi discorsi frivoli lo esasperano; lui ha bisogno di stare da solo davanti allo specchio per riflettere, pensare ad eventi piacevoli che valgono la pena essere ricordati.
Parte IV: Com'io volevo esser solo: Il modo con cui Moscarda vuole essere solo comincia a rasentare la pazzia. Sostiene che l'unico modo per essere veramente solo è di stare in un posto dove si è sconosciuti, estranei. Solo così può essere solo, perché la sua persona sia, insieme a se stesso, anche estraneo. Vuole parlare con l'io che lo infastidisce per conoscerlo meglio.
Se per gli altri non è l'uomo che pensa di essere, allora chi è veramente? Come può vedersi come lo vedono gli altri? Questo concetto è per lui fonte di sgomento. Vorrebbe conoscere a tutti i costi quell'io dentro di lui che tutti, eccetto lui, conoscono già. In queste riflessioni comincia a maturare la follia del protagonista.
Parte V: Inseguimento dell'estraneo: Ogni volta che Moscarda è solo in casa si sofferma davanti allo specchio per guardarsi e fare smorfie, aggrottando le sopracciglia immaginando dolore per la morte della moglie o meraviglia per qualcosa. Ad ogni sensazione che immagina corrisponde un'espressione diversa che è come la vive lui, non come lo vedrebbero gli altri.
Rallegrandosi della sua intelligenza nel riuscire a vedersi diverso da come si è sempre visto, non riesce a farsene una ragione, cioè non riesce a vivere per se stesso incurante di ciò che gli altri pensano di lui.
Moscarda si rende conto che c'è un io estraneo in lui che deve sempre portarsi dietro; questa idea lo sta ossessionando.
Parte VI: Finalmente: Un giorno la moglie Dida dice che deve andare a trovare l'amica Anna Rosa, malata. Moscarda, sapendo che le mogli fanno il contrario di ciò che dicono i mariti, si oppone, riuscendo così a rimanere solo finalmente.
Parte VII: Filo d'aria: Calmatosi dall'emozione, Moscarda chiude gli occhi e, con il suo estraneo corpo, torna davanti allo specchio. Ma una voce del suo inconscio gli dice che lì c'è anche l'estraneo, che può solo esser veduto; è come Moscarda per gli altri: può essere veduto ma non può vedersi. Una volta aperti gli occhi riuscirà Moscarda a vedere l'estraneo così come gli altri vedono Moscarda?
Queste considerazioni gli impediscono di aprire gli occhi in quanto sa che finché ha gli occhi chiusi lui e l'estraneo sono due cose diverse e non possono diventare l'un altro. Così apre gli occhi e vede se stesso con il viso disgustato.
Dopo essersi rasserenato vede l'estraneo e lo chiama per nome: "Moscarda!", ma lui resta fermo a guardarlo, senza reazioni. Moscarda non riesce a riconoscersi, vede un corpo che non sopporta, senza nome. Prova a salutarsi e sorridere.
Parte VIII: E dunque?: Tutte queste riflessioni sono state causate da sua moglie Dida che gli ha fatto notare la pendenza del naso. Moscarda cominciò così a pensare di non essere per gli altri ciò che ha sempre creduto di essere, ritenendo così di non potersi vedere, mentre gli altri possono vederlo.
Moscarda non riesce a vedere questo estraneo. Il suo corpo non sa di vivere e Moscarda lo può prendere di volta in volta, così come gli altri. Quel corpo non è niente e nessuno, anche un filo di vento può portarselo via.
Capisce allora perché sua moglie l'abbia nominato Gengè e decide che vuole scoprire chi è realmente, almeno per i suoi conoscenti.
Libro secondo:
Parte I: Ci sono io e ci siete voi: Riflettendo, Moscarda si rende conto che alla maggior parte delle persone non interessi volersi veder vivere come interessa a lui. Non tutti fanno caso ai propri difetti e non tutti fanno caso a ciò che gli altri dicono di loro. Ognuno basa la proprio vita sulla propria coscienza, ritenendo quindi di vivere sempre nella ragione, ciò conforta e tranquillizza.
Parte II: E allora?: Ciò significa che la verità è che la vita si basa sulla presunzione che la realtà che vediamo noi è come la realtà che vedono gli altri. Non ci interessa se le persone ci vedono in modo diverso da come noi vediamo noi stessi: pensiamo semplicemente che ciò non succede.
Parte III: Con permesso: La casa di Moscarda contiene ancora vecchi mobili della madre e il viottolo che conduce all'abitazione è contornato da una fila di cipressi tipo camposanto. In molti criticano questa la casa: ognuno ha le sue opinioni e i suoi gusti.
Parte IV: Scusate ancora: Inoltre, non è detto che se quando si parla si trova un accordo riguardo a qualcosa, il giorno seguente non ci si trovi in disaccordo, poiché ciò che si dice può essere interpretato in maniera diversa da persona a persona, in base a come ciascuno interpreta le parole. Ognuno vive la sua realtà in buona fede, ma la sua realtà. La mia sarà diversa.
Parte V: Fissazioni: Viviamo ogni giorno di fissazioni. Oggi ci fissiamo in un modo, domani in un altro.
Parte VI: Anzi ve lo dico adesso: Una montagna, grande e grossa, sembra stare ferma, ma in realtà si muove. È l'uomo che la fa muovere, prendendo il legno per fare i mobili, le pietre e la sabbia per fare le case. L'uomo è un essere piccolissimo rispetto alla montagna, ma ha qualcosa che essa non ha.
Parte VII: Che c'entra la casa?: Il discorso della casa sembra non c'entrare ma in realtà c'entra eccome. Moscarda, rivolgendosi al lettore dice che ormai è prevenuto e comincia ad abituarsi alla sua pazzia.
Parte VIII: Fuori all'aperto: Girare per la campagna infonde un senso di pace, poiché è un luogo naturale, non costruito dall'uomo. In città si vive alla ricerca di qualcosa che non c'è perché ce lo mette l'uomo, si cerca sempre qualcosa che dia senso alla vita. Nella campagna invece, nel silenzio, la natura vive per vivere, e qui l'uomo prova un senso di pace ed abbandono.
Parte IX: Nuvole e vento: Come sarebbe bello essere senza la coscienza d'essere, come una pianta o una pietra, non sapere di esistere ed ignorare se stessi.
Parte X: L'uccellino: La campagna, con la sua grandezza, rende vane le ambizioni degli uomini. Ad esempio, che senso ha il volere a tutti i costi volare con una macchina costruita, puzzolente e che al primo guasto cade e muore? Vedere il volo leggero e naturale dell'uccellino fa capire quanto siano inutili le ambizioni degli uomini.
Qui all'aperto si riesce a fare questo ragionamento ma appena tornati in città e si capisce perchè bisogna volare, tagliare piante e portare via pietre. La città è un mondo che ha senso solo per l'uomo che lo ha costruito.
Parte XI: Rientrando in città: Moscarda fa ancora riflessioni filosofiche. Come sono tristi gli alberi in città, tosati, pettinati e smarriti. Se potessero pensare e parlare... beati gli uccellini che possono volar via.
Ci vorrebbe più accordo tra uomo e natura, che spesso distrugge le costruzioni dell'uomo. La natura distrugge, ma l'uomo, caparbio e testardo, ricostruisce. L'uomo costruisce anche se stesso e crede di conoscersi: la realtà è quella che noi riusciamo a dare a noi stessi. Basta che le cose cambino un poco la realtà cambia.
Parte XII: Quel caro Gengè: Dida dice di conoscere bene suo marito, il caro Gengè. Per forza. Se l'è costruito come lo vorrebbe lei, ma soprattutto lui non si è mai opposto. Lui non ha mai saputo dare forma alla sua vita; anche gli ostacoli che ha incontrato non lo hanno mai stimolato ad affermarsi diventando qualcuno. Questo non per la sua debolezza, per il suo disinteresse, per la rassegnazione ai dispiacere che sarebbero potuti conseguire.
Così Gengè viveva in uno stato di confusione continua, conosciuto dagli altri in centomila modi diversi, salvo per il fatto che per se stesso Moscarda non era nessuno.
Nonostante l'abbia costruito come voleva lei, Dida riesce a trovare dei difetti in Gengè. A volte infatti lei piange per cose che lui dice, attribuendo un significato diverso a quello che la moglie darebbe a queste frasi. Dida ama questo Gengè e Gengè non può cambiare. Tuttavia il Gengè che lei ama non corrisponde al vero Moscarda, c'è un estraneo fra loro due.
Quando Moscarda decide di distruggere l'intruso, la moglie, inorridita, dichiara di non poterlo più amare a scappa.
Libro terzo:
Parte I: Pazzie per forza: Moscarda, una volta presa coscienza che esiste un Moscarda diverso per ogni suo conoscente, decide di scovarli uno ad uno e distruggerli.
Parte II: Scoperte: Moscarda scopre di avere un nome brutto e fastidio che ricorda le mosche (in realtà derivava da "muschio") e tutte le sue azioni vengono legate al suo nome.
Moscarda vorrebbe darsi un nome diverso per ogni suo atteggiamento perché nel suo proprio non si identifica. Non gli piacciono nemmeno le sue fattezze, ma guardandosi allo specchio ha capito che deve rassegnarsi, non potendo farci nulla. Anche le sue condizioni di vita non le aveva scelta, le aveva ereditate e con esse tutti i giudizi degli altri, dall'odio all'invidia.
Ha sempre pensato di aver fatto dipendere da se stesso le sue vicende, tuttavia ora si rende conto che ciò che ha è dipeso da altri: il nome, il corpo e lo stile di vita. Questa idea non gli piace.
Tutti pensano inoltre che egli ozi per l'eredità di suo padre; Moscarda invece credeva di aver fatto dell'ozio una sua caratteristica.
Parte III: Le radici: Il padre di Moscarda a suo modo gli voleva. Più che altro provava compassione per quel figlio inetto, ingenuo e incapace di combinare qualcosa. É comunque un figlio nato per sbaglio.
Parte IV: Il seme: Moscarda realizza che ha di suo padre un'immagine diversa da quella che hanno gli altri. Scopre come viveva suo padre e come si comportava. Queste verità lo mortificano e lo fanno vergognare.
Parte V: Traduzione d'un titolo: Del padre ha pochi ricordi. Morta la madre giovanissima, fu cresciuto in diversi collegi e poi frequentò diversi corsi all'università ma senza mai raggiungere risultati.
Quindi, dato il suo scarso profitto, fu richiamato a casa e ammogliato, forse nel tentativo di farlo maturare. Dopo due anni dal suo ritornò il padre morì. Quello che Gengè sa di suo padre è che è un banchiere. Di fatto, un usuraio, uno speculatore non stimato ma odiato in paese. Odio che il figlio erediterà.
Parte VI: Il buon figliolo feroce: Moscarda è inorridito da questa notizia ma quando ne parla alla moglie ella scoppia a ridere considerando la domanda sciocca. Moscarda capisce allora di essere uno sciocco per la moglie (il suo Gengè) e un usuraio per i cittadini. Moscarda è ancora peggio del padre in realtà, il padre almeno lavorava. Con Moscarda di affari non parla nessuno.
Quando qualcuno fa una domanda a Gengè per una raccomandazione lui ne squadra il viso per trovare i difetti. Nessuno fa male a Gengè perché lui non fa del male a nessuno. Vive come un cieco e per tutti è un figlio di papà incapace.
Moscarda introduce due personaggi che incontra tornando a casa ogni giorno: Marco di Dio e la moglie Diamante.
Parte VII: Parentesi necessaria, una per tutti: Questi due personaggi sono le prime vittime dell'esperimento per distruggere uno dei tanti Moscarda.
Moscarda, da persona coerente, si chiede come possa parlare di persone che non conosce se non per come li vede lui. In realtà non ne avrebbe diritto, sennò farebbe loro lo stesso torto che subisce lui. Solo che lui è fissato e quindi può farlo. Si può pensare che una persona sia costruita non da se stessa ma dai fatti che le sono accaduti nella vita e dalla sua esperienza. Ogni atto che qualcuno compie se lo porterà dietro per tutta la vita, imprigionandolo. Anche Moscarda ritiene di essere imprigionato, ingiustamente. Quando compiamo un atto pensiamo di essere tutti in quell'atto ma in realtà solo una parte di noi lo compie. Se i fatti non sono gravi si chiamano disinganni. La realtà è un inganno.
L'inganno consiste nel fatto che siamo sempre noi a dare una forma alla realtà, in base a chi siamo in quel momento. Ci illudiamo che la realtà di oggi sia l'unica vera, ma è spesso illusione domani.
Parte VIII: Caliamo un poco: Non si può capire la realtà di una persona solo da alcuni suoi aspetti. Ad esempio il protagonista può sembrare imbecille per alcuni poiché lascia Quantorzo a gestire la banca e Firbo alla consulenza legale, per altri questa scelta può sembrare avveduta, ma sembrare imbecille perché porta a spasso la cagnolina della moglie.
Parte IX: Chiudiamo la parentesi: Quindi ci si può sforzare di apparire a qualcuno in un certo modo, ma sarà solo un'interpretazione.
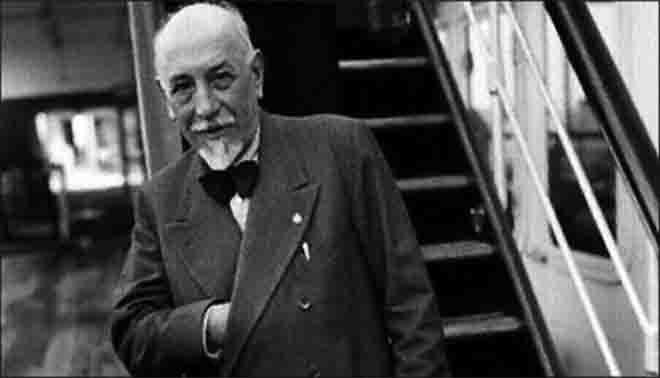
Parte X: Due visite: Moscarda riflette sull'imbarazzo di fronte alla situazione in cui sta con due amici che non si conoscono ma che potrebbe scoprire di conoscere due Moscarda diversi.
Libro quarto:
Parte I: Com'erano per me Marco di Dio e sua moglie Diamante: Sono una coppia di poveracci. Nel senso che faticano a mangiare e vivere. Marco aveva un futuro da artista in uno studio ma cadde in disgrazia quando cercò, in un momento di debolezza, di abusare di un giovane modello. Fu incarcerato e quando uscì non trovò più lavoro. Avrebbe voluto andare in Inghilterra. Crede di poter diventare ricco dopo qualche improvvisa invenzione.
Marco odia Moscarda, a causa di suo padre che gli faceva elemosine ma poi gliele richiedeva indietro.
Anche Moscarda cercava di aiutarli, lasciandoli alloggiare gratuitamente in una catapecchia di sua proprietà, fonte del suo primo esperimento...
Parte II: Ma fu totale: Totale perché il cercare di sembrava diverso dai centomila Moscarda in cui viveva gli apre la strada verso la pazzia. Compierà un atto per cercare di dimostrare di non essere un usuario, tuttavia la gente lo riterrà pazzo. Rischierà anche la vita, oltre al manicomio, per riprendersi la salute.
Parte III: Atto notarile: Per realizzare l'esperimento Moscarda ha bisogno di fare un atto notarile. Si reca quindi dal notaio Stampa cav. Elvidio a Richieri, la sua città.
Arrivato all'ufficio comincia a riflettere riguardo al silenzio degli uffici e al rumore dei canarini in gabbia, al punto che il notaio comincia a guardarlo in modo strano.
Spiega al notaio il tipo di atto che vuole fare ed aggiunge che deve rimanere un segreto. Moscarda deve allora andare a prendere dei documenti in banca.
Parte IV: La strada maestra: Deve allora rubare le carte al Moscarda usuraio. Ormai sta diventando pazzo. Considera però poi che tutti sono pazzi, anche se non sanno di esserlo.
Parte V: Sopraffazione: Moscarda non sa però dove cercare le carte. Trova l'ambiente squallido però non giudica per evitare di essere deriso da chi sa che lui non si occupa degli affari.
Entrato in banca assiste ad un dibattito tra Furbo e un certo Turolla, deriso a causa dei suoi abiti dopo essere andato lì per chiedere un prestito.
Moscarda riprende allora Firbo dicendo che deve trattare meglio anche sua moglie (di Firbo) invece di chiuderla in manicomio. Moscarda viene portato in direzione mentre continua a criticare l'atteggiamento di Firbo.
Poi chiede scusa inginocchiandosi a Firbo per ciò che ha detto sulla moglie. I due sono straniti. Così chiede loro perché Marco di Dio non paga da molto l'affitto. Loro rispondono che è stato suo padre a volerlo tanti anni prima. Moscarda è però impassibile e vuole i documenti, sbatte fuori i due collaboratori e cerca i documenti.
Parte VI: Il furto: Moscarda è entrato per rubare a se stesso ma non sa dove cercare. Pensa che non è lui a compiere quell'atto, ma uno dei tanti Moscarda. Qualcuno bussa alla porta e lui respinge l'intruso. Trova le carte, si sente liberato, ma poi si insospettisce perchè sta rubando a se stesso.
Parte VII: Lo scoppio: Il giorno dello sfratto piove. Moscarda è insieme a due guardie e fuori in strada si ammucchiano le poche cose dei di Dio e si sentono i commenti della gente ("Più schifoso del padre, usuraio, usuraio, accanirsi contro un povero pazzo").
Marco di Dio esce, vede Moscarda e non lo uccide solo grazie alle due guardie. Tra le grida della folla prende voce un giovane lavoratore dello studio notarile che ha qualcosa da dire a nome del notaio.
Tutti urlano ma il giovane dice che è stata fatto una donazione a di Dio: gli è stata fatto una donazione di una casa ed un assegno di diecimila lire per acquistare un laboratorio con tutti gli attrezzi. Il donatore è Moscarda. Tutti cominciano allora a gridare "pazzo!" a Moscarda.
Libro Quinto:
Parte I: Con la coda tra le gambe: L'episodio ha portato la considerazione da parte di Quantorzo, mentre Firbo vorrebbe farlo interdire in quanto pazzo e dannoso per l'immagine della banca. Quantorzo prevale facendo notare che Moscarda è il proprietario e la loro ricchezza la si deve a lui.
In questa discussione Moscarda se ne sta in disparte.
Parte II: Il riso di Dida: Dida prende a strapazzare il suo Gengè dicendo che l'ha fatta troppo grossa. Ma Moscarda è angosciato da fatto che Gengè non è lui. Sente sua moglie estranea e ne prova orrore.
Moscarda prova rancore verso Dida che non ha capito che è stato solo uno scherzo e si schiera dalla parte di Firbo contro di lui. Poi gli ordina di portare a spasso la cagnolina, ma Moscarda vorrebbe sedersi e non rialzarsi più.
Parte III: Parlo con Bibì: Nemmeno la cagnolina pare volerlo seguire. Va a nascondersi in un cantiere dismesso e si siede su una pietra. Qui comincia a parlare con la cagnolina: spiega che vuole nascondersi dagli sguardi della gente e che non vuole essere guardato perché nessuno dubita mai di quel che vede.
Parte IV: La vista degli altri: Moscarda pensa di uccidersi per liberarsi dal suo tormento e dimostrare di non essere l'imbecille che tutti pensano. Se non vedrà più nessuno che senso darà alla sua vita da morto? Sta impazzendo e prende a calci la cagnetta che lo guarda stranito.
Parte V: Il bel giuoco: No, non è stato lui a dare il calcio a Bibì; è stato un ragazzaccio smarrito. Che bel gioco sarebbe poter tornare da morti e vedere gli altri vivi. Che voglia ha di prendere tutti a calci!
Parte VI: Moltiplicazione e sottrazione: Rientrato a casa, trova Dida che confabula con Quantorzo, sicuramente di lui. Entrando Moscarda dice eccoci qua, intendendo che nel salotto ci sono, non tre, ma nove, anzi otto persone, visto che Moscarda, per se stesso, non conta più. Si sta preparando una bella conversazione tra otto persone che pensano di essere in tre.
Parte VII: Ma io intanto dicevo tra me: Moscarda pensa che se guardasse gli altri nel salotto, coi suoi occhi pieni di terrore, farebbe vacillare la loro sicurezza.
Parte VIII: Il punto vivo: Quantorzo è turbato, non per lo sguardo di Moscarda, ma dal tono delle sue affermazioni.
Quantorzo si è recato a casa di Moscarda per dissuaderlo dall’intromettersi negli affari della banca, per legargli mani e piedi in modo da tenerlo lontano e inoffensivo.
Ma Moscarda comincia a criticare l’operato dei due fedeli collaboratori. Dice che sugli scaffali c’era troppa polvere.
Poi comincia ad alzare la voce ed a litigare con Quantorzo trovando futili motivi sino che ad un certo punto dice che era stanco di essere chiamato usuraio.
Questa frase suscita risa di scherno da parte di Quantorzo e della moglie Dida.
Moscarda è punto nel vivo e grida alla moglie di tacere, che lui non era lo sciocco Gengè ma un altro che sa cosa vuole. Vuole che la banca venga chiusa e vuole ritirare i suoi soldi.
Il litigio si fa sempre più aspro ma Moscarda non cede. Tuttavia non può raccontare tutte le sue riflessioni. Può impazzire ma non distruggere il suo nemico. Urla alla moglie di finirla con Gengè e se ne va furioso.
Libro Sesto:
Parte I: A tu per tu: Moscarda si rende conto di aver compromesso il suo rapporto con Dida, ma finalmente è diventato ciò che voleva. Come può purificare i soldi della banca dalla colpa dell'usura?
Anche la moglie che se n'è andata è un punto vivo per lui. Lui la ama ma si rende conto che lei ama un Moscarda diverso, Gengè appunto.
Parte II: Nel vuoto: La casa è vuota, Dida è andata da suo padre e Moscarda è finalmente libero.
Parte III: Seguito a compromettermi: Il giorno seguente Moscarda va dal suocere e si diverte a prodursi in tanti altri individui pensando alla commedia da recitare.
Parte IV: Medico? Avvocato? Professore? Deputato?: Il suocere chiede a Moscarda se davvero sia impazzito e cosa ne farà di sua figlia e della sua vita. L'uomo dice che venderà la banca e, grazie ai sei anni di università, diventerà ciò che Dida vorrà. Il suocero capisce che è pazzo e se ne va.
Parte V: Io dico, poi, perché?: Il tono col colloquio col suocere era scherzoso; anche lui non accettava che Gengè non ci fosse più. Se Moscarda potesse andarsene con un altro corpo, lascerebbe Gengè ai suoi cari.
Parte VI: Vincendo il riso: Moscarda ha pensato nella notte che potrebbe fare anche professore o avvocato ma si rende conto che Dida non tornerebbe con lui più ormai.
Libro Settimo:
Parte I: Complicazione: Il mattino dopo viene invitato da Anna Rosa, un'amica di Dida. Lui pensa sia per tentare una riconciliazione o per dissuaderlo dal liquidare la banca. Oppure avrebbero potuto ricattarlo, riavere Dida in cambio di recedere dalle decisioni, dannose per tutti.
Parte II: Primo avvertimento: Moscarda non ha mai parlato con Anna Rosa. La donna vive in una badia (monastero) insieme ad altre vecchie suore. Arrivato lì la serva dice a Moscarda di andare a cercare Anna Rosa dalla zia monaca. Moscarda è preoccupato e pensa che andare su alla badia potrebbe avere conseguenze sulla sua vita.
Parte III: La rivoltella tra i fiori : Moscarda riesce a raggiungere la Badia e nel buio incontra Anna Rosa che, casualmente, si ferisce con una pistola che ha in borsa. Moscarda porta allora la donna ferita a casa sua domandandosi se la pistole sarebbe dovuta servire per lui.
Parte IV: La spiegazione: Moscarda scopre che Dida aveva detto ad Anna Rosa che Gengè la schivava per paura di innamorarsene. Riguardo la rivoltella Anna Rosa dice che la porta sempre con sè.
Ma la cosa più interessante è la spiegazione di Anna Rosa riguardo al fatto che Dida, insieme a Quantorzo, Firbo, di Dio, Turolla e il suocero, voleva fare interdire Moscarda. Anna rosa aggiunge dei particolare su Dida che Moscarda non immaginava.
Parte V: Il Dio di dentro e il Dio di fuori: Moscarda racconta che quando andava a spasso con Bibì le spiegava che gli uomini costruiscono le chiese perché hanno bisogno di costruire una casa anche per i loro sentimenti. Moscarda dice che punto vivo che si era ferito quando Dida aveva riso di lui quando disse che non voleva esser ritenuto un usuraio era Dio. Ma Moscarda non poteva parlarne con Firbo e Quantorzo, doveva appellarsi al Dio di fuori, nella casa costruita dai fedeli.
Parte VI: Un vescovo non comodo: Moscarda va a trovare monsignor Partanna, il nuovo vescovo che è arrivato a piedi e che predilige il Dio di dentro piuttosto che il Dio di fuori, comodo.
Parte VII: Un colloquio con Monsignore: Il colloquio col monsignore viene interrotto dalla vista di un pazzo che rischia di buttarsi giù dal tetto. Moscarda continua poi a sentire il discorso sulla coscienza del monsignore. Poi viene chiamato Don Antonio Sclepis, il quale conferma che aiuterà Moscarda a non essere interdetto.
Parte VIII: Aspettando: Moscarda è tentato dal fisico di Anna Rosa. Quando la ragazza gli fa un sorriso che ha provato poca prima allo specchio l'uomo si irrita e dibatte con la donna sul fatto che guardarsi allo specchio non è vivere, è come diventare statue e atteggiarsi si oppone al divenire della vita. Il dialogo con Anna Rosa continua e alla fine la donna, inorridita dal fascino di ciò che Moscarda le ha detto, gli sparò al petto.
Libro Ottavo:
Parte I: Il giudice vuole i suo tempo: Il giudice del processo contro Anna Rosa prende mesi per capire la dinamica dell'accaduto. Anna Rosa ha dato la sua versione, corrispondente al vero, ma il giudice vuole parlare con Moscarda.
Parte II: La coperta di lana verde: Ricondotto a casa, Moscarda se ne sta su una sedie con una coperta di lana verde sulle gambe, sulla quale immagina la campagna. Arriva il giudice al quale Moscarda non vuole raccontare la sua idea sulla vita per paura di terrorizzarlo come ha fatto con Anna Rosa.
Parte III: Remissione: Il dialogo col giudice avrebbe favorito l'assoluzione di Anna Rosa, ma reso più difficile il compiti di Sclepis, che lo aiuta tuttavia ad ottenere come penitenza la devoluzione di tutti i suoi beni per fondare un ospizio di mendicità nel quale anche lui si sarebbe fatto ricoverare.
Parte IV: Non conclude: Anna Rosa viene assolta, anche grazie al modo in cui Moscarda si presenta in tribunale (berretto, zoccoli e camiciotto turchino dell'ospizio). Moscarda passa gli ultimi anni della sua vita nell'ospizio in campagna in cui non si guarda più allo specchio ma decide di morire e rinascere continuamente, nelle cose che lo circondano. Il nome non fa più parte di lui, è solo un epigrafe funebre, per qualcosa che è finito, morto. Moscarda vuole vivere e non conclude con l'etichetta del nome.
Uno, Nessuno, centomila, commento
L'argomento principale di uno degli ultimi romanzi pirandelliani, "Uno, nessuno e centomila", pubblicato nel 1924 (iniziato a scrivere nel 1909), è la riflessione, intesa non solo come espediente per dissolvere la "forma" che costringe la "vita", ma anche come mezzo di "scomposizione del personaggio". La riflessione viene condotta dal protagonista della storia. Come scrisse Pirandello nell'opera L'umorismo: "La riflessione diventa come un demonietto che smonta il congegno dell'immagine, del veder com'è fatto, scarica la molla, e tutto il congegno ne stride, convulso". In tale senso, è possibile affermare che l'opera è incentrata sullo "smontare il congegno dell'immagine", attraverso tematiche psicologiche ed introspettive, del personaggio Vitangelo Moscarda, detto Gengè, figlio di un usuraio, oppresso dal fardello di una condizione sociale non voluta.Gli eventi vengono narrati seguendo un preciso ordine cronologico che abbraccia un periodo non chiaramente specificato della vita del protagonista (dai 28 anni di età in poi): dal momento in cui egli si accorge di essere uno dei centomila che subiscono la realtà esterna, ridestandosi e rifiutando il ruolo in cui è stato relegato, fino alla realizzazione del suo intento, l'estraniarsi dalla vita fino a divenire nessuno. Non a caso, il narratore, interno ma non onnisciente (infatti non conosce i pensieri degli altri personaggi), coincide con il protagonista della storia, incarnando il pensiero di un borghese rivoluzionario dei primi decenni del 1900 intento a distruggere quella rappresentazione che "non esiste per nessuno, sia creata dall'arte e sia comunque quella che tutti ci facciamo di noi stessi, degli altri e della vita" e che non si può credere una realtà, come afferma l'autore stesso nel volume poc'anzi citato.
Attraverso una narrazione realistica o comunque fedele al punto di vista del protagonista/narratore, quindi verosimile, viene tuttavia tratteggiato un paesino della Sicilia dal nome di Richieri del tutto inventato da parte dell'autore. A tal proposito, quasi sicuramente, la scelta di un luogo non esistente è riconducibile allo scopo di fondo di evidenziare il fatto che l'interesse primario dell'autore è quello di rappresentare una condizione generale, senza tempo e senza una fissa collocazione fisica, ascrivibile alla classe sociale della borghesia. Sulla scena domina quindi l'emblema della borghesia in crisi, Vitangelo Moscarda, che non è diverso dai soliti personaggi pirandelliani: in lui è facile individuare il tranquillo benestante provinciale attorno al quale si muovono i centomila personaggi di contorno, la piccola borghesia italiana di inizio secolo. Tuttavia, come nota la scrittrice Angela Cerinotti, "a dispetto di questo sfacciato protagonismo, al Moscarda è capitata la terribile avventura di scoprirsi nessuno. Non quel Nessuno che, nell'Odissea, fornì a Ulisse l'espediente per procrastinare la vendetta di Polifemo, avendo detto al Ciclope di chiamarsi così; [...] ma quel nessuno cui, nella psicanalisi, corrispondono i disturbi dell'identità". La crisi è tanto più grave perché, quando Vitangelo decide di ricondurre ad un'unità le centomila immagini che di lui hanno gli altri e stravolge il suo atteggiamento, viene preso per pazzo, viene abbandonato dalla moglie e va a vivere nell'ospizio da lui stesso fondato, dopo aver liquidato la banca del padre. La questione di fondo resta, dunque, il rapporto individuo-società. Infatti "Gengè rinuncia addirittura e consapevolmente all'identità personale e la sua battaglia contro le funzioni e le convenzioni sociali è in funzione di un'identità collettiva", come afferma, infine, la Cerinotti.
La caratteristica fondamentale del protagonista, Gengè, personaggio dinamico e a tutto tondo, è il continuo rifiuto di essere limitato a schemi ben definiti, che non fanno altro che frantumare la sua identità in altre centomila, nelle quali egli non si identifica: "Dovevo lasciarlo così com'era, quel buon figliolo feroce di Gengè [...] E io vi giuro che l'avrei lasciato lì [...] per non cagionare un così grave scompiglio a tanta brava gente che mi voleva bene, se, lasciandolo lì per gli altri, io poi per conto mio me ne fossi potuto andare altrove con un altro corpo e un altro nome" (p. 150). Vitangelo Moscarda è, dunque, l'emblema dell'io negato, quell'individuo dalla frammentarietà incolmabile, quell'uomo "tutto scisso e che non sapeva come avrebbe fatto a vivere domani" (p.170).
Si può affermare inoltre che il pensiero dell'autore coincide con quello del narratore/protagonista: a tal proposito, la Cerinotti infatti evidenzia "Vitangelo Moscarda ha il compito di esporre e motivare, sia pure nell'intelaiatura di una trama, i capisaldi della visione pirandelliana del mondo di fronte a un ideale pubblico". E tale ideologia di fondo emerge in modo chiaro e facilmente comprensibile, attraverso un linguaggio semplice, colloquiale, a tratti cogitabondo, tendente alla introspezione e alla trattazione filosofica.
Un personaggio significativo è la moglie Dida, una donna semplice e a modo che considera Vitangelo come il suo Gengè, uomo ingenuo e mansueto. Tale opinione è così radicata in lei tanto che, più forte è la convinzione di vedere il marito in un certo modo, tanto egli differisce da quella "marionetta" che ella si è creata ( per compiacersi). Quando Dida scopre che l'uomo che ha davanti non coincide con il Gengè della sua mente decide di lasciarlo e di ritornare alla casa paterna. A tal proposito risultano significative le parole del Moscarda pronunciate poco prima che la moglie lo abbandoni: "Finiscila tu, col tuo Gengè che non sono io, non sono io, non sono io! Basta con codesta marionetta! Voglio quello che voglio; e come voglio sarà fatto!" (p. 140). Anche Firbo e Quantorzo, altri due personaggi della vicenda, nonché i dirigenti della banca del padre di Vitangelo, si sono creati un'immagine del Moscarda totalmente differente rispetto alla realtà, credendolo una persona che non avrebbe mai intralciato i loro affari. Tuttavia devono ricredersi nel momento in cui il loro superiore decide di liquidare la banca, tanto che cercano di interdirlo al fine di salvaguardare i loro interessi ed evitare il fallimento dei loro affari. Un altro importante personaggio è il padre di Gengè che, benché non presente nella vicenda (in quanto morto), viene ricordato dal protagonista durante i suoi momenti di riflessione, simile a tratti alla follia. Infatti, Vitangelo è funestato dal superego funereo del padre morto (come accade anche a Zeno Cosini), il quale lascia in eredità al figlio la fama di "usurajo". A differenza di Zeno, però, il Moscarda cerca di rimuovere il ricordo oppressivo del padre non solo attraverso la riflessione, ma anche distruggendo materialmente l'unico mezzo che lo lega al padre e alla sua professione, cioè la banca. L'ultimo personaggio in ordine di presentazione è Anna Rosa, una giovane amica di Dida.
Il suo personaggio emerge nel momento più critico della vicenda, quando Vitangelo rischia di essere interdetto dai suoi amici e familiari. Anna Rosa convince il protagonista a rivolgersi al vescovo del paese al fine di farlo redimere. Tuttavia, in una circostanza bizzarra e imprevista, scopre che Vitangelo è attratto da lei e per questo motivo, cercando di difendersi, lo spara senza però ucciderlo. Alla fine della storia, quando il Moscarda si rifugia nel suo ospizio, viene scagionata perché il tentato omicidio viene fatto passare per un incidente non intenzionale da parte del protagonista stesso.
Il libro può essere suddiviso in due parti: la prima è caratterizzata dal travaglio interiore e dai disturbi di identità di Vitangelo, evidenziati attraverso continui soliloqui; la seconda parte è caratterizzata da una trama più ricca di contenuti, in cui la fabula coincide con l'intreccio, benché siano comunque presenti pause riflessive e momenti di analisi psicologica. Il ritmo della narrazione è pressoché costante per tutto il racconto. E' importante evidenziare i numerosi momenti di introspezione che, spesso, coincidono con le descrizioni attente dei luoghi in cui si svolge la vicenda (un'attenzione ai particolari di stampo verista).
La storia quindi è improntata su tematiche psicologiche e introspettive: il percorso compiuto dal Moscarda passa attraverso considerazioni esistenziali riconducibili alla ricerca del vero io e alla distruzione delle centomila false identità attribuitegli dagli altri. Sicuramente, l'intento di Pirandello è quello di fare riflettere il lettore circa l'impossibilità di definire una realtà certa e univoca per tutti proprio perché ognuno se ne costruisce una propria in base alla società in cui vive, alle convenzioni, agli individui che lo circondano, alle leggi civiche e morali del suo territorio.
Questa è, infatti, la forma che annienta l'impulso profondo della vita. Chiunque cerchi di disfarsi di questa condizione di indolente sottomissione, si estranea non solo dalla forma, ma anche della vita, con esiti non poco rovinosi, come è accaduto a Gengè. In questo senso, Pirandello dà, nell'impianto della narrazione, largo spazio creativo alla riflessione, che non resta invisibile: "non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandesene; ne scompone l'immagine". Secondo Giovanni Macchia, noto critico letterario e scrittore, "la riflessione è la fonte del dolore: e la vita quasi s'arresta o s'aggroviglia in quel sentirsi vivere". Per Vitangelo Moscarda conoscersi è morire: "Chi vive, quando vive, non si vede [...] Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più: la subisce, la trascina, come una cosa morta la trascina. Perché ogni forma è una morte.", sostiene Pirandello. E, partendo da un nucleo vitale, si comincia a procedere con la scomposizione della figura nei vari piani espressivi, come un continuo gioco di specchi, dove un'immagine insegue l'altra, con slanci isterici ed esaltanti.
Il critico Macchia sostiene che da quest'analisi introspettiva scaturiscono "confusione, disordine, caos, coscienza del vuoto, allontanamento da ogni certezza, distruzione della ragione", e si potrebbero anche aggiungere annientamento della personalità, dissoluzione dell'esistenza, riduzione drastica a cosa ("Non aver più coscienza d'essere, come una pietra, come una pianta: non ricordarsi più neanche del proprio nome [...] vivere per vivere, senza sapere di vivere."). Per concludere, a corroborare quanto già detto, risultano particolarmente significative le parole del protagonista nell'ultimo capitolo del romanzo: "Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di ieri; del nome d'oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non me ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude."
Uno, Nessuno, centomila di Pirandello
Inizialmente Vitangelo Moscarda (Gengé), il protagonista, ci viene presentato come un uomo del tutto comune e normale, senza nessun tipo di angoscia né di tipo esistenziale né materiale: conduce una vita agiata e priva di problemi grazie alla banca (e alla connessa attività di usuraio) ereditata dal padre. Un giorno questa piatta tranquillità viene però turbata: l’elemento disturbatore è un banale e innocente commento pronunciato dalla moglie di Vitangelo riguardo al fatto che il suo naso penda un po’ da una parte (a destra). Da questo momento la vita del protagonista cambia completamente, poiché Gengé si rende conto di apparire al prossimo molto diverso da come egli si è sempre percepito. Così decide di cambiare radicalmente il suo stile di vita, nella speranza di scoprire chi sia veramente, e a quale proiezione di sé corrisponda il suo animo. Nel processo di ricerca per trovare sé stesso compie azioni che vanno contro a quella che era stata la sua natura sino a quel momento: sfratta una famiglia di affittuari per poi donare loro una casa, si sbarazza della banca ereditata dal padre (inimicandosi ovviamente familiari e parenti), e inizia ad ossessionare chi gli sta vicino, con discorsi e riflessioni oscure che lo fanno passare per pazzo agli occhi della comunità. La situazione si aggrava al punto che la moglie abbandona la casa coniugale, e, insieme ad alcuni amici, inizia un'azione legale contro Vitangelo col fine d’interdirlo. Gli rimane fedele in un primo momento solo un’amica della moglie, Anna Rosa, che poco dopo però, spaventata dai ragionamenti di Vitangelo, arriva addirittura a sparargli, senza ucciderlo ma ferendolo in modo serio. Vitangelo, il cui "io" è ormai completamente frantumato nei suoi "centomila" alter ego, sembra trovare una tregua ai propri patimenti solo nel confronto con un religioso, Monsignor Partanna, che lo sprona a rinunciare a tutti i suoi beni terreni in favore dei meno fortunati. Il tormentato protagonista pirandelliano, rifugiatosi nell'ospizio ch'egli stesso ha donato alla città, riesce così a trovare un po’ di pace e di serenità solo nella fusione totalizzante (e quasi misticheggiante) con il mondo di Natura, l'unico in cui egli può abbandonare senza timori tutte le "maschere" che la società umana gli ha a mano a mano imposto. Vitangelo Moscarda conclude che, per uscire dalla prigione in cui la vita rinchiude, non basta cambiare nome: proprio perché la vita è una continua evoluzione, il nome rappresenta la morte. Dunque, l'unico modo per vivere in ogni istante è vivere attimo per attimo la vita, rinascendo continuamente in modo diverso.
Analisi: Il titolo del romanzo è una chiave di lettura per comprenderlo fino in fondo, infatti quella di Vitangelo Moscarda è la storia di una consapevolezza che si va man mano formando: la consapevolezza che l'uomo non è Uno, e che la realtà non è oggettiva. Il protagonista passa dal considerarsi unico per tutti (Uno, appunto) a concepire che egli è un nulla (Nessuno), attraverso la presa di coscienza dei diversi se stesso che via via diventa nel suo rapporto con gli altri (Centomila). In questo modo la realtà perde la sua oggettività e si sgretola nell'infinito vortice del relativismo.
Nel suo tentativo di distruggere i centomila estranei che vivono negli altri, le centomila concezioni che gli altri hanno di lui, viene preso per pazzo dalla gente, che non vuole accettare che il mondo sia diverso da come lo immagina. Vitangelo Moscarda è il "forestiere della vita", colui che ha capito che le persone sono "schiave" degli altri e di se stesse. Egli vede gli altri vivere in questa trappola, ma neanche lui ne è completamente libero: il fatto che la gente l'abbia preso per pazzo è la dimostrazione che non è possibile distruggere le centomila immagini, a lui estranee, che gli altri hanno di lui. È possibile solo farle impazzire.
La fine del romanzo è molto profonda, conclusione degna per un'opera di questa portata. Il rifiuto totale della persona comporta la frantumazione dell'io, perché esso si dissolve completamente nella natura. Pieno di significati è il rifiuto del nome, che falsifica ed imprigiona la realtà in forme immutabili, quasi come un'epigrafe funeraria. Al contrario della vita, che è un divenire perenne, secondo la concezione vitalistica di Pirandello.
Il punto sull'autore: Pirandello
Pirandello nasce ad Agrigento nel 1867 da una famiglia borghese benestante. Si laurea nel 1891 a Bonn in Lettere e l’anno successivo arriva a Roma. Grazie ad un assegno del padre, si dedica completamente alla letteratura; tuttavia, nel 1903, a causa della perdita delle rendite familiari, è costretto ad impegnarsi maggiormente nella scrittura e stesura di romanzi e novelle. Lavora anche in ambito cinematografico, rappresentando alcuni soggetti per film. In seguito al tracollo economico, la moglie, già psicologicamente instabile, sprofonda nella follia. Nel 1910, l’autore inizia l’attività a teatro e i suoi drammi vengono rappresentati in tutto il mondo. A partire dal 1922, invece, abbandona la cattedra universitaria e si dedica solo al teatro. Dal 1924 si iscrive al partito fascista e accetta la direzione del Teatro d’Arte a Roma. Nel 1934, viene nominato Premio Nobel per la Letteratura e muore a Roma il 10 dicembre del 1936. Secondo Pirandello, la realtà è un flusso continuo, ossia un movimento di trasformazione da uno stato ad un altro. La coscienza dell’uomo è formata da una successione continua di pensieri e stati d’animo, che sono sempre diversi ma che contribuiscono a determinare l’identità personale di un essere umano. Le convenzioni, però, ci impongono di indossare delle maschere e di recitare ruoli fissi, diventando per noi delle trappole, che rendono la vita un vero inferno. Ed è proprio questa la concezione che sta alla base di molte sue opere, tra cui, anche quella che illustreremo in questo appunto.Domande da interrogazione
- Qual è il tema centrale del romanzo "Uno, Nessuno e Centomila" di Luigi Pirandello?
- Come inizia la crisi di Vitangelo Moscarda nel romanzo?
- Quali azioni compie Vitangelo Moscarda per cercare di scoprire la sua vera identità?
- Qual è il messaggio che Pirandello vuole trasmettere attraverso "Uno, Nessuno e Centomila"?
- Come si conclude la storia di Vitangelo Moscarda nel romanzo?
Il tema centrale del romanzo è la crisi d'identità e la frantumazione dell'io, rappresentata attraverso la storia di Vitangelo Moscarda, che scopre di essere percepito in modi diversi da ogni persona che incontra, portandolo a una ricerca ossessiva di autenticità.
La crisi di Vitangelo inizia quando sua moglie Dida gli fa notare che il suo naso pende leggermente verso destra, un difetto di cui lui non era mai stato consapevole, scatenando in lui una profonda riflessione sulla sua identità e su come viene percepito dagli altri.
Vitangelo compie azioni inusuali come sfrattare una famiglia per poi regalarle una nuova casa, liquidare la banca ereditata dal padre e donare tutti i suoi beni ai poveri, nel tentativo di distruggere le false immagini che gli altri hanno di lui e trovare la sua vera identità.
Pirandello vuole evidenziare come la vita di ognuno sia influenzata dagli stereotipi e dai giudizi altrui, privandola di autenticità. Il romanzo esplora la casualità della vita e l'impossibilità di conoscere il proprio "io" interiore.
La storia di Vitangelo si conclude con lui che trova pace in un ospizio per i poveri, fondato da lui stesso, dove riesce a liberarsi delle maschere imposte dagli altri e accetta di vivere senza un'identità fissa, diventando "Nessuno".






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo