Concetti Chiave
- Il simbolismo, nato in Francia nel XIX secolo, si opponeva al naturalismo esaltando l'intuizione poetica e l'irrazionale, rifiutando le spiegazioni scientifiche dell'universo.
- Esponenti di rilievo del simbolismo includono Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé e Arthur Rimbaud, i quali esploravano una realtà misteriosa attraverso un linguaggio analogico e musicale.
- Il decadentismo, sviluppatosi successivamente, assorbì il simbolismo e si caratterizzò per l'estetismo e l'irrazionalismo, opponendosi al positivismo e promuovendo l'arte come fine ultimo.
- Il simbolismo influenzò il modernismo e trovò espressione anche nelle arti minori, anticipando movimenti come il surrealismo e il cubismo.
- Il simbolismo tedesco, fiorito tra il 1890 e il 1920, enfatizzava una "poesia pura" e includeva figure come Frank Wedekind, Stefan George e Rainer Maria Rilke, che esploravano emozioni e suggestioni intime.
In questo appunto si descrive il simbolismo che è un movimento che si è sviluppato in Francia nel corso del XIX secolo e si è poi successivamente diffuso in tutto il Continente europeo, esplicandosi nell'ambito letterario, artistico, culturale. Il movimento simbolista è nato quindi in Francia e la sua fondazione si ha grazie alla pubblicazione del Manifesto del Simbolismo ad opera del poeta francese Jean Moréas in data 18 settembre 1886. Vengono fatti dei confronti tra simbolismo, decadentismo e del naturalismo, analizzando anche delle analogie e delle differenze di fondo nei temi che i tre movimenti artistico-letterari presentano. Tra i maggiori esponenti della corrente artistico-letteraria simbolista si ricordano Verlaine, Rimbaud e Mallarmé.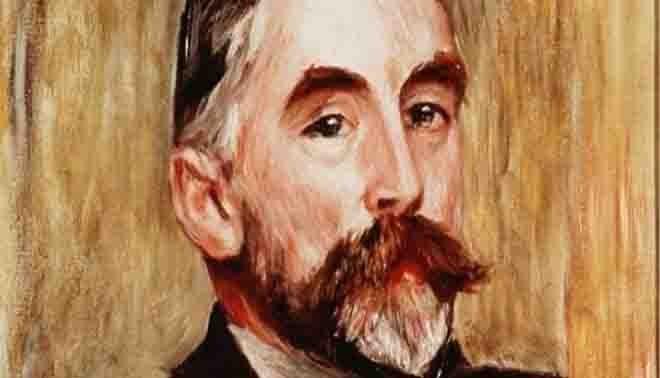
Indice
Il simbolismo
Nella produzione letteraria della seconda metà dell’Ottocento si manifesta il disagio dell’artista nei confronti della società della borghesia che celebrava il trionfo della scienza. Il poeta si considera estraneo al mondo esterno che lo circonda e reagisce o isolandosi o protestando contro il progresso. Il poeta vive in un esasperato individualismo, cercando esperienze estreme e spesso distruttive e provocatorie celebrando l’arte come valore assoluto. Il conflitto dell’artista con la società è avvertito dai poeti maledetti francesi, fondatori della lirica moderna e innovatori della poetica di quell’epoca. Charles Baudelaire impone con la raccolta “I FIORI DEL MALE” una svolta del gusto e della poetica. Egli accentua i caratteri conflittuali tra poeta e società. Si apre così la generazione dei poeti maledetti, personaggi di una vita sregolata, dediti all’alcol e droghe, rifiutando il conformismo borghese. È il maestro del Simbolismo, una tendenza che si sviluppa in Francia negli ultimi anni dell’Ottocento. La poesia simbolista viene rappresentata anche da altri poeti maledetti francesi: Paul Verlaine; Stéphan Mallarmé; Arthur Rimbaud;. Secondo loro il poeta deve farsi veggente per poter esplorare l’ignoto e cogliere l’assoluto. L’intuizione del Simbolismo è che sotto la realtà apparente, si nasconde un’altra realtà misteriosa e profonda. Viene così manifesta la sfiducia verso la scienza, la quale non è capace di penetrare nell’animo umano, né di spiegare i desideri dell’inconscio e il bisogno per gli uomini di esplorare l’ignoto. Il poeta può quindi penetrare attraverso l’intuizione. L’arte è l’unico strumento con cui si può esplorare e rendere accessibile ciò che è ignoto e irrazionale. I simbolisti elaborano un linguaggio nuovo, non più logico, ma analogico, permettendo di portare alla luce le corrispondenze e i legami misteriosi tra le cose. La parola quindi deve possedere una magica virtù evocando una realtà profonda dietro alle apparenze, e deve avere la capacità di comunicare le emozioni del poeta. I poeti simbolisti ricorsero a figure retoriche per esprimere stati d’animo, sensazioni e immagini. Venne anche accentuato l’aspetto musicale del linguaggio, privilegiando il suono rispetto alle parole. Si carica di una forza misteriosa ed evocativa. Secondo Baudelaire la natura è una “foresta di simboli” fatta di corrispondenze di profumi, colori e suoni che il poeta riesce a decifrare e a ricomporre in un’unica realtà.Mallarmé invece sente il privilegio di essere il poeta e di avere accesso ai significati misteriosi dei simboli e delle corrispondenze. I temi della sua poesia sono: l’anelito all’elevazione; evasione dalla vita reale; un’angoscia profonda; l’aspirazione a cogliere le cose; l’essenza intangibile.
La poetica di Verlaine invece è caratterizzata dal gusto del vago e del malinconico; dell’inquietudine; contrasto tra bene e male. Lui sente l’emozione soggettiva e il potere simbolico del linguaggio che diviene evocativo e musicale; è privo di ogni retorica; presenta versi brevi e fluidi.
Arthur Rimbaud invece occupa un posto nel panorama della poetica francese. Esso è convinto che il poeta deve essere veggente, che illumina l’ignoto e sappia penetrare nel profondo delle cose per capirne i segreti. Si arriva a questo grazie al “deragliamento dei sensi” cioè l’abbandono alle visioni che lo fa sentire libero. La lingua deve essere rinnovata e deve esprimere profumi, suoni e colori in una suggestione evocativa fuori dalla semantica ed eloquenza. Secondo lui il poeta è abbandonato a se stesso, come Rimbaud riuscì a dimostrare nel progetto “Il battello ebbro”, incompreso e maledetto dagli uomini comuni perseguitato dalla solitudine, ma conoscitore della libertà non può adeguarsi alla vita comune e alle convenzioni sociali.
per ulteriori approfondimenti sul simbolismo francese vedi anche qua
Simbolismo francese
Il Simbolismo nasce in Francia e si afferma soprattutto in poesia tra il 1876 e il 1890. Il termine rinvia ad una poetica in cui si procede attraverso i simboli: attraverso l'intuizione, il poeta rivela nei particolari l’universale, nel finito, l'infinito. Il Simbolismo rifiuta le pretese scientifiche di spiegazione oggettiva e razionale dell’universo.Negli ultimi anni (1890-1905), il simbolismo confluisce nel Decadentismo. Quest’ultimo nasce come poetica, ma oggi è considerato una forma di cultura e civiltà artistico-letteraria.
Le sue componenti essenziali sono l’estetismo e l’irrazionalismo.
Il termine Decadentismo implica un'idea di decadenza, di consunzione, di tramonto di una civiltà. Venne inizialmente usato per indicare sia la decadenza del romanticismo, sia quella della sana borghesia liberale e positivista che aveva gestito il potere economico e politico fra il 1848 e il 1875. Si trattava dunque alle origini, di un termine negativo che comportava un giudizio morale di condanna nei confronti dell’irrazionalismo e della corruzione morale delle tendenze artistiche e letterarie affermatesi in Europa a partire dagli anni ’80.
Oggi tale implicazione negativa è scomparsa e il termine indica solo la civiltà letteraria e artistica affermatasi in Europa fra i due secoli.
Il Decadentismo fa dell’estetismo, cioè il culto della bellezza e dell’arte la sua principale parola d’ordine, e dell’irrazionalismo la sua ideologia privilegiata.
Sul piano politico gli scrittori decadenti appoggiano le nascenti ideologie nazionaliste e imperialistiche; si deduce quindi che il decadentismo è un fenomeno culturale omogeneo alle nuove tendenze imperialistiche.
Caratteri del decadentismo::
- Rifiuto del metodo scientifico e razionale;
- Soggettivismo e Individualismo ossia: L’arte deve esprimere le sensazioni del soggetto, la sua vita interiore e sensuale;
- La scoperta dell’inconscio ossia: L’arte tende a esprimere le associazioni profonde dell’io, la complessità dei pre-sentimenti e collegare il mistero dell’anima a quello della vita stessa dell’universo;
- Il ricorso al simbolismo, la ricerca di corrispondenze fra l’anima del soggetto e la vita dell’universo, il ricorso alla metafora e soprattutto alla sinestesia.
- L’estetismo e la religione dell’arte: i decadenti affermano non solo la autonomia dell’arte, ma la anche la sua superiorità. Per sostenere il culto della superiorità, promuovono il culto dell’arte, intesa come pura bellezza, ragione di vita e vera e propria religione.
- Una concezione del poeta come artefice supremo o come profeta vate: poiché la poesia è concepita è concepita come rivelazione dell’Assoluto, il poeta è immaginato come il mediatore e il sacerdote di tale rivelazione. L’artista è un inventore e un creatore, non deve più imitare la vita come facevano gli scrittori naturalisti, ma crearla.
Il decandentismo e il simbolismo
Il decadentismo: È una corrente letteraria del fine 800, inizio 900. Si parla di decadentismo in Italia.Questa corrente era basata sul promuovere un’arte antinaturalista, non fondata sul “vero” della realtà, ma sui lati oscuri del mondo e della vita, su quanto sfugge alla ragione (l’inconscio, l’enigma) il decadentismo insiste su elementi irrazionali, come la sensazione o l’intuizione.
Nella corrente del decadentismo si distinguono due fasi:
- La prima fase (circa nel 1875-80) corrisponde al decadentismo irrazionale e ribelle: caratterizzato dall’estetismo, dal culto dalla sensazione, alla “ decadenza” del mondo, uno stato d’animo diffuso tra gli intellettuali di fine 800.
Il decadentismo al contrario del romanticismo non mette al primo posto il sentimento e il cuore ma degli istinti, delle pulsazioni individuali, dell’inconscio. I poeti decadenti usano un linguaggio alternativo, quello dei simboli fase segnata in Francia dai poeti simbolisti (baudelaire).. e in Italia dagli scrittori della scapigliatura milanese: l’avanguardia degli intellettuali antiborghesi e ribelli( Arrigo Boito, Emilio Praga). Nel decadentismo ci fu la partecipazione durature e qualitativa di Giovanni Pascoli e Gabriele D’annunzio.
Alla fine di questa prima fase ci sarà l’esperienza delle Avanguardie del primo Novecento (futurismo, espressionismo, surrealismo..) le quali condividono con il primo decadentismo diversi aspetti: l’atteggiamento della ribellione, affidarsi all’inconscio, agli istinti e anche alla fiducia che la protesta degli intellettuali possa migliorare la realtà. - La seconda fase è quella del Decadentismo di Italo Svevo e Luigi Pirandello. Questo più maturo Decadentismo è orientato a non rimanere fermo nella crisi, ma a conoscerla criticamente: la letteratura deve attestare sostenere la mancanza di certezze e di prospettive, deve rappresentare la debolezza degli individui e della loro coscienza. Il letterato non può cambiare la realtà di fatto, ma la rivela senza più illudersi di poterla migliorare. L’artista si separa dalla società, non è più ribelle( come i romantici) ma più dolorosamente un “inetto” ( Svevo)
quindi il primo decadentismo si orientava alla “poesia”, il secondo privilegiò la prosa, il romanzo come strumento primario per conoscere le cose sbagliate del mondo.
Nel sonetto le corrispondenze, Baudelaire descrive il poeta come uno che sa muoversi nella “ foresta dei simboli” il mondo. Mentre per gli altri tutto è incomprensibile, e il poeta è un “decifratore” un veggente.
I poeti simbolisti hanno l’obbiettivo di trasformare del tutto il linguaggio poetico, proprio per raggiungere quelle zone nascoste della natura e della vita umana che l’indagine scientifica non può toccare.
La poetica del simbolismo si fonda sul valore della parola “ pura” che riporta a una realtà più profonda. Per raggiungerla i simbolisti valorizzano alcune figure retoriche, come la sinestesia ( consiste nell’associare in un unico nesso parole o immagini riferite a differenti sfere sensoriali) o l’analogia ( la messa in relazione di due o più cose distanti fra loro nella realtà). Nello stesso tempo essi rinnovano la metrica e il ritmo dei versi per raggiungere un’insolita musicalità
Il linguaggio dei simbolisti fu un punto di riferimento per la poesia. In Europa i Francesi Paul Valery , Guillaume Apollinaire… mentre in Italia Pascoli, D’annunzio, i poeti vociani, poi anche Ungaretti e Montale.
I decadenti rinunciano a portare avanti il progresso scientifico e sociale e danno importanza al “culto della bellezza” intesa come fine a se stessa e nasce così l’estetismo, cioè la tendenza all’arte per l’arte.
Uno dei prima divulgatori dell’estetismo fu Walter Pater
Quello che importa per l’estetismo è ciò che appare bello, quindi tutto quello che riguarda l’estetica che deve essere bello.
Gabriele D’annunzio fa parte all’estetismo per la sua ambizione di fare la vita come un opera d’arte ( il romanzo il piacere, il superuomo)
Giovanni Pascoli aderisce all’estetismo per il concetto di fanciulllino in cui il poeta è al centro. L’individualismo è ciò che accomuna i concetti di questi due poeti.
Giovanni Pascoli:
- Pascoli nasce il 31 dicembre nel 1855 a San Mauro gi Romagna (Forlì)
- Nel 1867 giorno di san Lorenzo, il padre viene assassinato. La morte del padre verrà ricordata in vari componenti di Pascoli, tra cui X agosto
- 1882 si laurea a Bologna
- Pascoli è chiamato a collaborare alle più importanti riviste, tra cui “ vita nuova “ di Firenze dove nel 1990 appaiono nove sue brevi liriche con il titolo “ Myricae” dove la prima edizione a stampa fu nel 1991
- Nel 1897 escono le poesie ispirate alla vita delle campagne con il titolo “poemetti”
- nel 1903 viene pubblicato il “I canti di Castelvecchio”
- nel 1905 cattedra universitaria a Bologna
- muore a Bologna
Il “nido” domestico e la paura della vita: Pascoli ha avuto una vita povera di eventi esteriori e per paura di far fronte alla realtà e del presente (paura del vivere) si rifugiava nel nido domestico, la sua famiglia.
Per pascoli ci fu il tradimento del nido, quando la sorella Ida si sposa.
Pascoli Assieme all’altra sorella Maria si rifugiarono nella “biocca” di castelvecchio, dove lui incarnò la figura del tenace custode delle memorie della famiglia d’origine che includeva genitori, fratelli e sorelle vivi e morti. “ho vissuto senza amore “così scrive alle sorelle, non per incapacità d’amare ma perché mi dovevo dedicare solo a voi.
Con questi sentimenti dedicò Myricae alla memoria del padre, e i canti di Castelvecchio a quella della madre e i poemetti a Maria.
Confronto con Pascoli e D’Annunzio:
Pascoli: D’Annunzio
- vive isolato - brillante uomo di società
- fede a pochi luoghi
- avventuriero, senza fissa dimora
- avaro, pignolo e propenso
- prodigo nelle spese, capace di all’invidia amicizie, uomo di molti amori e debiti.
- trascorre la vita con eventi quasi solo - vita piena di colpi di scena, e vissuta interiori con l’intenzione di farne “un’opera
- idealizzò il mondo contadino, con i suoi d’arte” valori comunitari, di famiglia, di laboriosità,
- teorizzò il disprezzo della folla e di sobrietà, con rifugiandosi nel nido familiare della gente comune
- pochi uomini superiori
Movimento simbolista
Il simbolismo è una corrente che, come il neoimpressionismo, si pone l’obiettivo del superamento della concezione impressionista, modificandone però non la forma, come i neoimpressionisti erano soliti fare, bensì il contenuto, intendendo questo superamento come un superamento di stampo spiritualistico.Il simbolismo riapre il problema dei contenuti, come già Blake e Füssli avevano sottolineato, sostenendo che la realtà sia a cavallo tra il conscio e l’inconscio e perciò l’arte non dovrebbe rappresentare, bensì rivelare tramite segni. Il dipinto stabilisce quindi una continuità tra l’oggettivo reale e il soggettivo di ognuno, mirando a suscitare riflessioni.
Per la sua componente soggettiva il simbolismo viene influenzato dalla psicanalisi e la pittura diventa a sua volta strumento di analisi della mente umana, studiandone i processi.
Come il neoimpressionismo, il simbolismo rappresenta una delle componenti del modernismo: la sua influenza non si limita alle cosiddette arti maggiori, ma si espande anche alle arti minori quali arredamento e costume, considerando che tutto viene concepito come potenzialmente artistico. Il simbolismo anticipa le la concezione surrealista del sogno, proprio come il neoimpressionismo è l’anticipatore del cubismo.
Simbolismo, riassunto
Il simbolismo, affermatosi principalmente in Francia nella seconda metà dell’Ottocento, è una corrente poetica specifica nel più vasto ambito del Decadentismo europeo in contrapposizione al Naturalismo e al Positivismo. Sul modello di Baudelaire, i simbolisti intendono la poesia come rivelazione dell’essenza più profonda e misteriosa delle cose, non conoscibile né comunicabile attraverso gli strumenti della logica. Essi rinunciano pertanto a raffigurare realtà ben precise e a costruire il discorso in modo razionale, preferendo un linguaggio indefinito, evocativo e allusivo, basato su procedimenti espressivi di tipo analogico e fonosimbolico. I principali esponenti di tale poetica sono Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé.Paul Verlaine: Verlaine (1844-1896) nato a Metz in una famiglia della piccola borghesia, trascorre una vita disordinata, segnata dall’abuso di alcol e da atti di violenza, come l’aggressione nei confronti della madre e il ferimento del giovane amico Rimbaud. I caratteri della sua poesia sono sintetizzati nel componimento programmatico l’ “Arte poetica” (1822): egli esalta la musicalità della parola e punta sull’indefinitezza suggestiva, sull’ “indeciso” e sulla “sfumatura”, mentre rifugge da qualsiasi costruzione formale troppo rigida che limita la libertà espressiva, come la “rima” (la metrica tradizionale, che tuttavia non è del tutto abolita), e l’ “eloquenza” (l’apparato retorico proprio della poesia sostenuta e declamatoria). Sul piano tematico, le raccolte di Verlaine sviluppano alcuni dei motivi tipici del Decadentismo, quali la “noia” esistenziale, la percezione del presente come decadenza, il senso di impotenza nei confronti della storia, la concezione della poesia come esercizio formale raffinato e prezioso ma inutile.
Arthur Rimbaud: Come la vita di Verlaine, anche quella del “discepolo” e intimo amico Rimbaud (1854-1891) è caratterizzata dalla trasgressione e dall’irrequietezza. Dopo una breve e intensa stagione creativa (1870-1875) egli abbandona la letteratura e si trasferisce in Africa, spinto da un radicale rifiuto del mondo borghese: farà ritorno in Francia, già gravemente ammalato, poco prima di morire. Da Baudelaire Rimbaud trae la concezione del poeta come “veggente” che si immerge nell’ignoto e nell’irrazionale rifiutando gli schemi mentali e conoscitivi della tradizione. Da questo atteggiamento deriva il carattere visionario della sua poesia, che basandosi sulla “sregolatezza dei sensi” presenta immagini puramente fantastiche, sciolte da ogni rapporto di verosimiglianza con la realtà, come nel celebre poemetto “Il battello ebbro”. Rimbaud porta inoltre alle estreme conseguenze le analogie simboliche della poetica baudelairiana, giungendo ad individuare il carattere fonosimbolico delle parole, ossia la loro capacità di suggerire col suono effetti di sinestesia e significati estranei alla parola stessa. La letteratura doveva garantirgli la fuga dalla realtà, ma quando si rende che ciò è impossibile, vi rinuncia.
Stephane Mallarmé: La ricerca del Simbolismo decadente trova la sua espressione più compiuta nell’opera di Mallarmé (1842-1899), in particolare nel poema della maturità “Un colpo di dadi non abolirà mai il caso” (1897). Nell’opera la poesia si configura come manifestazione di un bisogno assoluto e di verità destinato a rimanere inappagato per la presenza del “caso”, ossia per l’irrazionalità del reale. Dal crollo di ogni sistema conoscitivo scaturisce il rifiuto della versificazione tradizionale e del suo ordine sintattico e grafico (il testo si legge ad esempio su due pagine contemporaneamente): le parole e i versi, isolati nello spazio bianco della pagina in cui sono immersi, sembrano rappresentare lo sforzo del poeta di appropriarsi della verità nel mistero dell’essere che lo circonda. Riconosciuto dai contemporanei come caposcuola e principale teorico del Simbolismo, Mallarmé apre la via, con la sua sperimentazione grafica e con la sua concezione della poesia, a molte esperienze letterarie del Novecento, tra cui il Futurismo e l’Ermetismo.
Il poeta deve andare al di là del reale, vuole sottrarre la poesia ai condizionamenti e ai limiti realistici sia nei temi sia nei mezzi; la fuga della realtà corrisponde ad una fuga dal modo in cui i naturalisti guardavano alla realtà, cioè oggettivamente. Per Mallarmé bisogna cogliere l’essenza e l’anima delle cose, perciò il poema è un eletto che inizia a questo conoscenza consapevole dell’ineffabilità e inesprimibilità che lo caratterizza. Bisogna evitare ogni tratto realistico, non bisogna definire, in quanto la realtà va evocata e suggerita, bisogna depurare il linguaggio dai detriti della comunicazione quotidiana in modo tale che la forma sia rarefatta, per questo rinuncia ad un intelligibilità immediata. Bisogna inoltre trovare la parola assoluta e attingere l’azzurro bruciando ogni scoria di materialità abbandonando il vissuto; questa ricerca porta al dramma dell’inespresso, ovvero alla difficoltà di esprimersi. È necessario infine riscoprire il potere magico della parole (concezione mistica del linguaggio) e ricorrere al simbolo che si basa sulla soggettività e sull’intuizione.
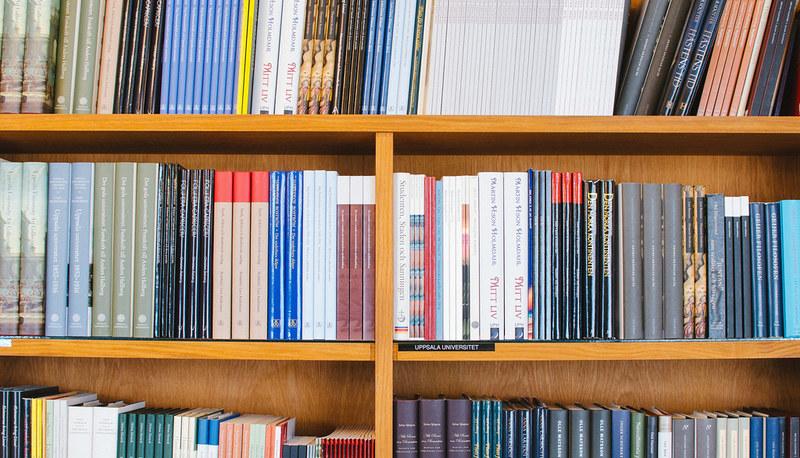
per ulteriori approfondimenti sul simbolismo vedi anche qua
Simbolismo, sintesi
La poesia pura dei Parnassiani: In Francia, tra il 1860 e il 1866, alcuni poeti, a seguito della crisi del Romanticismo, coltivarono l’ideale di una poesia che rifugiasse dal sentimentalismo.Il programma poetico verteva sull’autonomia dell’arte, in contrapposizione al romanticismo, dove la poesia e la narrativa dovevano svolgere una funzione sociale ed educativa. I parnassiani ricercavano una “poesia pura”, fine a se stessa, libera dalle ideologie, dalla storia, capace di rifugiarsi sul Parnaso per allontanarsi dalla realtà.
Baudelaire: le corrispondenze: Charles Baudelaire è considerato il caposcuola della moderna lirica europea. Condivideva con i parnassiani il rifiuto del sentimentalismo e della contaminazione della poesia con argomenti filosofici, morali,politici, sia il culto dell’ “arte per l’arte” , quindi della perfezione stilistica.
I fiori del male: Nella raccolta I fiori del male la realtà, osservata anche nei suoi aspetti più turbi e viziosi, è vista come una “foresta di simboli” di cui spetta al poeta intuire le relazioni, trovando i nessi tra la natura, i sensi e gli stati d’animo.
La frattura storica e il ruolo del poeta nella società moderna: Nella sua opera critica, Baudelaire si interroga sul ruolo della poesia nella società industriale e tecnologica.
Nell’antichità e fino al Rinascimento il poeta era considerato sacro e anche il poeta romantico godeva di grande prestigio, era il “vate”, guida della classe borghese.
Con la società industriale il legame tra il poeta e il popolo si è spezzato: ora è incompreso, perché il suo modo di sentire è diverso da quello della collettività, concentrata sugli aspetti materiali della vita.
A partire da Baudelaire il poeta rinuncia a rappresentare la realtà poiché è sempre più complessa e non può esser spiegata in modo razionale e solo la sensibilità del poeta può coglierne i significati più nascosti.
La magia verbale: Baudelaire potenzia il valore allusivo e la valenza espressiva della parola poetica. Ne deriva una creazione nuova, ricca di analogie e di sinestesie che creano legami inconsueti tra le cose, in un intreccio di stimoli sensoriali.
I poeti maledetti e la poetica del simbolismo: La raccolta di saggi e articoli di Paul Verlaine I poeti maledetti è la presentazione di un gruppo di giovani poeti uniti nel riconoscere Baudelaire il loro maestro. Si incontravano nei caffè parigini e pubblicavano una rivista Il decadente. Il titolo era polemicamente ripreso dall’etichetta dispregiativa coniata per loro dalla cultura ufficiale: “decadenti”, cioè corrotti, sia per il disprezzo per i borghesi che per lo stile di vita stravagante.
In seguito, con il termine Decadentismo si è indicato uno degli orientamenti artistici e letterari nati dalla crisi del Razionalismo e del Positivismo.
Simbolismo e tensione verso l'assoluto: Per questi poeti la verità non è quella che appare, ma tutto ciò che ci circonda è simbolo e ha un significato nascosto. Il poeta è colui che sa penetrare, con l’intuito, l’Assoluto che si nasconde dietro l’apparenza delle cose, che sa cogliere la complessità e il mistero che circonda la realtà.
La poetica dell'analogia: Il filone del simbolismo nacque da Corrispondenze, poesia-manifesto che sintetizza la visione del mondo di Baudelaire: la natura è una “foresta di simboli” e ha un suo proprio linguaggio che il poeta deve intuire e tradurre.
In Italia troviamo Pascoli e D’Annunzio.
Linguaggio analogico e fonosimbolismo: Attraverso l’intuito, una sensibilità superiore, il poeta coglie il mistero della realtà e lo rivela mediante l’analogia.
Lo sviluppo della “magia linguistica” creata dall’analogia conduce al fonosimbolismo, procedimento che usa il suono delle parole per evocare aspetti della realtà. I suoni assumono un significato autonomo: la parola crea suggestioni musicali che arricchiscono l’immagine e trasmettono al lettore sensazioni intense.
La poetica degli oggetti: Il simbolo in Baudelaire diventa allegoria quando consente di trasformare la realtà quotidiana in una “sovra realtà” nella quale il poeta si rifugia: Parigi, per esempio, è l’immagino dello spleen, cioè del vuoto, della noia, dell’angoscia esistenziale, allegoria dell’umana infelicità.
Il poeta “veggente”: Il caposcuola del simbolismo europeo è stato Rimbaud, che sostiene che la realtà è apparenza e il poeta deve riuscire a spingersi oltre, facendosi “veggente” per cogliere le segrete corrispondenze.
Illuminazioni e fonosimbolismo: Il poeta è dotato di una sensibilità fuori dall’ordinario e deve attingere all’ “ignoto”. A questo nuovo compito deve adeguare i propri mezzi espressivi attraverso la poetica delle “corrispondenze”, creando una poesia fonosimbolica, capace di evocare sensazioni inedite e significati misteriosi.
La poesia pura e la rivoluzione del linguaggio: Con Mallarmé, la poesia, avvolta da un alone mistico, diventa un valore assoluto, “poesia pura”.
Descrizione del simbolismo
Si presenta come tendenza dominante che si sviluppa a partire dal 1876,Quando Mallarmé scrisse l'après midi d'un faune, che viene considerato il testo base, ovvero il manifesto del simbolismo. Se si guardano le date, si nota che simbolismo e naturalismo convivono per un certo periodo, ma sono inconciliabili.
Caratteristiche del simbolismo europeo:
- Procedere per simboli
- Utilizzo dell'intuizione che, dal particolare porta all'universale.
- Il poeta può accedere all'universale solo utilizzando la sua componente irrazionale.
- Rifiuto del metodo scientifico.
Gli autori fondamentali sono Rimbaud, Verlaine e Mallarmé
Caratteristiche:
- rinunciare alla ragione;
- regolamento dei sensi;
- soggettivismo assoluto;
- verità oscura;
- poesia come assolutezza.
Decadentismo: Tra 1890 al 1905 il simbolismo va a confluire nel decadentismo. Il termine nasce da una poesia di Verlaine. Il decadentismo al contrario del simbolismo, è una vera e propria forma di cultura e di civiltà artistico-letteraria che ama tutti i periodi storici di decadenza perché si ritiene che essendo stati decadenti abbiano in sé qualcosa di languido, molle e debole.I decadentisti amano questi periodi di decadenza. Il simbolismo è la poetica del simbolismo.
Il manifesto del decadentismo è "A rebour" di Huysman.
Il termine decadentismo nasce con un'accezione negativa: periodo e attività culturale decadente, marcia, che sta morendo. Gli autori di questo periodo manifestano un particolare amore nei confronti delle società in decadenza.
Attualmente il termine non ha accezione positiva o negativa, è solo neutro.
Il decadentismo ebbe portata europea:
Il piacere di d'Annunzio (1889)
Myricae di Pascoli (1891)
Caratteristiche fondamentali del decadentismo in Europa:
- Le parole chiave sono irrazionalismo estetismo.
- L'ultimo è il culto dell'arte, del bello.
- Opposizione al positivismo e al naturalismo.
- Senso di estenuazione, negatività nel confronti della vita.
- Rifiuto del metodo razionale.
- Soggettivismo e individualismo.
- Scoperta dell'inconscio.
- Poeta visto come artefice supremo o vate colui che indaga l'assolutezzade della realtà.
- Estetismo, ovvero Arte per Arte.
- Ricorso al simbolismo: analogia, metafora e sinestesia.
1863-1938 nasce a Pescara da una famiglia borghese.
Poetica: il suo tratto fondamentale è lo sperimentalismo legato al suo carattere, alla sua sete di novità e al tentativo di essere sempre attuale, alla pari. I gusti si spostano dall'estetismo al romanzo introspettivo-russo e scrive L'Innocente.
●Prima fase: Fase giovanile. Influenzato da verismo e da simbolisti francesi. Fase in cui scriver Primo Vere a 16 anni.
●Seconda fase: Estetismo. (Culto di raffinatezza e bellezza a prescindere della morale.) 1889 pubblica Il Piacere.
●Terza fase: Pentimento. Dura poco. scrive Innocente e Giovanni Piscopo. (Si ispira ai romanzi russi)
●Quarta fase: fase cruciale. Superomismo e panismo.
●Quinta fase: Fase del Notturno.
Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo
Questo periodo ha inizio in Europa nel 1849, quando si conclude il movimento rivoluzionario per l’indipendenza nazionale. Termina agli inizi del Novecento in corrispondenza con la Seconda Rivoluzione industriale. In Italia invece si afferma negli anni dell’Unità (1861) e termina nel 1903, quando Giolitti è al potere aprendo la fase della democrazia.Sul piano letterario, le due tendenze dominanti sono il Naturalismo e il Simbolismo che nascono in Francia. Il movimento del naturalismo deve il suo nome alla concezione secondo cui l’uomo è determinato dalla natura, ovvero dagli istinti, dai bisogni materiali e dall’ambiente in cui vive. Il movimento del Simbolismo invece rifiuta le spiegazioni scientifiche e razionali dell’universo. Il poeta simbolista preferisce procedere in modo intuitivo e simbolico.
Verso la fine del secolo, il simbolismo viene assorbito dal decadentismo, un fenomeno molto più vasto di un movimento letterario. Rappresenta un’intera forma di cultura e di civiltà artistica che si ispira al culto della bellezza e dell’arte. Inizialmente però questo termine indicava gli aspetti negativi perché associato a decadenza e logoramento.
I temi della letteratura e dell’arte: in questo secolo trionfa la modernità, sconvolgendo tutti i tradizionali riferimenti e il modo stesso di sentire e percepire la vita. Il treno, il telegrafo, il telefono, l’automobile trasformano il modo di vivere lo spazio e il tempo, rendendo più agevoli le comunicazioni e i trasporti.
L’idea di progresso diventa di senso comune e si fonda sulla convinzione che il miglioramento materiale derivante dalle scoperte scientifiche coincida con quello intellettuale. Si esalta tutto ciò che è giovane e nuovo e si condanna ciò che è vecchio e che impedisce il progresso.
Il progresso provoca anche disagi e scontentezze, poiché provoca ingiustizie e sembra sacrificare la parte spirituale dell’uomo, la sua aspirazione alla felicità che non può essere raggiunta solo attraverso miglioramenti materiali.
In Italia, Verga condivide l’idea generale di progresso come evoluzione naturale, ma poi dedica il suo interesse a coloro che ne sono le vittime. Pirandello, riflettendo sulla tecnologia, deriderà il senso comune di chi vede in queste innovazioni, una maggiore possibilità di felicità per l’uomo.
Non solo il progresso ma anche il nuovo protagonismo delle masse può presentarsi in forme terrorizzanti. La massa di lavoratori che inizia ad organizzare e tentare di mettere in pratica gli ideali socialisti, preoccupa la borghesia.
Un’altra ragione di disorientamento all’interno della borghesia è la donna. In una società di massa la donna gode di una libertà prima sconosciuta, comincia ad essere sempre più presente a scuola in qualità di insegnante o negli uffici come impiegata, ponendo le condizioni per una ridefinizione del suo ruolo sociale e della sua identità.
La crisi del ruolo dell’artista: In un mondo in cui contano solo il denaro e il commercio diventa faticoso dedicarsi all’arte. Gli scrittori, i poeti e gli artisti devono fare i conti con la perdita della propria funzione privilegiata. L’unico modo per avere successo è vendersi al pubblico e trasformare l’arte in merce. Per questo motivo l’artista si paragona ad una prostituita o una ballerina, perché vendono ciò che non dovrebbe essere venduto. L’arte per vendersi deve esibirsi, sedurre con tecniche che fingono naturalezza e spontaneità. Per vendere l’opera bisogna tener conto di chi si ha di fronte. Tutto ciò però provoca nell’artista un senso di disagio perché essi vengono declassati.
Nella vita il cultore della bellezza è il Dandy, colui che ostenta eleganza e ricercatezza, contro l’arroganza della borghesia. In Italia il dandismo penetra con gli scapigliati, un gruppo di giovani scrittori che assumono un atteggiamento di poeti maledetti. A prevalere in Italia però è un modello opposto, ovvero quello di Carducci che cerca di affermarsi come educatore. Dopo di lui, D’Annunzio invece si confronta con la massa, lusingandola per ottenere e disprezzandola dichiarandosi superiore. Si parla di divismo. Il divo è colui che ha alle spalle una vera industria e il suo scopo è vendere.
Romanzo per la massa e poesia per l’èlite: Nel sistema dei generi letterari il fenomeno più significativo è rappresentato dal successo e dalla diffusione del romanzo. Questo successo è dovuto al fatto che il romanzo realista e naturalista fa ricorso ad un linguaggio comune. Per la poesia si registra il fenomeno opposto: il suo linguaggio è raffinato e complesso e si rivolge ad un pubblico selezionato. Una volta realizzata l’unità politica, occorre realizzare anche un’unità linguistica. Ma l’alto numero di analfabeti, la debolezza del sistema scolastico e la prevalenza dei dialetti, fanno dell’italiano una lingua correttamente parlata solo in Toscana e fra parlato e scritto resta una profonda differenza.
Colui che cerca di trovare una soluzione al problema è Manzoni, che propone di imporre all’intera nazione l’uso del fiorentino parlato dai toscani colti. Ma questa proposta non riesce a raggiungere i risultati sperati per le obbiezioni provenienti dall’alto.
Le correnti filosofiche: L’Ottocento è il secolo del positivismo, una corrente filosofica che esalta la conoscenza scientifica e l’osservazione sperimentale, crede che l’uomo sia profondamente determinato dall’ambiente in cui vive, considera il progresso come un’evoluzione fondata sulla lotta per la vita. Il positivismo è strettamente legato alle teorie di Darwin che si possono sintetizzare in due punti:
- la lotta per l’esistenza e la selezione naturale distruggono le specie deboli, ma ne costituiscono di nuove e rafforzano quelle che sopravvivono; all’interno di ciascuna specie si realizzano variazioni organiche prodotte dal rapporto con l’ambiente.La teoria di Darwin viene interpretata anche in senso filosofico e sociale e si chiama Darwismo Sociale.
- Alla fine del secolo si registra una violenta rottura con la cultura positivista. Il pensiero passa esaltazione delle scienze alla dichiarazione del sua rovina. Mentre il Positivismo partiva da fatti materiali, Nietzsche afferma che non esistono fatti in sé ma esiste solo la loro interpretazione, relativa e parziale. Inoltre egli nega l’utilità della storia perché tutto è un ciclo che si ripete secondo la legge dell’eterno ritorno.
Decadentismo, estetismo e simbolismo
Decadentismo: Il decadentismo, si afferma tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 (belle époque), in Francia. Il termine decadentismo, deriva da dècadent, aggettivo con cui Verlain descrive la sua posizione nella società. Questo termine era usato in tono dispregiativo, per indicare i poeti che rifiutavano la morale borghese e si ponevano al di fuori della norma sia nella produzione sia nella vita. Insomma, per loro questo termine indicava la loro diversità. Il movimento letterario si diffuse in molti paesi su rifiuto della tradizione letteraria precedente. Con il decadentismo, vediamo il formarsi di alcuni personaggi filosofici/scientifici. Lo scientifico Freud, metteva in dubbio lo stesso io cosciente, definendo tre livelli Es, Super-io, Io. L’es corrisponde agli istinti più profondi, le paure e i traumi. Il super-io corrisponde agli insegnamenti che ci vengono dati fin da piccoli l’Io è la parte cosciente, l’identità. Il mancato equilibrio di queste tre livelli genera patologie psichiche. Egli formula quindi teorie su: il significato dei sogni (lapsus e atti mancati), separazione tra lato cosciente e incosciente, pulsioni dell’Io profondo cioè rappresentanze psichiche di stimoli all’esterno del corpo (es. quelle erotiche).Albert Einstein invece, era un fisico che formulò la teoria della relatività basata sull’equivalenza tra: massa&energia e tempo&spazio. Nietzsche invece, formulò la teoria del superuomo cioè un uomo nuovo libero dalla morale e in grado di fare qualsiasi cosa per realizzare totalmente sé stesso.
Tra le figure più celebri della letteratura decadente troviamo: l’esteta o il dandy, il superuomo, la donna ambigua e sensuale (femme fatale).
Simbolismo: I poeti simbolisti, Paul Verlain, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé, diedero vita a numerose riviste, e videro come loro maestro il poeta Charles Baudelaire che aveva pubblicato "i fiori del male” opera che aveva suscitato scandalo per le tematiche forti affrontate. Il nome del movimento deriva da un'idea del mondo come una rete di simboli mediante la quale il poeta evoca una profonda, ricostruendola su una trama di analogie corrispondenze. Ammessa l'impossibilita conoscere la realtà vera mediante l'esperienza, la ragione, la scienza, si pensa che soltanto la poesia, per il suo carattere possa cogliere le analogie che legano le cose, scoprire la realtà che si nasconde dietro apparenze esteriori. Al poeta è dunque affidato un compito particolarmente importante: il poeta deve farsi veggente attingere al senso profondo del reale, guardare e vedere ciò che gli uomini comuni non possono vedere. Se la realtà è mistero, se la natura è una "foresta di simboli” allora il linguaggio della poesia dovrà cambiare, ricorrere a tecniche come il simbolo, l'analogia, la sinestesia, l'uso sapiente degli spazi bianchi, dovrà ricercare nella parola la musicalità capace di evocare. L'autore italiano più vicino al Simbolismo G. Pascoli.
Estetismo: Il principio dell’estetismo è “arte per l’arte”, che esalta il valore della bellezza artistica. Si traduce nel rifiuto del realismo. Secondo l’estetismo, il poeta deve vivere la sua vita come un’opera d’arte cioè come se fosse una manifestazione artistica, da qui nasce la figura dell’esteta o dandy, persona che fa della propria vita una continua ricerca del bello, anche nella quotidianità. L’esteta odia la vita comune, ha un’attrazione per la mondanità e per gli oggetti inutili e preziosi. Tra i più grandi esponenti troviamo D’Annunzio, Wilde e Huysmans.
Il simbolismo tedesco
Un altro movimento molto importante in letteratura è stato senz'altro il simbolismo tedesco che si è affermato nel periodo di tempo compreso tra il 1890 e il 1920 e si tratta di una letteratura principalmente anti-realistica che si occupa di produrre una tipologia di "poesia pura". Nelle poesie degli intellettuali simbolisti tedeschi vi sono degli elementi come ad esempio la suggestione evocata dalle parole, la suggestione stessa dei simboli. Lo stesso scrittore simbolista tedesco è colui che mediante le sue opere letterarie ha come obiettivo quello di trasmettere emozioni uniche e dei veri propri sentimenti andando a colpire la sfera più intima che si nasconde nelle cose stesse. Gli scrittori simbolisti più significativi sono Frank Wedekind, operante in ambito letterario tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento; Stefan George, operante anch'egli sempre a cavallo tra Ottocento e Novecento; Rainer Maria Rilke, sempre operante tra Ottocento e Novecento.Domande da interrogazione
- Qual è l'origine del movimento simbolista e chi ne è stato il fondatore?
- Quali sono le principali caratteristiche della poesia simbolista?
- Come si differenzia il simbolismo dal decadentismo?
- Chi sono i principali esponenti del simbolismo francese?
- Qual è il ruolo del poeta secondo la poetica simbolista?
Il movimento simbolista è nato in Francia e la sua fondazione è attribuita alla pubblicazione del Manifesto del Simbolismo da parte del poeta francese Jean Moréas il 18 settembre 1886.
La poesia simbolista si caratterizza per l'uso di un linguaggio analogico, l'accento sulla musicalità, e l'evocazione di una realtà profonda e misteriosa attraverso simboli e corrispondenze.
Il simbolismo si concentra sull'esplorazione dell'ignoto e dell'assoluto attraverso l'intuizione e i simboli, mentre il decadentismo è una forma di cultura artistico-letteraria che enfatizza l'estetismo e l'irrazionalismo, spesso associato a un'idea di decadenza.
I principali esponenti del simbolismo francese includono Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé e Arthur Rimbaud.
Secondo la poetica simbolista, il poeta deve farsi veggente per esplorare l'ignoto e cogliere l'assoluto, utilizzando l'intuizione per rivelare le corrispondenze nascoste tra le cose e comunicare le emozioni attraverso un linguaggio evocativo e musicale.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo