Concetti Chiave
- L'Infinito di Leopardi è una lirica giovanile che riflette il profondo legame del poeta con il colle di Recanati, evocando un senso di serenità e riflessione attraverso la contemplazione del paesaggio.
- Il componimento è costituito da quindici endecasillabi sciolti, suddivisi in due parti: la prima parte esprime inquietudine e la seconda dolcezza, attraverso immagini visive e uditive.
- Leopardi utilizza contrasti tra finito e infinito, evidenziati attraverso l'uso di dimostrativi come "questo" e "quello", e figure retoriche come l'enjambement e l'ossimoro, per ampliare il senso di vastità.
- La poesia esplora i temi dello spazio infinito, del tempo e del silenzio, offrendo al lettore un'esperienza di smarrimento e dolce abbandono nell'immaginazione dell'infinito.
- L'Infinito è un esempio di idillio leopardiano che supera i limiti concreti per evocare una grandiosa avventura spirituale, dove l'ostacolo visivo della siepe diventa un catalizzatore per l'immaginazione e la riflessione sul concetto di eternità.
Il poeta riporta nei versi, così come fa in tutti i suoi idilli, i suoi stati d'animo; in questo caso il suo stato d'animo sembra uno stato di serenità derivante dalla contemplazione del paesaggio che lo circonda.
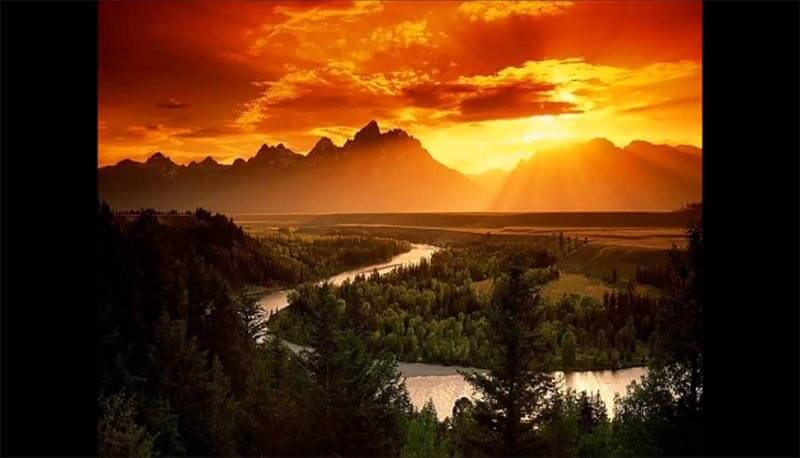 Attorno a lui vede l'infinito che è spiegato attraverso importanti assonanze come le seguenti: "interminati", "sovrumani", "mare". L'indefinitezza è un elemento molto evidente in questo idillio leopardiano e questa sensazione di indefinito, il lettore della poesia lo può scorgere in tutta la lirica. Inoltre l'idillio rende anche l'idea del visivo attraverso la descrizione del paesaggio recanatese circostante.
Attorno a lui vede l'infinito che è spiegato attraverso importanti assonanze come le seguenti: "interminati", "sovrumani", "mare". L'indefinitezza è un elemento molto evidente in questo idillio leopardiano e questa sensazione di indefinito, il lettore della poesia lo può scorgere in tutta la lirica. Inoltre l'idillio rende anche l'idea del visivo attraverso la descrizione del paesaggio recanatese circostante.Indice
L'Infinito di Giacomo Leopardi
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,e questa siepe, che da tanta parte
de l'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio;
e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Parafrasi l'Infinito: Sempre caro mi fu questo solitario colle e questa siepe, che mi impedisce per la gran parte lo sguardo. Ma rimanendo seduto e osservando questi spazi senza fine al di là, sovrumani silenzi, in profondissima calma io nel mio pensiero mi fingo; dove per poco il cuore non si spaventa. E come il vento agita queste piante io quell'infinito silenzio a questa voce vado comparando: e arriva l'eterno,
e le stagioni morte, e la presente e attuale, e il suo suono. Così tra queste immensità si perdono il mio pensiero; e il naufragare mi è dolce questo mare.
Spiegazione: “L’infinito” è un idillio scritto da Giacomo Leopardi.
L’idillio è una rappresentazione poetica di un’avventura dell’animo che nasce da un’esperienza concreta.
Leopardi scrive questo idillio sul monte Tabor a Recanati. Una siepe gli impedisce la vista del paesaggio, e così si immagina uno spazio immenso.
Questo idillio è composto da quindici versi non in rima. “L’infinito” di Leopardi può essere suddiviso in due parti: la prima comunica un senso di inquietudine (interminati spazi, sovrumani silenzi, il cor non si spaura), mentre la seconda comunica un senso di appagante dolcezza (sempre caro, profondissima quiete, il naufragar m’è dolce in questo mar).
Nella poesia sono presenti tre temi: lo spazio infinito, il tempo e il silenzio.
Il testo de L'Infinito è anche caratterizzato da immagini visive come la siepe, e percezioni uditive come i sovrumani silenzi e la profondissima quiete.
Metro: idillio di versi endecasillabi sciolti.
Analisi de L'Infinito
Al poeta fu sempre caro il colle che sorge verso Recanati (monte Tabor, collina solitaria) su cui era solito rifugiarsi per contemplare e riflettere. Sul colle cresceva una siepe che impediva la vista del paesaggio più lontano. Come per tutti i grandi uomini, per Giacomo Leopardi ogni limite è una sfida quindi egli immagina un mondo vastissimo oltre la siepe.Anzi supera i confini del mondo e pensa all’infinito spazio dell’universo, che l’uomo può intuire ma non comprendere
pienamente. Il rumore del vento fra i rami della siepe ricorda al poeta il momento in cui sta’ vivendo momento che possa per un attimo per definizione scivolare nel passato.Il poeta ripensa allora all’età trascorsa fino alle prime ere geologiche della terra ed arriva all’intuizione dell’eternità. L’infinito e l’eterno lo sconvolgono e danno alla sua mente la sensazione dolorosa e dolce al tempo stesso di affondare, di perdersi.
per ulteriori approfondimenti sull'Infinito di Giacomo Leopardi vedi anche qua
L'Infinito, spiegazione
L'Infinito è una poesia scritta da Giacomo Leopardi tra il 1818 e il 1821, durante il suo soggiorno giovanile a Recanati, e appartiene alla serie di scritti pubblicati nel 1826 con il titolo di Idilli. L’opera trova nel suo stesso titolo il tema che verrà sviluppato. Un colle solitario, una siepe e il vento infatti non costituiscono solo gli elementi di un sereno paesaggio, ma diventano lo spunto di un’incredibile esperienza, che porta il poeta a percepire, attraverso l’immaginazione, il concetto dell’infinità del tempo e dello spazio, dando prova della grandezza della mente umana, che, pur così limitata, riesce ad intuire l’intero universo, senza dimensioni e confini.Il testo, composto da un’unica strofa di 15 versi, si sviluppa in due parti. La prima, costituita da sette versi e mezzo in cui prevalgono i dati visivi, si apre con la descrizione di una siepe che costituisce un ostacolo alla visione dell’orizzonte; tuttavia è proprio questo ostacolo che permette di mettere in atto l’immaginazione per la quale, varcando il limite materiale, si possano creare spazi interminati e silenzi al di là dell’umano. Dunque la percezione di un elemento concreto, come una siepe, suscita un moto dell’animo, ovvero l’immaginazione dell’infinito spaziale, a cui segue un senso di smarrimento.
La seconda parte, simmetrica alla prima e costituita anch’essa da sette versi e mezzo, si centrata sui dati uditivi, come il rumore del vento, che suscita un nuovo slancio verso l’infinito ,questa volta temporale, e un nuovo moto dell’anima, ossia la dolcezza dell’abbandonarsi completamente in esso.
L’oscillazione continua fra la realtà e l’infinito è sottolineata anche dall’uso dei dimostrativi, il poeta utilizza infatti “questo” per ciò che è o sente vicino e “quello” per ciò che è o sente lontano.
In 10 versi su 15 Giacomo Leopardi utilizza l’enjambement, che ha una duplice funzione, da una parte infatti modifica il ritmo dei versi, dilatandoli e assecondando così la proiezione verso l’infinito dell’animo del poeta; dall’altra pone in evidenza alcune parole chiave che rimandano di nuovo al concetto di infinito.
Simile è l’obiettivo delle scelte lessicali effettuate da Leopardi, infatti la maggior parte dei vocaboli che appartengono all’area semantica dell’infinito sono almeno di tre sillabe (orizzonti, interminati, sovrumani, profondissima, immensità, infinito), mentre quelle che fanno riferimento alla realtà percepibile con i sensi, sono per lo più di due sillabe e producono quasi una contrazione del ritmo (caro,colle, siepe,vento, guardo).
Particolarmente significativo è l’ ultimo verso in cui compaiono ben due figure retoriche di significato, ”naufragar m’è dolce in questo mare” contiene infatti una metafora che paragona l’infinito al mare, e un ossimoro per indicare che l’esperienza dell’annullamento di sé, apparentemente negativa, si rivela in realtà dolcissima.
Un’altra scelta che contribuisce in modo efficace a sottolineare il tema è l’uso prevalente del gerundio, modo indefinito che elimina quindi la dimensione temporale della poesia.
per ulteriori approfondimenti vedi anche qua
L'Infinito, parafrasi
Sempre caro mi fu questo colle solitario e questa sepie, che al mio sguardo impediva la vista dell'orizzonte, ma sedendo e osservando , nella mia mente immaginavo immensi spazi e silenzi mai conosciuti dall'uomo,che per poco il mio cuore non si smarrisce.Il rumore del vento che sfiora le piante lo paragono all'infinito silenzio, ma mi viene in mente l'eternita del tempo e l'età che pulsa di vita , così che smarrisco il mio pensiero sprofondando nel mar dell'infinito.
L'Infinito, commento
L'infinito spaziale, così quell'interruzione del silenzio lo richiama allo scorrere inesorabile del tempo e allo struggimento per l`infinito temporale, cioè per l`eternità. E il poeta si abbandona dolcemente in questa nuova dimensione, trovandovi una sorta di annulamento. Composta nel 1819, la lirica, che fa parte dei cosidetti Piccoli idilli, è la testimonianza di una grandiosa avventura spirituale. Infatti, percepire l'infinito significa per il Leopardi evadere da una realtà circoscritta e limitante, simboleggiata dalla siepe e dalla voce del vento, per perdersi, sullo slancio del pensiero e della fantasia, oltre ogni limite, in un infinito in cui è dolce smarrirsi per sempre, quasi perdersi nel nulla e trovare un attimo, quasi eterno, di conforto dai mali.per ulteriori approfondimenti sul commento all'Infinito di Giacomo Leopardi vedi anche qua
L'Infinito, descrizione
Durante gli anni 1819-1820, Giacomo Leopardi compose “l’infinito”, poesia che fa parte dei piccoli idilli e di cui eseguirò l’analisi testuale.Per comprenderne meglio il contenuto svolgerò prima la parafrasi del testo.
-Questo colle e questa siepe mi furono sempre cari, che sottraggono alla mia vista tanta parte del lontano orizzonte.
Ma, mentre sto seduto a contemplare, immagino nella mia mente sconfinati spazi al di là di quella siepe e sovrumani silenzi e una profondissima calma; per cui il cuore prova quasi un senso di sgomento. E non appena sento il vento frusciare tra queste piante, io paragono quel silenzio infinito con questo rumore; e mi viene in mente l’eterno, e il tempo passato, e il tempo presente che pulsa dei rumori della vita. Così il mio pensiero sprofonda nell’immensità dell’infinito: ed è dolce per me affondare e annullarmi in questo mare.
Questa lirica è composta da endecasillabi sciolti, ovvero senza rime. Per permettere al poeta di avere maggiore libertà di espressione. Il tema del componimento è la meditazione sull’infinito che viene paragonato al finito. È un continuo passare dal finito all’ infinito; la poesia, infatti, inizialmente tratta del finito facendo riferimento alla siepe che porta il poeta ad immaginare cosa c’è dietro, mediante il fruscio del vento si torna a parlare del reale ed infine ancora dell’infinito, nel quale il poeta si immerge completamente. Per indicare la vicinanza e la lontananza dal finito o dall’infinito vengono usati gli aggettivi questo e quello che inizialmente pongono il finito vicino al poeta, mentre negli ultimi versi si capovolge la situazione poiché troviamo “questo” riferito al mare che indica l’infinito.
Inoltre, quando si parla di finito, troviamo parole monosillabiche o bisillabiche, quando invece si parla dell’infinito, vengono usate parole più lunghe al plurale, proprio per indicare l’immensità dello spazio. Si può rintracciare nel testo la prevalenza della vocale A (tanto, caro, interminati, sovrumani, profondissima, immensità) che rappresenta l’ampiezza, riferita certamente all’infinito.
Tra le figure retoriche presenti nel testo troviamo una metafora nell’ultimo verso, in cui l’infinito è chiamato “mare” e sempre nell’ultimo verso c’è un ossimoro (il naufragar m’è dolce), cioè l’accostamento di due parole di significato opposto. Nei quindici versi sono presenti ben dieci enjambements e hanno la funzione di mettere in evidenza le parole che danno l’idea di infinito. Sono anche presenti delle inversioni.
“L’infinito” di Leopardi può essere paragonato a “alla sera” di Foscolo poiché entrambi gli autori riflettono su problemi esistenziali attraverso la rappresentazione di paesaggi naturali. Sia Foscolo che Leopardi si riferiscono rispettivamente alla sera e all’ermo colle con appellativo “caro”;entrambi fanno delle riflessioni mediante le immagini naturali della sera e del colle; Foscolo contemplando la sera prova serenità e pensa al nulla eterno che segue la morte e Leopardi contemplando il colle e la siepe prova una calma che si trasforma addirittura in sgomento.
I due poeti trattano anche del trascorrere del tempo: Foscolo usa l’espressione “reo tempo” e Leopardi “morte stagioni” per riferirsi alla storia e quindi al tempo passato.
per ulteriori approfondimenti vedi anche qua
Analisi del testo L'Infinito
Composto fra la primavera del 1819, questo idillio è perfetto perché libero da intrusioni intellettualistiche. Superando una situazione concreta, il poeta trova la forza di crearsi grandi illusioni e di erigersi sopra la ragione. Il luogo della riflessione e il monte Tabor di Recanati che nella lirica appare lontano dalla realtà, e ci troviamo nel mondo della fantasia. La siepe rappresenta l'impedimento, la forza che pone dei limiti alla conoscenza dell'uomo ma gli permette di spaziare con la fantasia. Si costruisce col pensiero spazi interminabili che si estendono al di là della siepe. La fantasia ha dato libero spazio al sentimento creando una pace e una immobilità divine. Il vento che passa fra le foglie e le fa stormire rappresenta un lieve sussurro se paragonato all'immaginato sovrumano silenzio. La poesia è una fuga fantastica, ci proietta in questa realtà concreta (il colle e la siepe). Colle e siepe sono cari perché impediscono la vista, spingendo ad immaginare. L'uomo non vedendo con gli occhi, è invitato a vedere con la mente. Tale è la grandezza degli spazi che il cuore sobbalza, dà sensazione di smarrimento. Mente e cuore, abituati a vivere nel finito, quasi si smarriscono nell'infinito. L'esperienza di questo canto dà all'uomo l'illusione del piacere infinito cui esso aspira. è una poesia consolativa: consola l'uomo in quanto non potrà mai raggiungere il piacere infinito.L'Infinito, riassunto
Introduzione: Il ciclo della produzione poetica di Leopardi si articola in quattro periodi:- Poesia giovanile;
- Canzoni civili e i Piccoli Idilli;
- I Grandi Idilli;
- Il ciclo di Aspasia.
Il termine idillio ha origine dal greco e significa piccolo quadro. Un idillio ha lo scopo di descrivere la vita pastorale.Quello di Leopardi è un altro tipo di idillio, è un'affezione, che rievoca il passato. E' una poesia libera da tutto ciò che è erudito. E' semplice e pura.
L'Infinito: L'Infinito è un'avventura della mente. L'uomo cerca l'infinito per evadere dalla realtà. Il poeta è sopra un colle e c'è una siepe che gli impedisce di vedere oltre. Ma è proprio quest'ostacolo a permettergli di immaginare cosa c'è aldilà.
Il componimento può essere diviso in due parti perfettamente simmetriche:
- vv. 1-8: sensazione visiva che dà l'input all'immaginazione;
- vv. 8-15: sensazione uditiva che dà l'input alla possibilità di percepire un infinito temporale;

Il componimento è costituito da 15 versi di endecasillabi sciolti. C'è una forte iterazione del polisindeto , ovvero il ricorso alla ripetizione della congiunzione. C'è inoltre un ricorso alla ripetizione dei dimostrativi (per esempio: quest'ermo colle). Impiego dell'ossimoro, ossia l'associazione di due termini tra loro contrastanti (E il naufragar m'è dolce in questo mare). E' un componimento frutto del Limae Labor.
L'Infinito, sintesi
È il risultato più alto del primo periodo della produzione di Giacomo Leopardi. Si tratta di 15 versi endecasillabi. Sono 15 versi in cui Leopardi riesce esprimere alcuni concetti con straordinaria musicalità, il nucleo di sentimenti e emozioni che saranno alla base di tutta la poesia. In questo trattato viene trattata l'esperienza dell'infinito dell'autore, che anticipa il tema della teoria del piacere. Il desiderio di piacere infinito non può trovare appagamento in un oggetto reale che di per se è limitato, ma può trovare appagamento momentaneo nell'immaginazione, sollecitata da sensazioni indefinite o da un ostacolo, cioè la siepe. C'è un collegamento tra la teoria del piacere è il seguente idillio. L'esperienza dell'infinito appaga questo piacere. L'idillio si può dividere in due momenti:- Va dal verso 1 al verso 8: il primo momento dell'esperienza dell'infinito è l'esperienza dell'infinito spaziale. Questa prima esperienza arriva a turbare a suscitare sgomento nell'autore.
- Va dal verso 8 al verso 15: la voce del vento prendete suscita nel poeta il paragone con l'infinito temporale.
Verso 2/verso 3: questa siepe, che da tanta parte : lo sguardo era impedito dalla siepe.
Verso 4/7ma osservando bene nella mia mente/immaginazione mi mangino/creo spazi infiniti, illimitati, immersi in un silenzio incredibile.
Verso 8: dove il mio cuore per poco non si spaventa e io provo sgomento. Questa è la prima esperienza dell'infinito spaziale.
Verso 8: la voce del vento che fa stormire queste foglie riporta il poeta alla realtà, lo distoglie da quell'esperienza e paragono quel l'infinito silenzio che avevo immaginato a quegli spazi infiniti a questa voce reale del vento e riflettendo su questo affiora alla mia mente l'eterno (eternità, cioè l'infinito temporale) e le morte stagioni (il passato) la presente e viva (il presente, l'oggi). Il passato è il presumere sono destinati a svanire in questo infinito temporale. Così in questa meditazione sul l'infinito il mio pensiero si smarrisce e si smarrisce piacevolmente. E mi è piacevole sperdersi in questo mare dell'infinito. Per un momento Leopardi prova un'esperienza statica con un'estasi psicologica. Non c'è niente dei religioso. Il discorso appare consequenziale però se si analizza più attentamente si nota che è composto da 4 periodi ben distinti che sono in corrispondenza l'una con l'altra. Abbiamo 4 parti ben correlate in corrispondenza l'una con l'altra. Il primo e l'ultimo periodo sono composti quasi da uno stesso numero di versi e sono caratterizzati dalla paratassi e nel primo e nell'ultimo verso abbiamo in posizione evidente un verbo che indica un sentimento. E troviamo delle entità paesistici che però sono diversi: il paesaggio dei primi versi è fisico è reale, mentre quello dell'ultimo periodo sono metafisici. Abbiamo una sorta di percorso dalla realtà all'immaginazione. Dell'infinito sono state fatte 11 stesure. I due periodi centrali sono più lunghi e sono anche più mossi e complessi, sono più dinamici, raccontano proprio l'esperienza dell'infinito. Nelle scelte lessicali troviamo dei segnali di infinito, ci sono parole piacevoli e poetiche: ermo, silenzio, morte... Sono parole che non hanno un significato facilmente definibile. Ci sono parole che sembrano incarnare l'idea di infinito: orizzonti, indeterminata, sovrumana (sono parole lunghe e in genere anche superlativi). Ci sono parole che danno l'idea di apertura (parole che hanno la vocale tonica a).
Domande da interrogazione
- Qual è il significato principale de "L'Infinito" di Giacomo Leopardi?
- Come è strutturata la poesia "L'Infinito"?
- Quali sono i temi principali trattati ne "L'Infinito"?
- Qual è il ruolo della siepe nella poesia?
- Quali figure retoriche sono utilizzate ne "L'Infinito"?
"L'Infinito" di Leopardi esplora il concetto dell'infinito spaziale e temporale, utilizzando l'immaginazione per superare i limiti fisici e percepire l'immensità dell'universo.
La poesia è composta da quindici versi endecasillabi sciolti, divisi in due parti simmetriche che esplorano l'infinito spaziale e temporale attraverso sensazioni visive e uditive.
I temi principali includono lo spazio infinito, il tempo, il silenzio e l'immaginazione, che permettono al poeta di evadere dalla realtà limitata.
La siepe rappresenta un ostacolo fisico che stimola l'immaginazione del poeta, permettendogli di concepire spazi infiniti al di là del visibile.
Leopardi utilizza figure retoriche come la metafora e l'ossimoro, ad esempio nel verso "il naufragar m'è dolce in questo mare", per esprimere la dolcezza dell'annullamento nell'infinito.

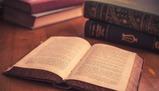








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo