In questo appunto di matematica ci occuperemo della goniometria e della trigonometria, definendo le funzioni elementari e le regole fondamentali che legano tali funzioni ai lati di un triangolo.
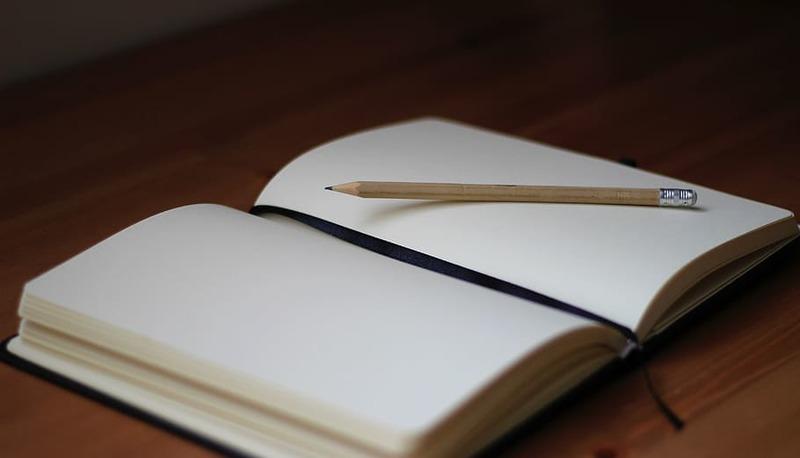
Indice
Goniometria e trigonometria
La goniometria è quella parte della matematica che si occupa della definizione e della misura degli angoli e delle funzioni a questi associate (seno, coseno, tangente, ecc.). In questa parte della matematica, oltre alle definizioni cui si è precedentemente accennato, vengono date delle formule che legano le funzioni goniometriche di più angoli a seconda della relazione che li interessa (come ad esempio fra gli angoli associati che sono archi differenti che hanno valori delle funzioni goniometriche uguali in valore assoluto).La trigonometria studia le relazioni che legano le misure dei lati di un triangolo a quelle dei suoi angoli. Quindi in questa parte della matematica vengono elaborati dei teoremi nei quali i lati di un qualunque triangolo vengono messi in relazione ai suoi angoli interni.
Gli angoli
Definiamo angolo ciascuna delle due parti in cui un piano è diviso da due semirette che hanno origine in comune, comprese le semirette.Il punto in comune alle due semirette che definiscono un angolo si chiama vertice, mentre le due semirette che lo definiscono sono dette lati.
A seconda della propria ampiezza diremo che un angolo è:
- nullo;
- giro;
- piatto;
- retto.
Diremo che un angolo è giro quando i suoi lati sono coincidenti ed è formato da tutti i punti del piano.
Diremo che un angolo è piatto se i suoi lati sono uno il prolungamento dell’altro.
Infine se due rette, intersecandosi, formano quattro angoli uguali, ciascuno di tali angoli viene chiamato retto.
La misura degli angoli avviene tramite due metodi principali:
- misura in gradi;
- misura in radianti.
1°
= \frac{1}{360}
[/math]
Ogni grado è suddiviso in 60 parti che prendono il nome di primo:
1° = 60’.
Il primo, a sua volta, è suddiviso in altre 60 parti che prendono il nome di secondo:
1’ = 60”.
Il radiante invece è la misura dell'angolo al centro che sottende un arco di lunghezza pari al centro della circonferenza, per cui l’angolo
\alpha
[/math]
\alpha = \frac{l}{r}
[/math]
dove
l = lunghezza dell’arco
r = raggio della circonferenza.
La formula che ci permette il passaggio dal sistema dal sistema di misura sessagesimale a quello in radianti è la seguente:
\alpha(rad) : \alpha(gra) = 2\pi : 360
[/math]
dove
\alpha(rad)
[/math]
e
\alpha(gra)
[/math]
In particolare si ha che:
\alpha(rad) = \frac{(2\pi)(alpha(gra))}{360}
[/math]
\alpha(gra) = \frac{(360)(alpha(rad))}{2\pi}.
[/math]
Infine è bene precisare il concetto di angolo orientato. Nel caso in cui venga scelto un lato di un angolo come lato origine e venga fissato un senso di rotazione, allora l’angolo si dice orientato (l’altro lato viene chiamato lato termine). Diremo che un angolo orientato è positivo se è descritto da una rotazione oraria; mentre lo definiremo negativo quando la rotazione avviene in senso antiorario.
Funzioni goniometriche
Si consideri il piano cartesiano ed una circonferenza avente centro nell’origine O nel piano cartesiano e raggio uguale ad uno, tale curva viene definita come circonferenza goniometrica, la cui equazione è la seguente:x^2 + y^2 = 1.
[/math]
Il punto di coordinate (1;0) viene chiamato origine degli archi. Tramite la circonferenza goniometrica si ha la possibilità di rappresentare gli angoli orientati, dove l’asse delle x viene scelto come lato origine.
Fissato un qualunque punto P sulla circonferenza goniometrica, sia H la sua proiezione ortogonale sull’asse x e sia
\alpha
[/math]
Definiamo seno dell’angolo
\alpha
[/math]
sen\alpha = \frac{PH}{OP}.
[/math]
Mentre definiamo coseno dell’angolo
\alpha
[/math]
cos\alpha = \frac{OH}{OP}.
[/math]
Il seno ed il coseno di un angolo orientato
\alpha
[/math]
\alpha
[/math]
tg\alpha = \frac{sen\alpha}{cos\alpha}
[/math]
ossia
tg\alpha = \frac{PH}{OH}.
[/math]
A tale funzione si deve aggiungere la cotangente, definita come la reciproca della tangente:
ctg\alpha = \frac{cos\alpha}{sen\alpha}
[/math]
ctg\alpha = \frac{OH}{HP}
[/math]
Infine si hanno la funzione secante e la funzione cosecante:
sec\alpha = \frac{1}{cos\alpha}
[/math]
cosec\alpha = \frac{1}{sen\alpha}.
[/math]
Se il punto P, partendo dall’origine degli archi, si muove sulla circonferenza goniometrica in senso antiorario avremo che:
se
\alpha = 0
[/math]
allora
sen\alpha = \frac{PH}{OP} = 0
[/math]
poiché PH = 0
mentre
cos\alpha = \frac{OH}{OP} = 1
[/math]
poiché OH = OP = 1.
Man mano che l’angolo
\alpha
[/math]
\alpha
[/math]
\frac{\pi}{2}.
[/math]
Se
\alpha = \frac{\pi}{2}
[/math]
PH = 1
OH = 0
Per cui
sen\alpha = 1
[/math]
cos\alpha = 0.
[/math]
Se l’angolo
\alpha
[/math]
\alpha = \pi
[/math]
sen\alpha = 0
[/math]
poiché PH = 0
cos\alpha = -1
[/math]
poiché OH = -1
ossia il punto P ha coordinate (-1;0).
Se l’angolo
\alpha
[/math]
Quindi se
\alpha = \frac{3\pi}{2}
[/math]
PH = -1
OH = 0
sen\alpha = \frac{PH}{OP} = -1
[/math]
cos\alpha = \frac{OH}{OP} = 0.
[/math]
Continuando a far crescere l’angolo
\alpha
[/math]
Se
\alpha = 2\pi
[/math]
sen\alpha = \frac{PH}{OP} = 0
[/math]
poiche PH = 0
cos\alpha = \frac{OH}{OP} = 1
[/math]
poiché OH = 1.
Da questo momento in poi il punto P ricomincia il giro sulla circonferenza ripartendo dall’origine degli archi, per cui sia il seno sia il coseno riassumono gli stessi valori descritti sopra.
In base a queste considerazioni si arriva alle seguenti conclusioni:
- seno e coseno hanno valori compresi fra -1 e 1;
- la funzione tangente valori compresi fra -infinito a +infinito;
- seno e coseno sono funzioni periodiche di periodo 2\pi;
- il segno delle funzioni seno e coseno varia nel seguente modo
primo quadrante: seno positivo e coseno positivo;
secondo quadrante: seno positivo e coseno negativo;
terzo quadrante: seno e coseno negativi;
quarto quadrante: seno negativo e coseno positivo .
\alpha
[/math]
sinusoide è il nome attribuito al grafico del seno, cosinusoide quello il grafico del coseno.
Relazione fondamentale
Le funzioni seno e coseno sono legate dalla relazione fondamentale:(sen\alpha)^2 + (cos\alpha)^2 = 1.
[/math]
La dimostrazione di tale relazione viene fatta tramite il Teorema di Pitagora:
(sen\alpha)^2 + (cos\alpha)^2 = (\frac{PH}{O})^P2 + (\frac{OH}{OP})^2 =
[/math]
= \frac{(PH)^2 + (OH)^2}{(OP)^2}
[/math]
ma
(PH)^2 + (OH)^2 = (OP)^2
[/math]
per il Teorema di Pitagora
quindi
\frac{(PH)^2 + (OH)^2}{(OP)^2} = \frac{(OP)^2}{(OP)^2} = 1
[/math]
da cui la nostra tesi.
Angoli e lati di un triangolo
La trigonometria, come già anticipato, mette in relazione i lati di un triangolo con i suoi angoli:I principali teoremi che ci forniscono queste relazioni sono:
- il teorema dei triangoli rettangoli;
- il teorema dei seni;
- il teorema di Carnot o dei coseni.
Il teorema dei triangoli rettangoli asserisce che:
dato un triangolo rettangolo ABC, in cui
BC è l’ipotenusa
l’angolo in A è
\frac{\pi}{2}
[/math]
\gamma
[/math]
\beta
[/math]
si ha che
AB = BC cos\beta
[/math]
AC = BC sen\beta
[/math]
AB = BC sen\alpha
[/math]
AC = BC cos\alpha.
[/math]
Il teorema dei seni afferma che:
dato un triangolo qualunque ABC in cui
\alpha
[/math]
\beta
[/math]
\gamma
[/math]
Il rapporto fra un lato ed il seno dell’angolo opposto è costante e più precisamente
\frac{CB}{sen\alpha} = \frac{AC}{sen\beta} = \frac{AB}{sen\gamma} = 2R
[/math]

dove R è il raggio della circonferenza circoscritta al triangolo ABC.
Il teorema di coseni o di Carnot asserisce che, dato un triangolo qualunque come sopra, il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due meno il doppio prodotto fra gli altri due lati ed il coseno dell’angolo compreso fra questi.
(CB)^2 = (AB)^2 + (AC)^2 – 2 (AB)(AC) cos\alpha
[/math]
(AB)^2 = (AC)^2 +(CB)^2 – 2 (AC)(CB) cos\gamma
[/math]
(AC)^2 = (AB)^2 +(CB)^2 – 2 (AB)(CB) cos\beta.
[/math]
per ulteriori approfondimenti sulla trigonometria vedi anche qua

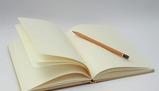







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo