Concetti Chiave
- La virgola ha origini antiche, derivante dal latino "virgulam", e il suo uso si è evoluto nel tempo dall'antichità fino all'epoca moderna, passando attraverso varie fasi di rappresentazione grafica.
- Nella storia, la virgola ha avuto un uso eccessivo, ma a partire dal Settecento il suo utilizzo si è ridotto, trovando un equilibrio nel tempo con le regole grammaticali in evoluzione.
- La virgola è ampiamente utilizzata per enumerare elementi in una lista, separare frasi coordinate senza congiunzioni o per evidenziare una pausa breve tra due proposizioni.
- Usata in frasi con congiunzioni avversative o subordinanti, la virgola aiuta a sottolineare contrasti o collegamenti concettuali tra le parti della proposizione.
- Serve anche per incassare incidentali o incisi nelle frasi e per enfatizzare elementi distintivi o rivolgersi direttamente a qualcuno, come in esortazioni e affermazioni.
In questo appunto ci si focalizza sulla definizione di virgola e su come nel corso del tempo il suo utilizzo si sia evoluto e regolarizzato fino ad arrivare ad analizzare i diversi casi in cui questo segno di interpunzione deve essere adoperato facendo ricorso anche a degli esempi.
Indice
Definizione di virgola e breve storia del suo sviluppo
La virgola è uno dei segni di interpunzione che sono presenti nella lingua italiana. La sua definizione proviene dal latino “virgulam” che vuol dire bastoncino o piccola verga (pezzo di metallo allungato a sezione circolare o poligonale).Si pensa che la virgola abbia avuto origine dalla “prima positura”, un punto che nella classicità veniva utilizzato per segnalare la comma ovvero un parte di testo racchiusa da due pause.
Quando, poi, tra il VII e l’VIII secolo, si inizia a diffondere la scrittura minuscola, la virgola è rappresentata come un apice da posizionare sopra il punto che, invece, è in basso. Nel corso del XIV secolo è consuetudine illustrare la virgola con una barra obliqua.
La forma moderna della virgola è dovuta all’attività tipografia di Aldo Manuzio e, in particolare, con la stampa veneziana del “De Aetna” scritto da Pietro Bembo nel 1496.
Dalla metà del Settecento, però, la virgola tende a scomparire visto che nei secoli precedenti se ne era fatta un’ eccessiva fruizione (veniva adoperata prima di ogni congiunzione e subordinata).
Nell’Ottocento la situazione è varia perché si vive un periodo di transizione tra i due opposti dell’uso di questo segno di interpunzione e, conseguentemente, le regole grammaticali ancora non sono univoche.
Attualmente la virgola viene adoperata frequentemente vista la sua tendenza a sostituire il punto, il punto e virgola e i due punti ma il suo utilizzo sente spesso l’influenza dello stile o della poetica personali di uno scrittore.
Elenco dei costrutti sintattici in cui si deve utilizzare la virgola
Secondo Serianni, la virgola è “di uso più largo, vario e articolato, più carico di valori e di funzioni” e ciò significa che la pausa che è contenuta in sé deve essere breve e debole in modo tale da non distaccare del tutto due parole o due proposizioni. Oralmente, infatti, si può notare come la voce si fermi per pochissimo tempo prima di ricominciare ad enunciare qualcosa.La virgola può essere di tipo seriale, cioè viene inserita nelle elencazioni e nelle descrizioni connessi per asindeto come dimostrano i seguenti esempi:
“Al supermercato devi comprare il pane, la nutella, i formaggi e la bresaola.”
“[Don Abbondio] vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, s’infuriò, pensò, prese una risoluzione”
A questa tipologia di virgola appartengono anche le frasi coordinate prive della congiunzione che nella maggior parte dei casi possono o meno avere lo stesso soggetto e descrivere due situazioni opposte o diverse. Alcuni esempi possono essere:
“Il nonno è originario di Trento, la nonna invece è nata a Roma.”
“Marco credeva nel suo amico, e si sbagliava clamorosamente”
Se, però, ci si trova in una condizione in cui si deve separare una frase principale da una coordinata introdotta dalle congiunzioni: ma, però, tuttavia, anzi o una frase principale da una subordinata introdotta da: benchè, sebbene, per quanto, poiché, giacché, quando, mentre e se (con valore ipotetico) la virgola può essere inserita. Generalmente, in questi casi, si vuole sottolineare la diversità tra la prima e la seconda parte della proposizione dal punto di vista grammaticale o concettuale. Alcuni esempi possono essere questi:
“Ti ho preparato una cioccolata calda, anche se non te la meriti.”
“Ti ho messo una nota, poiché non hai studiato.”
“Non sto bene, ma devo partire lo stesso.”
“Non ho notizie di Luca, anzi non lo sento da due mesi.”
“Oggi il cielo è sereno, ma è previsto che pioverà”
“Per quanto mi riguarda, io non ho dubbi” (F. Moccia, Scusa ma ti chiamo amore)
Una seconda tipologia di virgola è quella che “apre e chiude” perché generalmente viene inserita nelle incidentali o prima e dopo un inciso e incassa al suo interno una relativa quando questa ha una funzione distintiva nella frase per cui la comprensione del messaggio potrebbe essere vincolato dalla sua presenza o assenza. Alcuni esempi sono:
“Non riesco più a vivere in città, ormai, perché sono disturbato dal rumore delle auto a tutte le ore del giorno”
“Luca, uno studente modello della classe 1^b, studia alla scuola di musica di Milano.”
“Il professore, preoccupato per la situazione della classe emersa durante gli scrutini, propose di inserire il cinque in condotta.”
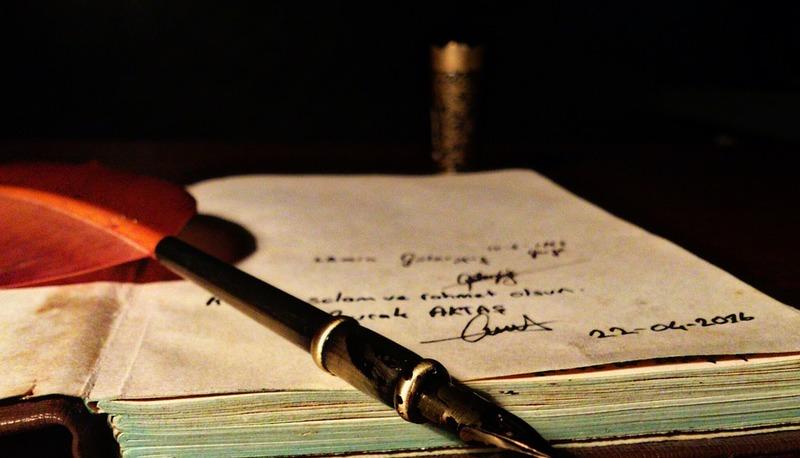
“I ricercatori che erano presenti alla convention sono stati ammaliati dalla rivoluzionaria scoperta del ragazzo appena quindicenne” (= non tutti i ricercatori, ma solo quelli che erano presenti)
“I ricercatori, che erano presenti alla convention, sono rimasti ammaliati dalla rivoluzionaria scoperta del ragazzo appena quindicenne” (= tutti i ricercatori sono rimasti sorpresi)
Infine con questa accezione la virgola si usa quando ci si rivolge a qualcuno direttamente, conseguentemente con le esortazioni e le iterazioni e dopo le particelle che indicano affermazione o negazione. Diversi esempi sono:
“Mauro, ricordati di studiare per il tema di italiano”
“Matilde, sbrigati o faremo tardi alla visita!”
Ti prego, pensami ogni tanto anche se saremo lontani”
“No, te l’ho già detto: non mi interessa andare a pattinare domenica”
Domande da interrogazione
- Qual è l'origine storica della virgola e come si è evoluta nel tempo?
- In quali contesti sintattici è necessario utilizzare la virgola?
- Come si distingue l'uso della virgola nelle frasi coordinate senza congiunzione?
- Qual è la funzione della virgola nelle frasi incidentali o con incisi?
- Quando si utilizza la virgola nelle esortazioni e iterazioni?
La virgola ha origine dal latino "virgulam" e si pensa derivi dalla "prima positura" usata nella classicità. La sua forma moderna è stata influenzata dall'attività tipografica di Aldo Manuzio nel XV secolo. Nel tempo, il suo uso è variato, con un eccesso nel Settecento e una transizione nell'Ottocento, fino a diventare un segno di interpunzione comune oggi.
La virgola è usata in elencazioni, descrizioni connesse per asindeto, e per separare frasi coordinate o subordinate introdotte da congiunzioni come "ma", "però", "tuttavia". Serve anche per aprire e chiudere incidentali o incisi, e quando ci si rivolge direttamente a qualcuno.
Nelle frasi coordinate senza congiunzione, la virgola separa proposizioni che possono avere lo stesso soggetto o descrivere situazioni opposte. Ad esempio: "Il nonno è originario di Trento, la nonna invece è nata a Roma."
La virgola in frasi incidentali o con incisi serve a delimitare parti della frase che, se rimosse, non alterano il significato principale. Ad esempio: "Luca, uno studente modello della classe 1^b, studia alla scuola di musica di Milano."
La virgola si usa nelle esortazioni e iterazioni per separare il nome della persona a cui ci si rivolge o per enfatizzare un comando. Esempi includono: "Mauro, ricordati di studiare per il tema di italiano" e "Matilde, sbrigati o faremo tardi alla visita!"









 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo