Concetti Chiave
- L'immagine è uno strumento eterno per l'uomo, nato dalla necessità di immortalare ciò che è minacciato dalla sparizione e dalla morte.
- La rappresentazione artistica è un privilegio sociale che consente agli antenati di sopravvivere attraverso l'immagine, un trasferimento dell'anima da rappresentato a rappresentazione.
- Il cristianesimo ha saputo conciliare immagine e spiritualità, utilizzando le immagini come mediatori di fede e comunità, senza che diventassero il fine ultimo.
- L'arte è un fenomeno globale che evolve attraverso cicli di stile simbolico, figurazione, equilibrio geometrico e realismo, mantenendo una traiettoria di crescita e decadenza.
- La videosfera, iniziata con la fotografia e proseguita con cinema e televisione, ha rivoluzionato la percezione e l'importanza degli eventi, enfatizzando l'istantaneità e l'ubiquità dell'informazione.
L'immagine e la sua eternità
- La nascita dell’immagine è strettamente connessa alla morte, l’immagine per l’uomo primitivo era una necessità per sfuggire al deperimento e diventare eterni. --> ciò che non è precario non viene rappresentato, ciò che si immortala è ciò che è minacciato di sparizione.
- Trasformare il morto in immagine di lui da vivo serve anche per sé stessi, per non vedere come si diventerà, l’immagine porta nelle tombe le gioie della vita, decomposizione del corpo, ricomposizione dell’immagine.
- Immagine=eidolon=simulacro, spettro; alcune immagini erano utilizzate al posto delle persone nelle cerimonie, le statue greche servivano non per guardarle ma per essere guardate. Non erano rappresentazioni del dio, ma il dio stesso. --> proprietà dello sguardo, non dell’immagine.
- Nel paleolitico l’immagine oscilla tra panico e tecnica: finché il panico è maggiore c’è la magia, dopodichè c’è arte, natura manipolata (tecnica) e manipolatrice (panico); Leonardo da Vinci era un artista perché era un tecnico (scienziato e pittore).
Il ruolo sociale dell'immagine
- Rappresentazione diventa privilegio sociale, gli antenati sopravvivono attraverso le immagini, spostamento d’anima da rappresentato a rappresentazione. 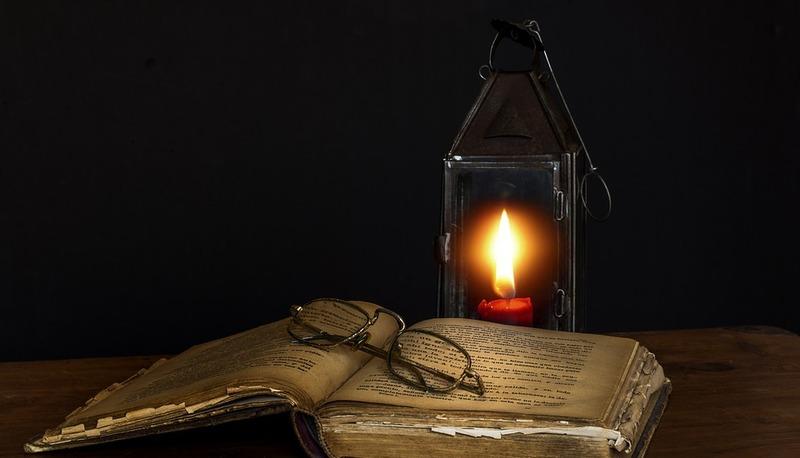
- Tomba egizia: rivolta all’interno, tomba greca: rivolta all’esterno, tomba cristiana: a metà strada tra tomba e tempio; nei templi cattolici man mano che diventano più importanti sempre maggiore spazio è riservato alle immagini.
L'immagine come linguaggio
- l’immagine è l’antenata del segno (lingua scritta) e rispetto a questa è meno precisa ma ha potenzialità maggiori. La parola NON ha l’esclusività del trasporto di senso. L’una non è “migliore” dell’altra, sono solo due modi diversi di esprimersi, entrambi con pro e contro.
- Ciononostante l’immagine non è una lingua, principalmente per il fatto che non segue un codice e non può essere tradotta, inoltre non può essere scomposta in “frammenti” di base. Però i colori possono seguire un codice.
- Un’immagine può voler dire una cosa e il suo opposto.
- Un quadro non esprime, è. È chi lo guarda che esprime. in sostanza, il quadro suscita la parola, ognuno può dare al quadro il significato che trova guardandolo, questo a livello teorico, poi per forza l’artista lascia parte di sé stesso nel dipinto, una “traccia” di senso.
Il simbolismo nell'arte
- Simbolo (ciò che unisce) contro diavolo (ciò che separa) --> un’immagine che apre qualcosa rispetto a sé è sacra (n.b.: sacroreligioso come trascendentesoprannaturale); questa sacralità è l’aura di Benjamin che si è trasferita dall’opera all’artista
- L’arte si è conquistata contro l’alienazione, si è ingrandita nell’autonomia ed è morta di autoreferenzialità, solo le immagini che si rifanno a qualcos’altro oltre a sé stesse diventano eterne (vedi le immagini sacre nelle chiese). Se un’immagine parla solo di sé stessa non si comunica ed è sterile. L’arte moderna lascia abbastanza freddi proprio per questo motivo. Solo l’artista è in grado di capire le proprie opere.
- tutti i monoteismi sono iconofobi e iconoclasti; il cristianesimo è riuscito in un qualche modo a conciliare immagine e spiritualità.
- Per gli ebrei l’occhio è un organo infausto, che fa adorare la creatura invece del creatore, le visioni fanno parte delle piaghe d’Egitto, il linguaggio è come il dio padre: distanziato, digitale, l’immagine è come la madre: analogica, tattile. (odio/amore per la donna, ad esempio Eva, madre dell’umanità ma responsabile della cacciata dall’eden).
- Concilio di Nicea del 787: legittimità delle icone --> immagine mediatrice di Gesù, cosa buona perché rinvia al creatore. Cristo stesso è una immagine di Dio.
- L’immagine ha il vantaggio di essere alla portata di tutti, di essere un codice comune e di rinsaldare la comunità il cattolicesimo la accetta e ne fa ampio uso, tanto che non si farà mai sorprendere dalle nuove tecnologie di comunicazione.
- Ovviamente però le immagini devono solo essere dei rimandi e non diventare il fine ultimo.
- Nessun uomo di autorità può permettersi di rompere con l’immagine: chiunque deve cercare di apparire per poter comandare.
- la storia dello sguardo è legata a tecnica (storia dell’arte), aspetto simbolico (iconologia o semiologia) e aspetto politico (storia della mentalità), insieme costituiscono il complesso mediologico.
- La pubblicità è criticata perché seduce e intimidisce, ma questa non è una proprietà solo della pubblicità ma delle immagini in genere; è uno strumento che alimenta una certa tendenza mimetica e che può essere usato sia per il bene che per il male.
- Le immagini richiamano l’inconscio, con la loro semplicità tagliano fuori la parte ragionevole e l’uomo che ha a che fare con le immagini tende più a ragionare con l’istinto; l’immagine è peculiare dell’uomo e corre nelle sinapsi più veloce del concetto. (questo è il motivo per cui spesso la storia dell’arte anticipa la storia).
- Il mediologo è contro la frattura tra estetica e tecnica; più un’arte contiene tecnica più tardi acquisirà il titolo di “arte”.
- L’oggetto artistico è contemporaneamente cosa e segno, non si può separare l’uno dall’altra, motivo per cui non ha senso dividere forma e materia --> la tecnica è necessaria.
- La tecnica permette inoltre di ampliare le percezioni (fotografia e cinema) affinando sempre di più gli organi della conoscenza.
- Malraux: vede nella riproduzione dell’arte una possibilità per costruire un umanismo planetario, Benjamin è più scettico e vede la vittoria di duce e divo.
- Castelli apprezza l’opera d’arte e cerca di enunciare una legge per il bello comune a tutti (anche e nella pratica non cambia nulla) Kant preferisce all’opera d’arte la natura, enuncia queste massime sulla bellezza. (pur disinteressandosi all’arte contemporanea, di cui però scrive...)
o È bello l’oggetto di un piacere disinteressato.
o Quel che piace universalmente senza concetto è bello.
o La bellezza è percepita senza la rappresentazione di uno scopo.
o Il bello è ciò che, senza concetto, viene riconosciuto come oggetto di un piacere necessario.
L'arte e la sua evoluzione
- arte: un qualcosa di locale diventato globale
- si può dire che tutto è arte ormai, ma non si ammette che in realtà l’arte è solo una illusione.
- Non è che l’artigiano di colpo è diventato un artista, è il concetto stesso di arte che lo ha trasformato.
- L’idea di arte è stata portata nel rinascimento dall’idea di progresso. Ma una eventuale fine dell’era dell’arte non vorrebbe assolutamente dire una fine dell’immagine. Per questo non ha senso di parlare di una storia dell’arte dagli albori ad oggi.
- Qual è la traiettoria che segue l’arte?
1- stile simbolico
2- passaggio dal segno alle prime figure
3- equilibrio tra geometrico e rappresentazione
4- realismo
in pratica ogni arte ripercorre questi 4 punti ogni volta, “decadendo” alla fine dell’ultimo. Non è un ogni volta ripartire da zero, perché si tiene in considerazione quel che è stato, ogni nuovo ciclo è sempre più eclatante e più breve.
La percezione greca dell'arte
- filosofi come Kant ed Hegel parlavano dell’antica Grecia come culla dell’arte, ma il termine arte è propriamente usato? Inoltre non conoscevano l’arte paleolitica; i greci nel loro vocabolario non hanno un termine per l’arte in genere (ma per le varie arti prese singolarmente sì: techne), che era vista come una funzione della religione (non esisteva nemmeno un termine preciso per religione) poiché quando tutto è arte l’arte non ha nome (e lo stesso per la religione).
- Per i greci la bellezza era secondaria rispetto all’utilità, quindi un’arte come la nostra avrebbe goduto di poco rispetto. (concetto di bello e buono); anche a Roma e nel medio evo c’è la netta distinzioni tra arti manuali e liberali.
- Per i greci vedere è conoscere, inoltre sono stati loro gli inventori del teatro.
- La messa per iscritto di immagini ha più prestigio che la messa in immagini dello scritto.
- La conoscenza vera si acquisisce guardando le essenze, ed è quando che ci si accorge che l’essenza potrebbe essere più nella copia che nell’originale l’artigiano diventa artista.
- la paesaggistica è nata in Olanda molto tardi, perché Calvino proibì la pittura religiosa e perché l’industrializzazione permise di vedere la natura con occhi diversi.
- Nasce anche il ritratto liberato dal contesto sacro nello stesso periodo, liberalizzazione dell’arte. (paesaggio = pagano + paesano: il ritrarre il mondo era una cosa disdicevole perchè voleva dire che si preferiva la realtà al divino.)
L'arte e la globalizzazione
- Con la soppressione delle distanze tutto diventa accessibile a tutti --> pigrizia, mondializzazione dello sguardo.
- tre mediosfere, una non distrugge la successiva, ognuna è “madre” della successiva.
o Logosfera (idolo)
o Grafosfera (arte)
o Videosfera (visivo)
- vi è artistico quando l’arte trova in sé la propria ragione d’essere, vi è arte quando un committente non richiede ben più l’immagine di una crocifissione quanto un Raffaello.
La morte e rinascita dell'arte
- la morte dell’arte quindi ormai è una cosa che accade in ogni secolo (per poi rinascere, rimorire e così via), ma questo secolo pare che le cose siano diverse: l’arte è diventata autoreferenziale e si è svuotata di senso
- questo periodo, che dovrebbe essere di morte è invece di apoteosi, i musei sono più pieni e il valore delle opere va alle stelle, l’arte esiste tutt’oggi solo in funzione del mercato. Tv e cinema esistono in funzione del pubblico, e la pubblicità trasforma in oggetti d’arte oggetti di uso comune.
- Non c’è contraddizione tra affari di culto e il culto degli affari, gli artisti devono tornare ad edificare ponti tra le culture (pontificare --> i nuovi papi)
L'immagine e il contesto culturale
- In realtà una immagine non crea legami, piuttosto è viceversa. Perché una immagine pur viaggiando meglio di mille parole, senza un contesto culturale adatto non vuol dire nulla. Sapere e senso il senso divide gli uomini (esiste almeno un senso diverso per ogni cultura) il sapere non contrappone né accomuna in quanto sterile. L’arte non può dare un senso alla vita, o può solo se è al servizio di un potere o di una religione.
- Sintomo alessandrino: culto dell’edonismo, dell’erotismo, della ricerca sfrenata del piacere per sopperire all’anestesia dei sensi.
L'evoluzione della videosfera
- La videosfera non è l’apogeo della società dello spettacolo ma la fine (nasce con la fotografia, prosegue con la proiezione, poi film sonoro e cinema a colori).
o La fotografia ha costretto i pittori a dipingere con minore realismo e maggiore estetismo
o Il cinema ha superato la pittura dall’alto (prestigio) e dal basso (consenso popolare)
o La tv all’inizio era un cinema in miniatura (come tutte le “figlie” inizialmente imita il padre, per poi discostarsene)
o Tv e rivoluzione telematica che ne è conseguita hanno rivoluzionato inserendo ubiquità ed istantaneità dell’informazione nella vita di tutti i giorni. Un evento non è più importante di per sé ma solo se viene ripreso
o La tv invade le nostre case dall’interno, non riusciamo ad immedesimarci perché ci siamo già dentro.
Il digitale e l'arte
- digitale (1980): l’immagine si stacca da ogni connessione con la materia
o Le macchine diventano creatrici.
o La mano non fa nulla per creare.
o Ogni innovazione ha generato un’arte.
- declino delle immagini con il declino della polizia (ciò che non fa scandalo non interessa).
- si venera ciò che si perde.
- Ritorno dell’idolo: una immagine auto referente somiglia più ad un idolo che ad un’opera d’arte, siamo tentati di adorarla direttamente invece di adorare attraverso essa la realtà che rappresenta
- Il nostro occhio diserta sempre di più il mondo reale.
- Insomma ormai ci si fida solo di quel che si vede attraverso uno schermo. Un morto non filmato potrebbe non essere un vero morto.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo dell'immagine nella cultura primitiva secondo Régis Debray?
- Come si differenzia l'immagine dalla lingua scritta?
- In che modo il cristianesimo ha conciliato immagine e spiritualità?
- Qual è la critica di Debray alla modernità dell'arte?
- Quali sono i paradossi della videosfera secondo Debray?
L'immagine nella cultura primitiva è strettamente legata alla morte e serve come mezzo per sfuggire al deperimento e diventare eterni. Ciò che è minacciato di sparizione viene immortalato.
L'immagine è l'antenata del segno scritto e, sebbene meno precisa, ha potenzialità maggiori. Non segue un codice e non può essere tradotta, ma suscita la parola e permette interpretazioni personali.
Il cristianesimo ha legittimato l'uso delle icone come mediatori di Gesù, accettando l'immagine come codice comune che rinsalda la comunità, senza farla diventare il fine ultimo.
Debray critica l'arte moderna per la sua autoreferenzialità, che la svuota di senso. L'arte esiste oggi principalmente in funzione del mercato, perdendo il suo potere comunicativo e culturale.
Nella videosfera, l'immagine diventa autoreferenziale, simile a un idolo, e il nostro occhio si allontana dal mondo reale. Si tende a fidarsi solo di ciò che si vede attraverso uno schermo, perdendo il contatto con la realtà.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo