Concetti Chiave
- Hegel posits that philosophy, art, and religion share the same subject matter but differ in form, with philosophy being a higher form of self-reflection.
- Feuerbach critiques religion, suggesting that humans project their nature onto God, reversing the creator-created relationship.
- The right-wing followers of Hegel emphasized religion, while the left-wing used philosophy to critique and challenge religious concepts.
- Feuerbach's philosophy emphasizes the importance of interpersonal relationships and love, viewing it as essential to human existence and understanding.
- Feuerbach's materialism contrasts with Hegel's idealism, focusing on tangible, sensory experiences and relationships rather than abstract ideas.
Indice
Divergenze tra filosofia e religione
Queste due posizioni andarono divergendo sul ruolo tra filosofia e religione. Questo rapporto tra la filosofia e la religione è stato trattato nella sezione della filosofia dello spirito e secondo Hegel la filosofia dello spirito metteva sullo stesso piano arte, religione e filosofia dicendo che avevano lo stesso oggetto ma in forme differenti (la filosofia era la forma che il pensiero ha di sé stesso nella forma del concetto, il modo in cui l'assoluto pensa sé stesso nella forma della rappresentazione quindi la religione era meno importante della filosofia).
La destra tese ad accentuare il momento della religione piuttosto che la filosofia.
La sinistra invece valorizzò la filosofia rispetto alla religione e alla filosofia venne attribuito un ruolo di critica alla religione riprendendo il fatto che quella che Hegel studiava era filosofia della religione.
Critica di Feuerbach alla religione
Feuerbach scriverà 'L'essenza del cristianesimo' e 'L'essenza della religione' in cui tese a criticare la religione mostrandone il ruolo. Alla stessa maniera l'altro tema fu il ruolo della filosofia. La destra tese a vedere la filosofia come giustificazionistica. La sinistra invece sostenne la funzione di critica del reale: la filosofia è lo sguardo che in virtù della ragione gli uomini conducono sulla realtà. È un modo diverso di vedere la realtà, la filosofia dà un modo di pensare, è un altro modo di pensare il mondo. Vedi la realtà non come appare ma cosa sta sotto, non ti limiti all'occultazione del dato di fatto.
Marx e la trasformazione della filosofia
Feuerbach fu discepolo di Hegel e contesterà il maestro. Questa tesi verrà teorizzata da Marx quando nel 1911 nelle 'Tesi su Feuerbach' scriverà che i filosofi hanno interpretato il mondo, ora è ora di cambiarlo. Con Marx la filosofia da giustificazione della realtà e da critica diventa trasformazione. Queste tre opzioni sono rinviabili a Hegel, derivano da una riflessione sulla filosofia hegeliana. La destra è la più conservatrice mentre la sinistra fu più critica.
Feuerbach non ha combattuto politicamente però scriverà 'La filosofia dell'avvenire' in cui delinea una concezione alternativa di uomo fondata sulla relazione dell'uomo con l'altro uomo, una relazione di amore, non di sopraffazione. Diventa una filosofia con una destinazione sociale, con il rovesciamento della filosofia speculativa. Marx sarà teorico e militante, teorizzerà il rapporto indistinguibile di teoria e prassi.
Egli fu un uomo di grande coerenza, dignità e moralità tant'è vero che alla sua morte parteciparono migliaia di persone. Nel 1804 tenta la carriera universitaria che gli viene interdetta evidentemente per posizioni considerate inaccettabili. Fu considerato ateo, la sua è una forma di ateismo ma metodologico. Visse con la rendita di una fabbrica di porcellana della moglie
Di Feuerbach vedremo tre cose:
1. rovesciamento dei rapporti di predicazione
2. critica della religione
3. filosofia dell'avvenire.
Rovesciamento dei rapporti di predicazione
Rovesciamento dei rapporti di predicazione
È un tema che poi riprende Marx e consiste nell'analisi del rapporto di predicazione: quando io predico qualche cosa di un soggetto, es. questa mela è un frutto. La sua è una filosofia che parte da Hegel e giunge a criticare Hegel. Coglie quello che secondo Feuerbach fu il grande errore dell'idealismo. L'idealismo hegeliano si fonda su un errato rovesciamento dei rapporti di predicazione: è un morale giudizio in cui hai un soggetto a cui attribuisci un predicato. Questo rapporto in Hegel viene rovesciato nel senso che il soggetto è il predicato e il predicato è il soggetto. Il soggetto in Hegel è l'universale, il predicato è il particolare. Il giudizio prototipico è quello secondo il quale l'universale è questo individuo qua: io predico dell'universale il particolare: la frutta è questa mela qui.
Per Hegel il soggetto era l'universale cioè lo spirito e lo spirito veniva a coincidere con le determinazioni finite. Feuerbach dice che da questa filosofia che indica nello spirito assoluto e soggetto che il predicato siano le determinazioni finite, discende implicitamente, un giudizio 'paradossale' del tipo "la frutta sono questa mela", che ovviamente non coincide con la realtà. Accusa Hegel di panlogismo: è come se il logos fosse tutto, come se fosse la vera realtà. Il soggetto è lo spirito, l'universale, e le singole determinazioni finite sono il predicato, dunque il giudizio che ne esce è contro la realtà delle cose. Si può dire che lo spirito è la sintesi delle determinazioni finite ma se poi lo si traduce sul piano della realtà ne esce un errore. La verità fuori da una speculazione filosofica così astratta è che questa mela è un frutto e che la realtà è sempre individuale, singolare, concreta. C'è un rovesciamento filosofico per cui dall'idealismo si passa al materialismo: l'affermazione che ciò che esiste nella realtà è sempre l'individuo particolare e mai esiste l'universale. Gli stoici avevano sostenuto che il concetto è una costruzione della mente, è la mente umana che elabora un universale per comodità di ragionamento.
❗️"Non si deve fare del predicato il soggetto e in quanto soggetto trattarlo come principio, basta insomma rovesciare la filosofia speculativa per avere la verità senza veli pura e schietta."
Il compito della vera filosofia è di conoscere non il finito nell'infinito ma l'infinito nel finito.
Critica della religione e alienazione
Critica della religione
La filosofia hegeliana è speculativa in quanto panlogica, una teologia mascherata che si maschera dietro una visione monistica e panteistica.
Siamo in presenza di un parricidio: parte da Hegel e giunge contro Hegel. Parte dalla coscienza infelice di Hegel, per il quale la coscienza era per sua natura scissa e lacerata, che era la coscienza che nella terza figura scinde la propria parte intrasmutabile da quella trasmutabile: si percepisce centro di noi il conflitto fortissimo tra la nostra parte trasmutabile cioè quella finitudine, caducità che caratterizza l'essere umano e quella intrasmutabile cioè l'essenza (che non muta) e proiettandolo fuori di sé la trasferisce in Dio. Nella coscienza infelice l'uomo, per lo meno nel Medioevo e per lo meno nell'esperienza che ne facevano i mistici, l'uomo si ricongiunge con Dio, ha esperienza di una intensa identificazione con Dio e dunque la coscienza scissa e lacerata si ricompone.
In Kierkegaard questa condizione di sofferenza veniva dalla sua natura di creatura peccaminosa, in Feuerbach viene ripresa da Hegel.
Feuerbach teorizza che non sia Dio ad aver creato l'uomo ma l'uomo ad aver creato Dio a partire dalla struttura complessa e per certi versi contraddittoria dell'uomo: al suo interno coesistono l'esistenza transeunte e caduca e l'essenza eterna non soggetta a mutamenti.
Pascal o Kierkegaard interpretano questa compresenza di questi due fattori irriducibili anche in loro con il fatto che l'uomo è creato, dalla sua natura creaturale che fa sì che queste due componenti non siano risolte. Lo vedono infondo come un dato necessario, inevitabile, che mostra la miseria e la grandezza dell'uomo (Pascal). In Kierkegaard c'è infondo una visione pessimistica dell'uomo: siamo imprigionati all'interno di questa agitazione e non ne possiamo uscire se non affidandoci a Dio. È un problema grosso e l'uomo tende in virtù di questa compresenza a riconoscersi solo in quella caduca, in fieri, in divenire continuamente diveniente e quindi non riconosce la propria essenza come sua, la proietta fuori e a denomina Dio. Tanto più io sono impotente tanto Dio frutto della mia proiezione della mia essenza fuori di me lo definisco onnipotente. Dio viene definito attribuendogli esattamente ciò che io non sono: io non sono ingenerato e Dio lo è, io non sono imperituro e Dio lo è. Dio è la parte di me che proietto fuori di me tanto che la parola alienazione con Feuerbach assume solo il significato negativo. Mentre in Hegel la parola alienazione (porsi in altro da sé) era negativa e positiva per il raggiungimento della sintesi, da Feuerbach in poi avrà solo significato negativo di scissione che significa estraniazione. La parte che è scissa, la mia essenza, diventa estranea a me, diventa oggetto, e la adoriamo, le tributiamo culti, adoriamo noi stessi divenuti estranei a noi stessi.
Non è Dio che ha creato l'uomo ma l'uomo che ha creato Dio. L'essenza della teologia è quella di essere antropologia. Il tuo Dio è tale quale è il tuo cuore: Dio è la raffigurazione di come è l'uomo. E la religione è una produzione umana che discende dal carattere duplice dell'uomo. La causa dell'alienazione che riprende da Hegel discende da 3 contraddizioni nelle quali si avviluppa l'essere umano:
• tra la sua natura sensibile, corporea, caduca e la sua essenza che gli appare sovratemporale, atemporale. Questa dicotomia è la prima importante: tra l'essere umano e la sua essenza
• tra l'individuo e la specie che appare sovratemporale, attraversare il tempo, conservarsi mentre l'individuo nasce e muore
• tra potere (limitato e circoscritto) e volere (illimitato).
Queste tre contraddizioni inducono l'uomo a proiettare la parte essenziale, i connotati propri alla specie cui appartengono, il volere illimitato, infinito, in una dimensione illimitata di cui ci si priva. Proietta la sua parte aspirativa (es: non morire-onnipotenza) che l'uomo coglie e si presenta lui come una parte contraddittoria. È come se nell'uomo convivessero queste sue dimensioni. L'uomo ha bisogno di proiettare fuori di sé quest'esigenza di immortalità e quindi pensa che esista un altro mondo perché non riesce ad accettare questa condizione caduca. Kant dice che è inspiegabile. Gli uomini hanno bisogno di credere, dato che colgono questa contraddizione, che esista un mondo sovrannaturale al quale ritorneremo e attraverso il quale vivremo in eterno. Abbiamo preferito privarci di una parte di noi depauperando noi stessi: preferiamo morire nella terra per trovare eternità in un presunto regno dei cieli sostanzializzato con i nostri sogni.
Supposizione illusoria perché in tal modo ci priviamo di una parte di noi stessi dimezzandoci.
Alienazione e riappropriazione di sé
Alienazione:
•in Hegel era un porsi in altro da sé
•ha un significato negativo cioè negarsi in altro che resta anche in Feuerbach perché l'uomo pone in Dio la sua essenza: non ci sarà più il momento positivo. L'alienazione è solo negativa ed è sinonimo di scissione. L'uomo deve prendere atto che attraverso la religione diventa estraneo a sé stesso. La parola alienazione diventa sinonimo di estraniazione e quindi scissione. È talmente una forma di estraniazione che Dio appare all'uomo nel corso dei secoli in modi diversi perché sempre proiezione dell'essere umano. Anche in Kierkegaard era così, diversamente dall'idealismo che aveva ricongiunto l'uomo con Dio perché una filosofia immanentistica, panteistica. Con Schopenhauer abbiamo visto una proclamazione di ateismo, in Kierkegaard il tema della trascendenza che era separazione tra Dio e l'uomo, alterità, Dio è altro, l'uomo deve solo abbandonarsi, è un Dio incomprensibile per l'uomo. Anche in Feuerbach ritorniamo alla tesi della trascendenza intesa come estraneità. Dio è l'uomo che si è estraniato. Lui ritiene che l'ateismo sia una scelta etica nel senso che l'ateismo è la capacità di riassunzione delle proprie capacità. L'ateismo è in contro-tendenza con la rinuncia. L'ateismo è la disalienazione dell'uomo, è la riappropriazione di sé non per diventare onnipotente ma per riappropriarsi di sé e assumersi le responsabilità in ordine della vita. L'uomo si riappropria della parte minore, la contraddizione rimane ma la accetti. Anche lui cita il cristianesimo e gli appare la religione che più ha tentato una sintesi tra uomo e Dio: Cristo si fa uomo.
La fede ha un ruolo secondo lui negativo. È un transito individuale, solipsistico, dove l'uomo è in una relazione egoistica. La fede è egoismo e si tramuta in una denigrazione di sé stessi e in una ricerca di grazia da parte di Dio con un rapporto privato con Dio. Molto facile questa strada! È un rapporto di ‘DO UT DES’: tanto più mi denigro, tanto più invoco la grazia divina. Il senso di colpa, la culpa, è tipica del rapporto religioso. Secondo lui la fede è egoistica, è il contrario dell'amore. La coscienza di Dio è l'autocoscienza dell'uomo. Senofane: ognuno di noi tende a rappresentarsi Dio come sé stesso (un cavallo si rappresenterebbe Dio come un cavallo).
In questo contesto Dio è l'interiorità resa manifesta. 'Dimmi che Dio hai, ti dirò chi sei'. A seconda di come lo concepisci tale tu sei. La religione è la prima e indiretta coscienza che l'uomo ha di sé stesso, è una trasposizione della propria essenza fuori di sé.
Il tema dell'alienazione religiosa sinonimo di estraniazione, scissione, ha una valenza solo negativa anche se per Feuerbach è possibile la disalienazione. Non è un processo storico come in Hegel per cui la sintesi per forza avveniva per ragioni dialettiche, in Feuerbach è un atto coscienziale, l'uomo che si rende conto di esserci e quindi può prendere coscienza di essere scisso, dimezzato, depauperato e tentare di riappropriarsi della parte estraniata. Avviene per un processo coscienziale, l'uomo che si rende conto di essersi depauperato. In questo senso l'ateismo è il modo con il quale l'uomo si riappropria di sé stesso, è un fatto etico perché significa non delegare ad altri ciò su cui devi assumerti la responsabilità.
Considerazione personale: questo tema è interessante: se la religione è alienante, è giusto che l'uomo rinunci ad essa. È possibile credere in Dio senza che credere comporti un'alienazione? Secondo Feuerbach no, secondo l'epicureismo e il deismo sì. Non c'è dubbio che sia in Feuerbach che in Marx ciò che viene attaccato è l'alienazione religiosa: l'ateismo discende dalla critica all'alienazione. Un cristianesimo per l'uomo, solidale, che si batte contro le ingiustizie è alienante? Problema interessante ma difficile.
Antropologia e amore in Feuerbach
Riappropriazione di sé e della responsabilità verso sé viene a coincidere con l'ateismo etico. Nuova antropologia di Feuerbach che lui delinea in un'opera che non a caso si chiama 'filosofia dell'avvenire'. La filosofia utopica che si riappropria di sé.
Relazione tra soggetto e oggetto
Testo del '46: insieme alla critica alla filosofia hegeliana c'è la delineazione di una filosofia materialistica. Hegel viene accusato di aver creato una teologia speculativa cui Feuerbach contrappone un'antropologia. All'idealismo di Hegel si sostituisce il materialismo al centro del quale sta l'uomo, un uomo non solo ma con gli altri uomini. La sua è un'antropologia dell'amore delineata come una struttura propria della natura umana. L'uomo vive in relazione con un TU. Io-tu è il binomio e l'amore è la prova ontologica dell'essere. Se avessimo dei dubbi sull'esistenza della realtà in cui viviamo, la prova sarebbe l'amore.
Aforismi 59: l'uomo non è uomo se soltanto è un essere morale (Kant: la filosofia kantiana viene giudicata una forma di erica individualistica ma viene teorizzata la comunità) né soltanto ente pensante. Non basta Cartesio, l'uomo non è tale solo in quanto pensa. Sei uomo insieme agli altri altrimenti non sarai mai un uomo. Io e tu siamo differenti ed è grazie a questa differenza che siamo uniti: riconoscimento dell'altro.
Aforisma 62: la vera dialettica è:
•la legge attraverso la quale il pensiero conosce la realtà
•il vero pensatore che pensa la realtà dialetticamente non deve essere un pensatore solitario. Il vero pensatore dialettico è il pensiero del dialogo e della differenza tra un io e un tu. È una traduzione della tesi hegeliana con la differenza che un uomo è tale se lo diventa insieme agli altri, ontologicamente nella relazione con gli altri. L'amore diventa criterio di esistenza della realtà e della verità.
Aforisma 32: tesi materialistica: il reale in quanto tale è il sensibile, è lo scardinamento del sensibile, esistenza della realtà fuori di noi, non è più dentro il pensiero. Viene prima del pensiero, è fuori, materiale, si dà attraverso i sensi non attraverso il pensare.
In base a cosa asserisce che l'oggetto è esterno? Perché agisce sul soggetto: attrazione, repulsione, ostacolo, è un'azione sul soggetto. Solo la sensibilità è in grado di spiegare il mistero dell'azione reciproca. Io esisto nella relazione con l'altro. L'intelletto estrae l'essere e lo decontestualizza, ne fa una sostanza staccata, io, atomo, Dio, è un'operazione arbitraria perché il collegamento con l'altro da sé è reso possibile dalla sensibilità, non dal pensiero. Con l'intelletto astratto isolo mentre è la sensibilità che permette di collegare questo con questo. Anche lui come Kierkegaard sostiene che essere e pensiero siano due cose differenti: l'equiparazione anche in Feuerbach è sbagliata. L'essere è un mistero dell'intuizione sensazione amore. L'essere per gli idealisti è l'essere per noi, quello che il pensiero fa essere. Qui invece bisogna andare alla ricerca dell'essere come è, lo cogli non con l'intelletto che a l'essere in base al pensiero ma attraverso la sensazione o l'amore.
L'essere idealistico è l'oggetto per il soggetto, il tramite. Qui invece ritorniamo all'oggetto in sé che non è il noumeno inconoscibile ma lo cogli se ti rapporti con altro indipendentemente dal soggetto. Liberazione dal soggettivismo che ha inizio con Cartesio e ha culmine con l'idealismo. Il soggetto conosce sempre e solo l'essere per lui: dobbiamo cogliere l'essere per tutti che lo cogli con il sensibilismo o con l'amore. Soggetto e oggetto riacquisiscono la loro attività mentre prima era il soggetto che crea l'oggetto. Nella relazione con l'altro essere umano l'uomo supera la sua finitudine e diventa infinito in questa relazione con l'altro. L'uomo diventa Dio. È un dio non astratto, non è un dio metatemporale ma è nella relazione con l'altro uomo che costruiamo dio. DIO È AMORE. Quando il Dio cristiano dice: 'ama il signore Dio come te stesso' o 'ama il prossimo come te stesso' amare Dio vuol dire amare il prossimo.
Chi è cristo? Essere per gli altri. Non è un cristo scandalo per la ragione rispetto al quale c'è un abisso, viene ricucito lo spazio che separava l'uomo con Dio. Siccome dobbiamo disalienarci rispetto a un dio altro, riappropriarci di noi stessi, significa diventare uomini e possiamo diventare Dei nella relazione con l'altro uomo superando così la nostra finitudine.
Rapporto uomo-dio:
•iato tra dio e l'uomo per cui l’uomo è piccolo e deve affidarsi a dio
•non nientifica l'uomo ma gli consente di realizzarsi a un livello superiore in questa relazione d'amore
•dio considerato indifferente perché non si vuole che interferisca
•uomo prometeico che non ci sta a essere limitato da dio.
La prova dell'esistenza della realtà fuori di noi è data dal fatto che essa agisce su di noi. La passione è la prova dell'esistenza della realtà esterna. La passione è come l'inter esse dì Kierkegaard, stare tra gli altri. L'amore è la vera prova ontologica dell'esistenza di una realtà esterna al nostro pensiero sussistente. Ciò che non può essere amato non esiste. L'amore è un criterio di esistenza. È qualcosa soltanto colui che ama qualcosa. Presenta il pensiero come esercizio astratto e indifferente all'esistenza e alla non esistenza di qualcosa. Teorizzò qualcosa che è una possibilità. Amore è sensazione hanno questa superiorità data dal fatto che questi agiscono su di me provocando in me una risposta. L'amore dunque e la sensazione sono la prova ontologica che l'altro individuo esiste mentre col pensiero la realtà non è effettivamente sussistente. L'identità di soggetto e oggetto è unita e realtà solo nell'intuizione sensibile che l'uomo ha e diventa realtà nella relazione con l'altro uomo. Azione-relazione che mostra che tra soggetto e oggetto c'è realtà.
Ha ragione Hegel quando dice che è il pensiero la fonte delle idee però sbaglia quando pensa che l'uomo da cui scaturiscono le idee sia isolato. Un uomo che in quanto essenza produce idee. Tutta la fenomenologia è la storia degli uomini che producono idee che arricchiscono la storia e non discendono, dice Feuerbach, dal fatto che l'uomo è tale ma dal fatto che gli uomini hanno agito insieme. Ai concetti non si giunge da soli ma in due, esattamente come bisogna essere in due per generare. Il fatto che siamo d'accordo è criterio di verità.
È una filosofia comunitaria perché si diventa uomini insieme. Alterità dell'oggetto è necessaria comunità tra soggetto e oggetto dove l'oggetto è la cosa e l'altro uomo.
Hegel fonde la ragione ontologicamente, non teorizza la comunità: è il percorso di un'autocoscienza. Ora invece se non c'è l'altro non vai neanche avanti.
Domande da interrogazione
- Qual è il rapporto tra filosofia e religione secondo Hegel e come si differenziano le posizioni della destra e della sinistra hegeliana?
- Come Feuerbach critica la religione e quale ruolo attribuisce all'alienazione?
- In che modo Feuerbach rovescia i rapporti di predicazione e critica l'idealismo hegeliano?
- Qual è la concezione di Feuerbach sull'amore e la relazione tra gli uomini?
- Come Feuerbach si differenzia da Hegel nella sua visione della comunità e della produzione delle idee?
Secondo Hegel, filosofia, arte e religione hanno lo stesso oggetto ma in forme differenti, con la filosofia che rappresenta il pensiero di sé stesso nella forma del concetto. La destra hegeliana accentua l'importanza della religione, mentre la sinistra valorizza la filosofia come critica della religione.
Feuerbach critica la religione sostenendo che non è Dio ad aver creato l'uomo, ma l'uomo ad aver creato Dio, proiettando la propria essenza fuori di sé. L'alienazione è vista come una scissione negativa, dove l'uomo diventa estraneo a sé stesso attraverso la religione.
Feuerbach critica l'idealismo hegeliano per il rovesciamento dei rapporti di predicazione, dove il soggetto è l'universale e il predicato è il particolare. Egli sostiene che la realtà è sempre individuale e concreta, e non universale come proposto da Hegel.
Feuerbach vede l'amore come la prova ontologica dell'esistenza della realtà esterna e sostiene che l'uomo diventa tale solo nella relazione con gli altri. L'amore è il criterio di esistenza e la vera dialettica è il dialogo e la differenza tra un io e un tu.
Feuerbach critica Hegel per non teorizzare la comunità, sostenendo che le idee non scaturiscono da un uomo isolato ma dalla storia degli uomini che agiscono insieme. La verità e i concetti si raggiungono attraverso la comunità e la relazione con l'altro.

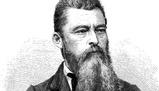





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo