Concetti Chiave
- Nel "De interpretatione", Aristotele esplora come le proposizioni, combinando termini come "Socrate" e "ride", formano giudizi che possono essere veri o falsi, a differenza di espressioni non assertorie come domande o esortazioni.
- Aristotele definisce la proposizione come l'espressione di un giudizio predicativo, suddivisa in affermativa o negativa, universale o particolare, per classificare la verità e la falsità.
- Le proposizioni possono essere universali affermative, universali negative, particolari affermative o particolari negative, e la loro verità è determinata dalla corrispondenza con la realtà.
- Nei "Analitici Primi", Aristotele introduce il sillogismo come forma base dell'argomentazione, dove una conclusione necessaria deriva da premesse assertorie.
- I sillogismi aristotelici si distinguono in validi e veri, validi ma non veri, e non validi ma veri, a seconda della relazione tra premesse e conclusione.
Nella sua raccolta “Organon” (dal greco “strumento”) Aristotele affronta il tema della logica, nel quale si occupa del linguaggio e delle sue articolazioni. Per il filosofo infatti la logica, intesa come una dialettica, studia gli elementi di cui uno si serve nel discutere delle scienze vere e proprie.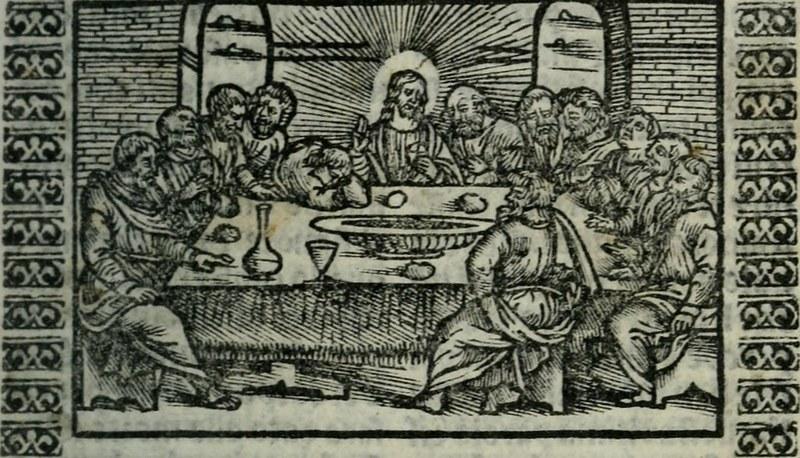
Indice
L'affermazione o giudizio nel “De interpretatione”
Nel “De interpretatione”, trattato raccolto nell’Organon aristotelico, l’interesse del filosofo greco si concentra sugli elementi linguistici che costituiscono il discorso, in particolare sulla proposizione. Rispetto al concetto delle Categorie, infatti, in cui i termini del discorso sono suddivisi secondo le loro caratteristiche specifiche e presentati senza connessione tra loro, nella proposizione gli stessi termini acquistano un nuovo significato e sono in rapporto tra loro. Ad esempio, "Socrate ride" è la combinazione dei due termini "Socrate" e "ride". L'unione dei termini fra loro dà luogo a una proposizione assertoria o affermazione (ap6phasis) o, come si dice utilizzando un'espressione attuale, ad un giudizio. È attraverso un giudizio che noi affermiamo o neghiamo: verità e falsità non sono dunque proprietà dei termini singoli, che isolatamente non sono né veri, né falsi, ma sono proprietà del giudizio che li connette e diventano veri o falsi in rapporto al loro significato finale. Altri tipi di proposizioni non assertorie, che quindi non seguono il criterio di verità e falsità, sono ad esempio le domande, le preghiere, le esortazioni. Non rientrando nell’ambito delle scienze però non interessano il suo discorso sulla logica.Per ulteriori approfondimenti sul De interpretatione vedi qui
Proposizione verbale: verità e falsità
La proposizione è dunque l'espressione verbale di un giudizio. La forma della proposizione su cui si sofferma Aristotele è quella riducibile a un rapporto predicativo, vale a dire a un enunciato composto da un Soggetto (S), da una copula e da un Predicato (P). Per esempio, "Socrate è un filosofo" (S è P). Si possono ridurre a questo schema anche le proposizioni in cui non è presente la copula, come “Socrate mangia”. Si possono poi classificare le proposizioni secondo criteri di qualità e quantità, verità e falsità. Secondo la qualità una proposizione può essere affermativa o negativa, mentre secondo la quantità può essere universale o particolare. Dalla combinazione di questi criteri si sviluppano quattro tipi di proposizione:- UA: universale affermativa, ad esempio “tutti gli uomini sono mortali”;
- UN: universale negativa, “nessun uomo è mortale”;
- PA: particolare affermativa, “qualche uomo è mortale”;
- PN: particolare negativa, “qualche uomo non è mortale”;
Per ulteriori approfondimenti sulla logica aristotelica vedi qui
Il sillogismo negli “Analitici”
Nel trattato “Analitici Primi”, anch’esso contenuto nell’Organon, Aristotele parla di forma base dell’argomentazione e la individua nel sillogismo, un ragionamento che deduce una conclusione necessaria a determinate premesse. Le premesse del sillogismo sono sempre proposizioni assertorie e solitamente sono due, una premessa minore e una maggiore. La conclusione che ne consegue è anch’essa una proposizione assertoria. Il sillogismo poi si compone di soggetto, predicato e termine medio. Il termine medio compare solo nelle premesse e scompare nella proposizione. Un esempio di proposizione è:- Tutti gli uomini sono mortali (PM)
- Tutti i Greci sono uomini (Pm)
- Tutti i Greci sono mortali (C)

In questo caso il termine medio sono “gli uomini”, che scompare nella conclusione unendo il soggetto, “i Greci”, con il suo predicato, “mortali”. A seconda del ruolo che assume il termine medio nelle premesse (di soggetto o predicato) i sillogismi vengono distinti in tre grandi categorie:
- validi (quando la connessione tra premesse e conclusione è necessaria) ma non veri: le premesse sono false e quindi la conclusione è falsa: “Socrate è un cane, tutti i cani possiedono una stazione di servizio, Socrate possiede una stazione di servizio”;
- validi e veri: “Ogni animale è mortale, ogni uomo è animale, ogni uomo è mortale”;
- non validi ma veri: pur partendo da premesse false giungono a una conclusione vera: “Socrate è greco, tutti i greci sono uomini, Socrate è un filosofo”.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della proposizione nel "De interpretatione" di Aristotele?
- Come Aristotele classifica le proposizioni verbali?
- Che cos'è un sillogismo secondo Aristotele?
- Quali sono le categorie di validità dei sillogismi?
- Quali espressioni linguistiche non rientrano nella logica proposizionale aristotelica?
Nel "De interpretatione", Aristotele si concentra sugli elementi linguistici del discorso, in particolare sulla proposizione, che unisce termini per formare un giudizio, determinando così verità o falsità.
Aristotele classifica le proposizioni secondo qualità (affermativa o negativa) e quantità (universale o particolare), creando quattro tipi: universale affermativa, universale negativa, particolare affermativa e particolare negativa.
Un sillogismo è un ragionamento che deduce una conclusione necessaria da premesse assertorie, composto da soggetto, predicato e termine medio, che appare solo nelle premesse.
I sillogismi possono essere validi ma non veri, validi e veri, o non validi ma veri, a seconda della connessione tra premesse e conclusione e della verità delle premesse.
Espressioni come preghiere, comandi, invocazioni ed esclamazioni non seguono il criterio di verità e falsità e quindi non rientrano nella logica proposizionale aristotelica.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo