Concetti Chiave
- Foscolo critica la sepoltura anonima imposta dall'editto di Saint Cloud, sottolineando l'importanza di un memoriale per il ricordo dei defunti.
- Il culto dei morti è visto come un passaggio dalla barbarie alla civiltà, contrapposto tra il mondo classico e quello medievale, con un elogio alla civiltà inglese.
- Le tombe dei grandi uomini, come quelle nella chiesa di S. Croce a Firenze, rappresentano un patrimonio storico e culturale che ispira i vivi.
- Foscolo evidenzia la superiorità della poesia rispetto alla tomba nel preservare eternamente la memoria e la gloria di un individuo.
- Rievocando il mito di Troia, Foscolo esalta la funzione eternatrice della poesia, capace di perpetuare la memoria di eventi e figure storiche.
Indice
L'importanza dei Sepolcri
A Foscolo interessa argomentare a favore dei Sepolcri.
Deourm - Manium - lura - Sancta - Sunto: i diritti degli dei Mani saranno sacri. Gli dei Mani erano le anime dei defunti; è una citazione della legge latina, attribuita senza certezza alle antichissime dodici tavole. Con essa vuole dimostrare che le anime erano sacre fin dall’antichità.
La concezione materialistica della morte
Le due domande con le quali si apre il carme dicono in sostanza la stessa cosa: la sepoltura, con i suoi riti e i suoi onori, serve forse a ripagare la perdita causata negli uomini dalla morta? La risposta è implicita, ed è negativa, come dimostra soprattutto l’appassionato elenco dei beni della vita (vv. 3-12), cui corrisponde il misero “sasso” (metonimia = tomba) del verso 13, si tratta cioè retoriche.
Foscolo qui utilizza la litote filosofica, ovvero nega il concetto attraverso la privazione degli elementi degli elementi della vita.
In linea con le correnti di materialismo settecentesco e illuministico, Foscolo esalta insomma la gioia della vita e denuncia l’inesorabile significato negativo della morte.
Successivamente compare la concezione materialistica della morte: la vita è costituita da una forza operosa che costringe tutte le cose a trasformarsi continuamente, così che l’uomo non può garantire nessuna durata nel tempo né a se stesso né alla propria memoria o ciò, come le lapidi sepolcrali, che dovrebbero proteggerla.
Il sentimento contro la ragione
Il “ma” avversativo e pesante del verso 23 rappresenta la ribellione dell’uomo, la rivalsa del sentimento sulla ragione: siamo oltre l’Illuminismo, Foscolo anticipa il Romanticismo, è definito un preromantico, che sta ancora vagliando tutti gli argomenti con la ragione, ma inizia a far prevalere il sentimento.
Dapprima Foscolo nega l’utilità della tomba tramite la ragione, ma il sentimento permette all’uomo di illudersi. L’uomo può vivere ancora nel ricordo dei cari e con la tomba è possibile questa illusione. Questo legame di sentimenti affettuosi, questa corrispondenza di amorosi sensi è una dote divina dell’uomo, una sua specifica nobiltà. Infatti egli si oppone a questo modo, sia pure per una passeggera illusione, ai limiti materiali della sua condizione e della natura.
Contrapposizione: fino al verso 22 le due domande retoriche presuppongono una risposta negativa (vv. 16-22); qui è la ragione che pone queste domande (prospettiva razionalistica): il tempo distrugge e travolge tutto quindi la tomba non ha nessuna importanza. Dopo il “ma” del verso 23 arriva una prospettiva sentimentale con ancora due domande retoriche che però presuppongono una risposta positiva: l’uomo può sopravvivere grazie alla possibilità di essere ricordato tra i vivi, a patto che lasci eredità di affetti; questa condizione vincolante viene espressa in negativo.
Dal verso 41 al verso 50 viene ribadito lo stesso concetto con un’argomentazione opposta: chi non ha una “corrispondenza d’amorosi sensi” non può sperare di sopravvivere, neanche in una tomba. Quindi l’uomo per sperare di sopravvivere deve fare in modo di lasciare un ricordo di sé.
L'editto di Saint Cloud e Parini
La “nuova legge” alla quale si allude al verso 51 è l’editto di Saint Cloud (5 settembre 1806), con il quale veniva estesa alle provincie italiane una normativa già attiva in Francia dal 1804. Essa vietava la sepoltura nei centri abitati, interrompendo l’uso corrente, e introduceva un controllo sulle iscrizioni funerarie, che dovevano essere consone allo spirito della Rivoluzione Francese, e pertanto non contenere, per esempio, riferimenti ai titoli nobiliari. In ogni caso le sepolture dovevano essere anonime, e la collocazione delle lapidi era relegata ai margini dei cimiteri.
Rimane vittima di questa legge il grande Giuseppe Parini, che Foscolo considerava suo maestro, “sacerdote”; morto nel 1799, i suoi resti andarono a finire in una fossa comune.
Foscolo si immagina che Talia, la musica classica della poesia satirica, vaga a cercare il corpo di Parini ma non lo trova, e potrebbe anche essere che un assassino con il capo mozzo insanguini le ossa di questo grande. Quindi con l’editto di Saint-Cloud non vale più la meritocrazia: Parini non ha una tomba degna della sua grandezza.
Critica alla cultura milanese
Dal verso 70 si apre una parentesi lugubre, tipica del Romanticismo inglese. È presenta una feroce critica della cultura milanese, che osannava la moda dei cantanti castrati, attraendoli con compensi e onori sindacati, e ignorava un poeta grande come Parini, non assumendosi neppure dopo la morte il dovere di ricordarne e onorarne la figura (i cantanti lirici, fino ai tempi di Verdi, erano tutti uomini, e per sviluppare la voce femminile venivano evirati).
Dal verso 70 al verso 86, attraverso uno scenario lugubre, Foscolo implicitamente ci sta dicendo che è ingiusto che un poeta così grande non abbia una degna sepoltura: un’affamata cagna randagia e un malaugurante uccello notturno funestano e violano la pace dei camposanti, compromettendo la serenità di Parini.
Conclusione versi 88-90: è necessario che la tomba di un defunto sia lacrimata, abbia le lodi dei vivi e un pianto affettuoso per far si che esso sia ricordato.
Contrapposizione tra sepolture
Tesi: L’esempio medievale è negativo: cadaveri in chiesa, scheletri raffigurati ovunque, terrore superstizioso per le pretese da parte dei defunti di ricevere messe di suffragio.
Tutto ciò si oppone al mondo classico, dove il culto dei morti era invece positivo (tombe circondate dai giardini).
La sepoltura pagana è inserita in una cornice luminosa, molto diversa dalla sepoltura cristiana, caratterizzata da cattivo odore (lezzo), gemiti e figure macabre.
Nell’antichità classica ritorna la corrispondenza d’amorosi sensi del verso 30 e ritorna in mente anche il sonetto “In morte del fratello Giovanni”. Anche ai tempi di Foscolo c’è una civiltà in cui il culto dei morti è positivo: la civiltà inglese, che viene richiamata per analogia con la civiltà classica. E dall’esempio del costume inglese trae spunto la rievocazione dell’eroismo dell’ammiraglio Nelson, che sconfisse la flotta francese e spagnola a Trafalgar (1850), trovando la morte in battaglia. Quindi la tomba anche un luogo di incitamento patriottico.
Dal verso 137 al verso 141 c’è di nuovo una contrapposizione: come i cimiteri ispirano virtù dove l’eroismo è praticato e onorato (per esempio nell’Inghilterra di Nelson), così i segni che ricordano la morte servono solamente a manifestare sfarzo e a provocare repulsione dove invece (come nell’Italia contemporanea del poeta) l’eroismo e la virtù sono tramontati e dominano la ricchezza dei potenti e la viltà degli oppressi. E con questa contrapposizione Foscolo entra nel vivo della polemica politica: egli è italiano, ma non vuole far parte di questa categoria di persone, non vuole lasciare di sé lapidi inutili o ricchezze in eredità, ma vuole lasciare una poesia che parli di libertà, dignità umana e “caldi sensi” (= sentimenti appassionati).
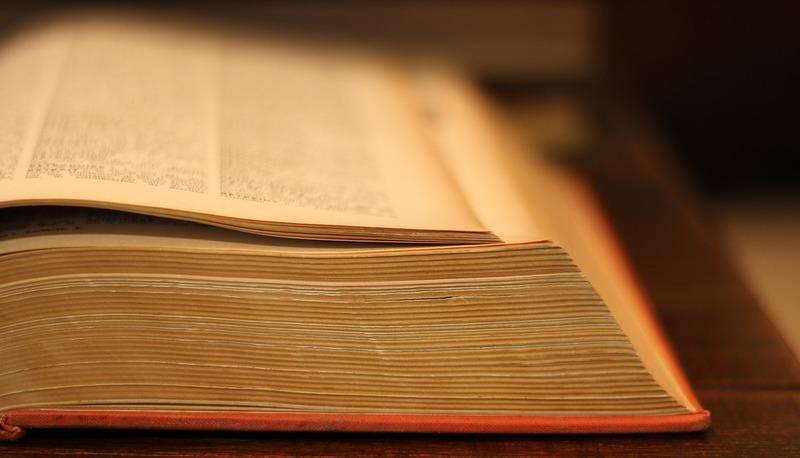
Esempi di grandi uomini
Dopo il valore affettivo e civile delle tombe viene qui approfondita l’importanza storica delle tombe.
Tesi: le tombe dei grandi uomini (“forti”) sono di esempio per i vivi ed aumentano la gloria della nazione che li ospita (vv. 151-154). Segue l’esempio di Firenze, dove nella chiesa di S. Croce sono riunite le tombe di tanti grandi uomini citati con le loro imprese da Foscolo:
- Macchiavelli, che ha parlato di politica; Foscolo in questi versi accoglie la teoria secondo cui egli scrisse il Principe non per insegnare ai principi a regnare, ma dando loro consigli, vuol dire che in realtà il governo dei potenti è basato sulla sofferenza. Questa interpretazione del Principe come opera rivolta ai popoli per smascherare l’orrore del potere tirannico risale al Cinquecento ma fu diffusa nel secondo Settecento.
- Michelangelo, che ha costruito un Olimpo celeste a Roma, la cupola di San Pietro. Foscolo è laico e anche qui c’è la concezione laica di questa impresa: vengono designati elementi cristiani attraverso elementi pagani.
- Galileo,che scoprendo che tanti mondi girano intorno al Sole, permise a Newton di scoprire le leggi della gravitazione universale. Attenzione! Newton, pur essendo implicitamente citato, non è sepolto a Firenze.
Versi 173-175: l’esaltazione di Firenze è accompagnata da un’altra critica alla situazione dell’Italia, che per colpa del fato e dei governanti ha perso tutto. L’unico elemento che resta all’Italia è la memoria dei grandi uomini, come Vittorio Alfieri (e Giuseppe Parini).
Parini è visto come poeta civile che compone opere per migliorare e criticare la società.
Alfieri è visto come poeta patriottico che, ispirandosi alle tombe dei grandi, compone le sue opere per esaltare e difendere la patria.
Poi per analogia, con un trapasso logico molto repentino, Foscolo avvicina le tombe di S. Croce alle tombe dei soldati di Maratona (490 a. C.). Foscolo rievoca la battaglia ancora con un gusto lugubre, tipico del preromanticismo inglese, e dice che chi è passato di notte nella zone di mare antistante il terreno dello scontro di Maratona, ha avuto modo di vedere ancora i segni della battaglia, la quale si ripeterebbe ogni notte. La fonte di questa credenza è il geografo greco Pausania.
Qui il ritmo è incalzante e il lessico solenne e foneticamente aspro.
Funzioni della poesia secondo Foscolo
Ha come tema la funzione della poesia, che per Foscolo ha tre funzioni:
- eterna la gloria di un uomo poiché se egli è stato grande sarà cantato da un poeta (funzione eternatrice);
- consola l’uomo alleviando le sue sofferenze (funzione consolatrice);
- ispira pietà per le sofferenze.
Altra funzione che qui non c’è è quella resserenatrice (“Alla sera”), cioè la poesia riesce a dare felicità all’animo di un uomo.
Tesi:Foscolo spera di comporre opere così grandi da rimanere per l’eternità e vorrebbe essere un nuovo Omero, in modo tale che il suo ricordo non possa essere dimenticato.
Foscolo allora rievoca il mito di Troia cantato da Omero.
Versi 235-295: in questi versi Foscolo riporta come esempio della funzione eternatrice della poesia la vicenda di Troia distrutta dai Greci. Ricorda che a Troia c’è la tomba di Elettra, la ninfa che unendosi ha Giove ha generato il figlio Dardano, da cui ebbe origine la stirpe troiana. Presso la tomba di Elettra andavo a pregare le donne di Troia per la salvezza dei loro mariti durante la guerra contro i Greci, andò a profetizzare Cassandra, che prediceva il vero ma non veniva mai creduta e che profetizzò la fine di Troia e l’immortalità delle tombe troiane; essa prega palme e cipressi di difendere le tombe finché un giorno arriverà “Mendico un cieco”, cioè Omero, che prendendo ispirazione da queste tombe canterà la grandezza di Troia, e con la sua poesia esternerà sia i vinti, come Ettore (troiano), sia i vincitori, consolerà i vinti per il dolore e ispirerà pietà per le sofferenze (terza funzione della poesia).
per approfondimenti vedi anche:
Analsii di Dei Sepolcri di Ugo Foscolo
Foscolo, Ugo - Il carme dei Sepolcri
Foscolo, Ugo - Dei sepolcri, introduzione
Domande da interrogazione
- Qual è l'importanza dei Sepolcri secondo Foscolo?
- Come Foscolo contrappone il sentimento alla ragione?
- Qual è la critica di Foscolo all'editto di Saint Cloud?
- In che modo Foscolo critica la cultura milanese?
- Quali sono le funzioni della poesia secondo Foscolo?
Foscolo argomenta a favore dei Sepolcri, sostenendo che le anime dei defunti erano considerate sacre fin dall'antichità, come dimostrato dalla citazione della legge latina.
Foscolo inizialmente nega l'utilità della tomba tramite la ragione, ma poi il sentimento permette all'uomo di illudersi, creando un legame affettuoso che sfida i limiti materiali della condizione umana.
Foscolo critica l'editto di Saint Cloud per aver reso anonime le sepolture e per aver negato a grandi uomini come Parini una tomba degna della loro grandezza, riflettendo una mancanza di meritocrazia.
Foscolo critica la cultura milanese per aver osannato i cantanti castrati e ignorato un grande poeta come Parini, non onorandolo adeguatamente neanche dopo la morte.
Foscolo attribuisce alla poesia tre funzioni principali: eternare la gloria di un uomo, consolare l'uomo alleviando le sue sofferenze, e ispirare pietà per le sofferenze.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo