Concetti Chiave
- L'Ermetismo è una corrente letteraria nata a Firenze negli anni '30, influenzata dal Decadentismo e dai simbolisti francesi, caratterizzata da una poesia scarna e oscura.
- Giuseppe Ungaretti, poeta di spicco del Novecento, utilizza la poesia come strumento di conoscenza, con un linguaggio essenziale influenzato dalle sue esperienze di guerra.
- Le opere di Ungaretti, come "L'allegria", affrontano temi di precarietà e attaccamento alla vita, esprimendo solidarietà umana attraverso immagini di guerra e morte.
- "Il porto sepolto" rappresenta il mistero dell'animo umano e il ruolo del poeta nel rivelare ciò che è nascosto, attraverso uno stile frammentario e essenziale.
- "Mattina" esprime un momento di pienezza e apertura verso il mondo, esemplificando la poetica di Ungaretti con una riduzione progressiva dei versi e l'uso della sinestesia.
Indice
Ermetismo
L'Ermetismo è un'avanguardia letteraria che nasce a Firenze intorno alle riviste “Il Frontespizio” e “Campo di Mart all'incerca nel 1930 e si sviluppa nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, terminando con l'irrompere del Neorealismo. Il termine "ermetismo" deriva da Ermes, il Dio delle scienze occulte, ed è stato operato in senso dispregiativo per descrivere la lirica scarna delle poesie come se i poeti praticassero una scienza occulta. La poesia ermetica riprende i temi del Decadentismo europeo, in particolar modo dei simbolisti francesi. Da Baudelaire assimila la concezione della corrispondenza tra le cose (i legami più nascosti tra le cose), da Rimbaud e la concezione dei versi come un'illuminazione dovuta ad improvvise folgorazioni e da Verlaine il rifiuto della ricercatezza metrica.
Temi
Concezione della poesia: la poesia ermetica rifiuta la concezione della scrittura come celebratrice di ideali romantici o positivisti (religione, patria, eroismo e fede), ma come una scrittura libera dalle forme e da ognifinalità pratica. Il motivo centrale che accomuna gli ermetici alle tematiche di Svevo e Pirandello è il senso della solitudine dell'uomo moderno che non ha più certezze a cui ancorarsi in un mondo sconvolto dalla
guerra.
Sfiducia: ne consegue una visione della vita sfiduciata: Ungaretti è inizialmente un uomo di pena, Quasimodo ritiene che la vita sia una condanna destinata a terminare.
Linguaggio: il linguaggio poetico è contraddistinto da parole essenziali e dall'uso frequente dell'analogia (paragone privo delle particelle) e della sinestesia (l'accostamento di sensazioni avvertite con due sensi diversi simultaneamente).
La poesia ermetica viene considerata una poesia per poche persone, oscura, indecifrabile e soggettiva, che deve solo ed esclusivamente dare degli spunti dal quale puoi ricavare la propria interpretazione personale. Tale corrente eredita dalla tradizione del primo Novecento sia l’uso del verso libero sia le tematiche spirituali e interiori.
Giuseppe Ungaretti
Giuseppe Ungaretti è una delle voci più importanti della poesia del Novecento. Egli è un intellettuale cosmopolita, che riconosce come patria il mondo, motivo per cui si sente cittadino di esso. Interpreta il bisogno di rinnovamento che caratterizza la cultura di inizio secolo, elaborando una poetica originalissima, che costituirà un punto di riferimento per coloro che lo seguiranno e in particolar modo per i cosiddetti ermetici. Egli, attraverso le sue poesie, riesce a trasmettere al lettore l'urgenza di vivere di fronte all'atrocità della morte con un linguaggio nudo.Influenzato dal Simbolismo. Si arruola volontario nella Prima Guerra Mondiale e aderisce al fascismo.
Pensiero
Ungaretti concepisce la poesia come strumento di conoscenza della realtà, in linea con la concezione di Pascoli e in opposizione a quella di D'Annunzio. Si propone di analizzare la coscienza dell'uomo in relazione prima a sé stesso, poi al resto del mondo. Il metodo utilizzato è quello analogico: attraverso improvvise folgorazioni o deduzioni, il poeta scopre le relazioni più nascoste tra gli esseri viventi, riconoscendone le difficoltà che tramutano in speranza con una presa di coscienza (fede in Dio). Pertanto, Ungaretti da uomo di pena diventa uomo di fede e tale itinerario è sintetizzato nel titolo “Vita di un uomo” che racchiude tutte le sue opere. Questa concezione della poesia è stata adattata con l'uso di una parola nuda ed essenziale attraverso l'uso dell'analogia (l’accostamento immediato di due immagini, fondato sul rapporto di somiglianza senza il come) e della sinestesia (l’accostamento di sensazioni diverse avvertite simultaneamente). Terminata la guerra, continua la sua meditazione sulla poesia e sulla condizione dell'uomo, però attraverso il recupero dell'endecasillabo e del settenario (poiché rispondono all’esigenza che avverte di comunicare agli uomini le sue scoperte, di essere insomma il poeta veggente dei simbolisti).
Opere
Porto sepolto (1916): la prima raccolta poetica è il Porto sepolto che contiene le poesie scritte sul fronte di guerra su pezzi di carta occasionali. Il titolo allude a un porto reale nei pressi di Alessandria, ma ha un significato simbolico: rappresenta il mistero della morte e il simbolo del viaggio introspettivo del poeta alla ricerca del mistero dell'essere umano.Allegria(1931): le liriche del Porto sepolto insieme alla raccolta Allegria dei naufragi (1919) compongono l'Allegria. Anche in questo caso il titolo è allusivo, esprime la gioia che l'animo umano prova nell'attimo in cui si rende conto di essere scampato al pericolo della morte (naufragio) e guarda al domani con fiducia. La raccolta comprende le impressioni della Prima Guerra Mondiale: il sentimento dell'attaccamento alla vita che spinge il poeta a richiamare la speranza quando è costretto a passare un'intera nottata vicino a un compagno morente (Veglia); le case distrutte sono paragonate alle membra delle persone a cui Ungaretti è legato (San Martino del Carso); il sentimento della precarietà della vita (Soldati). A differenza di D'Annunzio, la guerra non è vista da Ungaretti come un'occasione di eroismo, ma come una disgrazia ineluttabile che si abbatte sull'umile gente. A contatto con la morte in trincea, il poeta percepisce la bellezza della vita e recupera un sentimento di solidarietà verso il prossimo e tutte le creature viventi. Tutte le poesie dell'Allegria sono datate e recano la segnalazione del luogo di composizione, così che, nell'insieme, costituiscono una sorta di diario autobiografico in una particolarissima stagione di vita. Si tratta di poesie innovative soprattutto sul piano stilistico: adopera versi liberi, brevi e semplici, abolendo la punteggiatura, impiegando spazi bianchi e titoli suggestivi.
Il Sentimento del tempo (1933): il Sentimento del tempo segna il passaggio alla seconda fase della poesia ungarettiana (il poeta recupera la versificazione tradizionale, la sintassi è composta da periodi più lunghi, il lessico è elevato e denso di oscuri significati) e tratta della caducità della vita. A fare da sfondo alle vicende sono i resti dei monumenti romani, simbolo del trascorrere degli anni. All'interno del titolo è racchiuso il significato dell'opera. Con il veloce scorrere del tempo, Ungaretti intende trasmettere la nostalgia del passato e un più tenace attaccamento alla vita. A questa tematica è affiancata la fede verso Dio inteso come un'entità superiore in grado di consolare.
Il dolore(1947): le poesie raccolte nella raccolta traggono origine da due esperienze del poeta, la prima individuale (la morte del figlio), l'altra collettiva (Seconda Guerra Mondiale). Entrambe ispirano allo scrittore un messaggio d'amore e di solidarietà tra gli uomini. Qui, il dolore personale del poeta si fonde con quello universale provocato dalla guerra. Lo stile è spesso alto e sublime.
La Terra promessa(1950): tornano i motivi della morte e del nulla, accentuati da una diffusa sensazione di disfacimento e desolazione. L’ispirazione nasce da un viaggio del poeta in Campania; da qui l’atmosfera mitica che aleggia in tutti i componimenti.
Il porto sepolto (1916, da L’allegria)
Il poeta stesso ha spiegato più volte nei suoi scritti il senso del titolo: da ragazzo conobbe dei giovani ingegneri francesi che gli parlarono di un porto sommerso esistente ad Alessandria d’Egitto, città natale dell’autore. Ungaretti descrive l’opera del poeta come una sorta di avventura, come una discesa in questo porto sepolto per riportare alla luce soltanto dei frammenti che non possono essere decifrati. Il porto sepolto diventa quindi il simbolo di ciò che è nascosto nell’animo di ogni uomo. La prima strofa si apre con l’avverbio di luogo “vi”, che si riferisce al titolo della poesia. Il poeta infatti arriva nel porto sepolto perché esso diventa il luogo da cui nasce la poesia. Il poeta ci arriva, torna in superficie con le sue poesie e le disperde tra gli uomini, un po’ come il palombaro che trova dei reperti antichi e li riporta alla luce. La funzione del poeta è quindi quella di scoprire cosa è rimasto sepolto nell’animo degli uomini e riportarlo in vita, tentando di dare un sollievo alle sofferenze dell’uomo. La seconda strofa è una riflessione fatta sulla base della prima e quindi sull’opera del poeta stesso. Cosa ha trovato in fondo all’animo umano? Nulla, perché il cuore degli uomini è un segreto inesauribile. Solo il poeta, che ha un animo sensibile, riesce a percepire ciò che è nascosto nel cuore di ognuno e a tradurlo in poesia. Ci sono numerosi enjambements, che vengono utilizzati da Ungaretti per rendere il testo ancora più frammentario. Lo stile, la metrica e la sintassi sono quindi ridotti all’essenziale, conta soprattutto l’importanza della parola stessa, messa in evidenza attraverso l’utilizzo di versi molto brevi.
Veglia (1915, da L’allegria)
Tra le poesie dell'Allegria è riportata la poesia Veglia, scritta su un brandello di carta qualche notte prima del giorno di Natale in cui il poeta coglie la tragicità della guerra distaccandosi dalle celebrazioni dei futuristi che la definiscono "sola igiene dei popoli" (Marinetti). La parola è scabra ed essenziale perché, spiega Ungaretti, tra i morti non c'era tempo per perfezionare il verso, ma servivano parole decise e assolute. Accanto a lui giace, come un oggetto inanimato, il cadavere di un suo compagno mutilato dalle armi. La sua bocca è rivolta verso il plenilunio, il simbolo della dolcezza e della bellezza dell'esistenza, infatti proprio in quel momento Ungaretti avverte la necessità di scrivere (scrittura come forma di salvezza) e dichiarare per contrasto il suo attaccamento alla vita.
San Martino del Carso (1916, da L’allegria)
In San Martino del Carso il poeta descrive il paese distrutto dalla guerra, per parlare della desolazione che avverte nel suo cuore, a causa della dolorosa perdita di tanti amici cari. Ancora una volta trova nelle immagini esterne una corrispondenza con quanto egli prova nei confronti dell’uomo, annullato dalla guerra. La lirica, di un’estrema essenzialità, è tutta costruita su un gioco di rispondenze e di contrapposizioni sentimentali, ma anche verbali: di San Martino del Carso resta qualche brandello di muro, dei morti cari allo scrittore non resta nulla; San Martino è un paese straziato, più straziato è il cuore del poeta. Ungaretti riesce a rendere con il minimo di parole la sua pena e quella di tutto un paese, e dà vita a una lirica tutta nuova. La metafora “brandello di muro” riconduce all’immagine di corpi mutilati, straziati, ridotti a brandelli. Anche se nulla è rimasto dei compagni morti, “nessuna croce manca”: non è svanito il ricordo di nessuno di quei morti. Le croci suggeriscono l’immagine di un cimitero ma richiamano, naturalmente, anche al sacrificio e alla morte del Cristo. L’immagine finale del cuore straziato richiama quella iniziale del brandello di muro, racchiudendo il componimento in un cerchio di dolore.
Mattina (1917, da L’allegria)
Mattina è uno dei testi più famosi di Ungaretti. La versione iniziale era composta da cinque versi ed era intitolata Cielo e mare; qui era presente una parte finale che specificava la modalità con cui la sensazione descritta nei primi due versi era percepita. Dal titolo comprendiamo che il poeta sta descrivendo l’esperienza di un uomo che assiste al sorgere del sole dopo l’oscurità notturna: Ungaretti ricorre a un’immagine di vita vissuta che potrebbe riferirsi a un momento felice, consumatosi dopo una nottata sulla spiaggia, passata in compagnia degli amici o, più probabilmente , a un momento liberatorio, vissuto all’alba dopo un’intera notte insonne vissuta al fronte. La sensazione che Ungaretti vuole esprimere è difficilmente comunicabile: una particolare intensità che dona un senso di pienezza e di grandiosità e permette di stabilire un rapporto con una totalità alla quale raramente è possibile accedere. Il poeta si trova improvvisamente di fronte allo spettacolo della vita che risorge dopo l’oscurità notturna, resa ancor più difficile da sopportare dalla durezza del conflitto bellico. Mattina esprime un’epifania, una sensazione fulminea e destabilizzante e, allo stesso tempo, un senso profondo di pienezza e di apertura verso l’esterno, prodotto nell’uomo da un istante di sintonia tra la sua interiorità e il mondo che lo circonda; un istante raro e particolarmente difficile da vivere in una condizione come quella della guerra.La poesia rappresenta al meglio anche la poetica di Ungaretti, fondata sulla fiducia nel valore esemplare della parola. La tecnica con cui Ungaretti ottiene la versione finale di Mattina è, dunque, quella del levare: riduce progressivamente la quantità di versi e di termini utilizzati per esprimere il nucleo centrale del componimento. Dal punto di vista retorico la figura predominante è senz’altro la sinestesia; luminosità e immensità si percepiscono, infatti, in modo diverso: mentre la prima è una sensazione di carattere visivo, la seconda è una condizione che viene colta dalla mente, una presenza che si dischiude nell’interiorità del poeta.
Soldati (1918, da L’allegria)
Soldati è una brevissima poesia contenuta all'interno dell'Allegria e scritta durante il passaggio in Francia della fanteria italiana. I soldati, così come tutti gli esseri umani, sono contraddistinti dalla condizione di essere esposti ai rischi della guerra, al pari delle foglie fragili sugli alberi che al più lieve soffio di vento si staccano dei rami e sul terreno. Il poeta, che ha visto morire tanti compagni durante i combattimenti, ha voluto rappresentare attraverso nove parole (la lunghezza dell'epigramma) la vulnerabilità della vita. Il "si" impersonale e il verbo al presente accentuano il carattere temporale e universale della lirica.Domande da interrogazione
- Qual è l'origine e il significato dell'Ermetismo nella letteratura italiana?
- Come Giuseppe Ungaretti interpreta la poesia e qual è il suo contributo alla letteratura del Novecento?
- Quali sono i temi principali delle poesie di Ungaretti raccolte in "L'allegria"?
- In che modo la poesia "Il porto sepolto" di Ungaretti rappresenta il suo approccio alla scrittura poetica?
- Qual è il significato della poesia "Mattina" e come rappresenta la poetica di Ungaretti?
L'Ermetismo è un'avanguardia letteraria nata a Firenze intorno al 1930, caratterizzata da una poesia scarna e oscura, influenzata dal Decadentismo europeo e dai simbolisti francesi.
Ungaretti vede la poesia come uno strumento di conoscenza della realtà, utilizzando un linguaggio nudo ed essenziale. È una figura centrale del Novecento, influenzata dal Simbolismo e dalla sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale.
I temi principali includono la precarietà della vita, l'attaccamento alla vita di fronte alla morte, e la solidarietà umana, spesso espressi attraverso immagini di guerra e morte.
"Il porto sepolto" simboleggia il mistero dell'animo umano e il compito del poeta di riportare alla luce ciò che è nascosto, utilizzando uno stile frammentario e essenziale.
"Mattina" esprime un'epifania di pienezza e apertura verso il mondo, rappresentando la fiducia di Ungaretti nel valore esemplare della parola attraverso una riduzione progressiva dei versi.

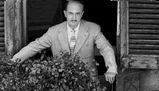





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo