Concetti Chiave
- Giacomo Leopardi nacque a Recanati nel 1798 e visse in un ambiente familiare rigido e nobile, ma economicamente in declino.
- Durante gli anni giovanili, Leopardi studiò intensamente come autodidatta e iniziò a scrivere lo "Zibaldone", una raccolta di riflessioni su vari argomenti.
- Nel 1822, dopo aver lasciato Recanati, visse a Roma, Bologna e Milano, scrivendo opere significative come le "Operette Morali" e i "Canti".
- Il pensiero di Leopardi evolse verso un pessimismo cosmico, considerando la natura maligna per l'infelicità intrinseca degli esseri viventi.
- La poetica del vago e dell'indefinito di Leopardi valorizzava l'immaginazione come mezzo per trovare felicità, esemplificata nella sua poesia "L'Infinito".
In questo appunto viene descritta la vita, il pensiero e la poetica di Giacomo Leopardi. Di seguito vengono riportate alcune informazioni brevi sulla vita dell’autore, gli anni giovanili, la formazione, i viaggi e le opere scritte nel corso degli anni.
Indice
Cenni sulla vita di Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi nasce a Recanati nel 1798 e muore a Napoli nel 1837. Recanati, a quel tempo, faceva parte dello Stato Pontificio e quindi era arretrata sia per l'agricoltura che per la cultura. Riguardo la sua famiglia, Leopardi aveva nobili origini: il padre era il conte Monaldo Leopardi mentre la madre era Adelaide Antici. D’un tratto la famiglia cominciò ad avere problemi economici: il patrimonio andava riducendosi pian piano e la madre incolpò il padre per aver comprato tanti volumi costosi per la sua biblioteca personale. Quindi Leopardi è cresciuto in un ambiente familiare molto chiuso, freddo e severo.Per ulteriori approfondimenti sul pensiero e la poetica di Giacomo Leopardi vedi anche qua
Anni giovanili di Giacomo Leopardi e formazione
Dal 1808 al 1815 per Leopardi sono stati anni di studio molto intensi. Era molto giovane e stava molto spesso da solo dedicandosi allo studio inizialmente con l’aiuto di precettori, successivamente come autodidatta. Conosceva diverse lingue come il latino, il greco, l'ebraico, l'inglese, il francese e lo spagnolo. Nel 1817 Leopardi si dedica alla scrittura dello “Zibaldone”, una raccolta di pensieri, una sorta di diario che scrisse fino al 1832, in cui vi annota riflessioni su vari argomenti, pensieri filosofici, dichiarazioni di poetica. Nel 1819 decise di andare a Roma ma fu riportato a casa. Entrò quindi in uno stato di profonda tristezza, inoltre una malattia agli occhi gli impedì di dedicarsi alla lettura. Da questo periodo emersero nuovi ed importanti spunti: la conversione al bello e la composizione di Idilli (“Infinito”) e canzoni.La conversione al bello era una constatazione amara. Si rese conto che la poesia d'immaginazione ai moderni non era possibile; i moderni potevano fare solo una poesia sentimentale, esprimendo l'unico sentimento che si potesse provare ovvero l'infelicità, e filosofica. Diceva questo a malincuore perché lui aveva detto anni prima di essere a favore della poesia classicista, però si rende conto che alle persone del suo tempo non riesce comporre poesie classiciste. Leopardi viveva a Recanati ma la vedeva come una prigione dalla quale però riuscì ad evadere grazie all'amicizia e allo scambio di lettere con Giordani e alla partecipazione alla polemica classico – romantica.
Per ulteriori approfondimenti sul pensiero e la poetica di Giacomo Leopardi vedi anche qua
Soggiorni fuori da Recanati e stesura delle opere più importanti
Intorno al 1822 Leopardi aveva finalmente il permesso di andare a Roma dove raggiunge uno zio materno. Ma per lui Roma è una grande delusione, lo infastidì questa vecchia cultura, legata a un rigoroso classicismo archeologico. Sostenne che non ci fosse più nulla della cultura classica. Dopo qualche anno, si spostò tra Bologna e Milano, qui firma un contratto con l'editore Stella che gli pubblicò le Operette Morali, scritte dal 1823 al 1827. L’anno seguente andò a Pisa: ormai la sua salute era cagionevole ma qui trovò un clima mite e stava bene iniziando così la seconda stagione poetica. Scrisse alla sorella che sentì in lui un "risorgimento poetico". Fu il periodo in cui scrisse "A Silvia". Scrive i Canti, che i critici hanno voluto chiamare i Grandi Idilli, de Sanctis li ha definiti Canti pisano – recanatesi. Infatti, a Pisa non potè stare a lungo perché la sua salute non era delle migliori. Nel 1833 si trasferì a Napoli dall'amico Antonio Ranieri e lì nel 1837 morì.Per ulteriori approfondimenti sul pensiero e la poetica di Giacomo Leopardi vedi anche qua
Pensiero di Giacomo Leopardi
Il pensiero dello scrittore viene descritto in fasi diverse perché evolve nel corso degli anni. Nel suo pensiero rientra la Teoria del piacere: non è formulata da egli stesso, ma già esisteva nel 1700. La novità del suo pensiero consiste nell'aver espresso l'idea che qualsiasi essere vivente è destinato ad una profonda infelicità. Ogni creatura venire al mondo con dentro di sé la voglia del piacere assoluto ovvero la felicità. Questo desiderio è infinito per durata e per estensione.Per ulteriori approfondimenti sul pensiero e la poetica di Giacomo Leopardi vedi anche qua
Pessimismo di Giacomo Leopardi
Il pessimismo leopardiano viene suddiviso in fasi:- Pessimismo storico (1819 - 21): Leopardi afferma che l’epoca in cui vive sia più infelice dell'epoca antica. L’avanzare della tecnologia ha reso l'uomo più infelice. Afferma che la natura è benigna mentre la ragione è nemica della natura. È positiva la presenza della natura che fornisce agli uomini la capacità di vedere le cose sotto una luce positiva, di illudersi.
- Pessimismo cosmico (dal 1824): questa concezione è testimoniato dal Dialogo con l'islandese (Operette morali). Si modifica la maniera di concepire la natura, non è più benigna ma maligna perchè è responsabile di infondere agli uomini il piacere infinito ma non dà loro la possibilità di soddisfarlo. È colpevole perché non le sta a cuore il destino del singolo ma solo la preservazione della specie. La natura è poeticamente rappresentata come una divinità malvagia.
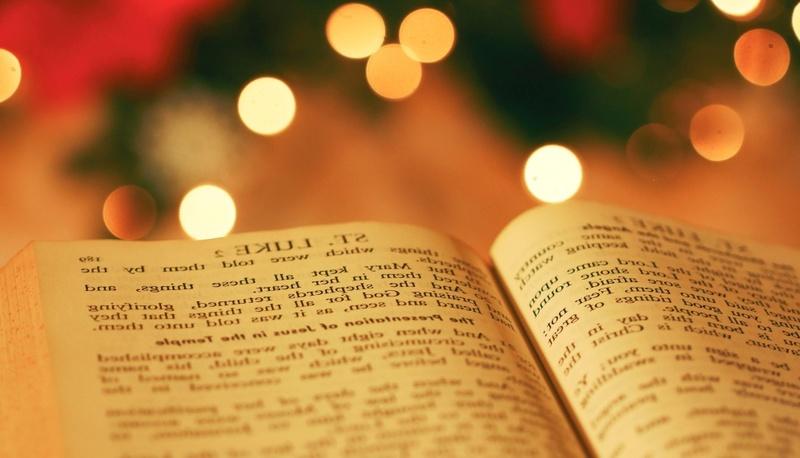
Per ulteriori approfondimenti sul pensiero e la poetica di Giacomo Leopardi vedi anche qua
Poetica del vago e dell'indefinito
Giacomo Leopardi porta avanti una poetica legata alla teoria del piacere:- il piacere nella realtà non è infinito, la felicità nella realtà non c'è;
- nell'immaginazione il piacere è infinito, la realtà immaginata è parallela a quella vissuta che però è infelice invece l'immaginazione è felice. Quindi, è necessario stimolare l'immaginazione e quindi ricorrere a immagini vaghe e indefinite.
Per ulteriori approfondimenti sul pensiero e la poetica di Giacomo Leopardi vedi anche qua
Domande da interrogazione
- Quali sono le origini familiari di Giacomo Leopardi e come hanno influenzato la sua crescita?
- Come si è sviluppata la formazione di Leopardi durante gli anni giovanili?
- Quali furono le esperienze di Leopardi durante i suoi soggiorni fuori da Recanati?
- In cosa consiste il pessimismo di Leopardi e come si evolve nel tempo?
- Qual è la poetica del vago e dell'indefinito di Leopardi?
Giacomo Leopardi proveniva da una famiglia nobile, con il padre conte Monaldo Leopardi e la madre Adelaide Antici. La famiglia affrontò problemi economici, e Leopardi crebbe in un ambiente chiuso, freddo e severo, influenzando la sua visione del mondo.
Tra il 1808 e il 1815, Leopardi si dedicò intensamente allo studio, inizialmente con precettori e poi come autodidatta. Conosceva diverse lingue e iniziò a scrivere lo "Zibaldone", una raccolta di pensieri e riflessioni filosofiche.
Leopardi visitò Roma, Bologna, Milano e Pisa. A Roma fu deluso dalla cultura classica, mentre a Pisa trovò un clima favorevole che stimolò la sua produzione poetica, portando alla scrittura di opere come "A Silvia".
Il pessimismo di Leopardi si divide in due fasi: il pessimismo storico, che vede la modernità più infelice dell'antichità, e il pessimismo cosmico, che considera la natura maligna per aver dato all'uomo un desiderio di piacere infinito senza possibilità di soddisfarlo.
La poetica del vago e dell'indefinito di Leopardi si basa sull'idea che il piacere e la felicità siano infiniti solo nell'immaginazione. L'arte deve stimolare l'immaginazione attraverso immagini vaghe e indefinite, come esemplificato nella poesia "L'Infinito".






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo