Concetti Chiave
- Giovanni Pascoli, uno dei principali autori italiani, è noto per la sua poetica del fanciullino, che esalta la capacità del poeta di vedere il mondo con occhi di bambino, cogliendo la realtà nella sua essenza più pura e sorprendente.
- La tragica morte del padre e altri lutti familiari influenzarono profondamente la sua vita e opera, portandolo a sviluppare il tema del "nido", simbolo di protezione e rifugio dalla realtà esterna.
- Pascoli ha scritto numerose opere significative, tra cui le raccolte di poesie "Myricae" e "Canti di Castelvecchio", che esplorano temi come la natura, la morte e l'umanità, attraverso un linguaggio simbolico e innovativo.
- La sua poesia si distingue per un linguaggio dettagliato e simbolico, che mescola termini tecnici, dialettali e letterari, e utilizza figure retoriche come analogie e sinestesie per esprimere la complessità delle emozioni umane.
- Pascoli abbraccia una visione del mondo che oscilla tra il pessimismo, dovuto alla crisi del positivismo, e l'ideale di una società solidale, dove il dolore e la sofferenza umana possono essere mitigati attraverso l'amore e la fratellanza.
In questo appunto si parla di Giovanni Pascoli che è considerato uno dei principali autori della letteratura italiana e in assoluto tra i più importanti. Egli nacque a San Mauro di Romagna nel 1855. La sua prima formazione gli fu impartita in un collegio religioso. La sua vita presto fu segnata da un tragico evento, ovvero la morte del padre Ruggero, che fu ucciso mentre stava guidando il suo carro. Questo evento segnò per sempre la vita del giovane Pascoli, il quale ricorrentemente nelle sue poesie proporrà il tema del nido. Dopo poco tempo morì anche la madre del poeta e questi trascorse quindi la sua vita in compagnia delle sorelle Ida e Maria, stabilendo nel corso del tempo con loro delle relazioni molto morbose. Giovanni Pascoli sul piano letterario fu molto attivo, scrivendo opere molto importanti come per esempio liriche famose, tra cui si ricordano: X Agosto, Il Gelsomino notturno, Novembre, Tuono. Tra i temi principali e ricorrenti presenti nelle sue poesie, si ricordano per esempio il ricorso alla poetica del fanciullino, il tema del nido.
Indice
Vita e opere di Giovanni Pascoli
Giovanni Pascoli nasce a S. Mauro di Romagna nel 1855, nel 1862 entra nel prestigioso collegio dei Padri Scalopi a Urbino, da dove porterà avanti i primi studi, sino all’anno 1871.Nel 1867 morirà il padre Ruggero, assassinato nel suo carro, sulla strada del ritorno verso casa. Mai scoperti gli autori di tale reato, solo alcune supposizioni.
Il padre rivestiva l’ambita carica di amministratore dei beni dei principi di Torlonia.
Questo evento lascerà un segno indelebile nel pensiero pascoliano, andando ad influenzare inevitabilmente tutta la produzione del poeta.
Di lì a poco succederà la morte della madre, accompagnata da quella dei due fratelli e di una sorella: Pascoli uscirà dal lutto familiare accompagnato dalle sole due sorelle, Ida e Maria.
Il poeta tenterà così di ripristinare la parvenza di una famiglia e, a conclusione della sua carriera di insegnate, si ritirerà a vivere con le sorelle. A questo proposito il loro rapporto farà molto discutere.
Sulle orme di queste relazioni ambigue nasceranno anche gli interessi di critici e psicologi, i quali sonderanno le intime vicende di casa Pascoli, intrise di rapporti equivoci e morbosi. Da molte poesie di Pascoli emerge anche la visione turbata della sessualità del poeta.
Nel 1873 Pascoli ottiene una borsa di studi per l’Università di Bologna, dove si iscriverà alla facoltà di lettere. Qui conoscerà il socialista Andrea Costa, avvicinandosi al gruppo degli anarchici romagnoli e partecipando ai primi moti socialisti. Prenderà parte anche alla manifestazione in difesa di Gaetano Bresci, pagando lo scotto della prigione, dove sarà detenuto per tre mesi assieme ad altri anarchici. Qui finirà la sua attività politica, in favore degli studi accademici, che riprenderà di lì a poco presso l’Università romagnola. Nel 1882 si laurea.
Comincia a questo proposito la sua attività di professore, che lo vedrà insegnare latino e greco presso alcuni dei più prestigiosi licei italiani.
Nel 1906 succederà alla cattedra del Carducci, suo mentore.
Comprerà quindi una casa a Castelvecchio dove si trasferirà con le sorelle. Morirà nel 1912, poco tempo dopo la conquista italiana della Libia. Proprio in occasione di questa impresa scriverà il famoso saggio “La Grande Proletaria si è mossa” e quello sulla poetica del “Fanciullino”.
Tuttavia, la raccolta che più lo renderà famoso sarà “Myricae” (da tamerici, fragili arbusti di dimensioni umili, in cui si rifà alla prima egloga delle Bucoliche di Virgilio).
In Myricae, raccolta di poesie di Giovanni Pascoli, egli proporrà una collezione di temi quotidiani, in cui prevarrà sostanzialmente il paesaggio rurale di una campagna novembrina, autunnale. Su questo sfondo bucolico, espressione dell’angoscia e dell’inquietudine del poeta, comparirà ricorrente la presenza della nebbia.
Altra importante raccolta del Pascoli prende il nome de “I Canti di Castelvecchio”, ispirati alla permanenza del poeta presso l’omonima località, in cui il poeta si interrogherà su questioni quali il mistero e l’angoscia del vivere.
Ne “Poemi Conviviali” (poemetti in versi), che appariranno per la prima volta sulle pagine della rivista Il Convito, Pascoli proporrà temi di reminiscenza classicheggiante, in cui sarà riservato uno spazio particolare alla presentazione di valorosi eroi del passato.
Nei “Carmina” verranno proposte alcune liriche in lingua latina, anche a ricordare i successi riportati durante svariati concorsi letterari ad Amsterdam (9 volte di fila).
Poetica di Giovanni Pascoli: apparentemente ci si sorprende della semplicità dei testi pascoliani, ma prestando un po’ d’attenzione ed entrando nel merito della poesia, accentuata emerge l’influenza del simbolismo.
Nelle poesie di Pascoli si può osservare una straordinaria capacità ricettiva, in grado di celebrare la totalità delle emozioni che una situazione può suscitare. Anche la più banale delle sensazioni riveste importanza fondamentale ai fini di un forte impatto emotivo, che caratterizza le opere di questo poeta.
L’importante è cogliere tutto con immediatezza e spontaneità tipiche dello spirito infantile, il poeta si identifica nell’uomo capace di regredire all’infanzia ed essere bambino.
Tale è l’atteggiamento che il poeta assumerà nel suo approccio con la realtà, manifestando quella genuinità e quel senso di meraviglia tipici degli spiriti puerili.
per ulteriori approfondimenti sulla vita di Giovanni Pascoli vedi anche qua

Temi emergenti nelle opere di Giovanni Pascoli:
- Campagna: atmosfera immersa nella nebbia e nel silenzio, sotto una luce crepuscolare. Questo paesaggio dice tutta l’inquietudine dell’animo scosso del poeta, presentando spesso aspetti drammatici.
- Umanitarismo: ricorrente invito alla fratellanza e al rispetto reciproco, riconducibile alla traumatica morte del padre.
- Tragedia famigliare: in relazione alla propria esperienza di lutto, in particolare alla morte del padre, avvolta nel mistero.
- Visione bieca della sessualità: manifestata in maniera eclatante della lirica del “Gelsomino Notturno”.
- Nebbia: uno dei topoi della lirica pascoliana, assume un’accezione non del tutto negativa, si pone come qualcosa che avvolge, limitando la vista ad una realtà circoscritta, dimensione ricercata dal poeta.
Se nel Romanticismo il poeta guardava allo streben verso l’infinito, nel Decadentismo si
ricercheranno piuttosto dimensioni limitate. A questo proposito la nebbia rappresenterà per
il poeta decadente un riparo dalla vastità romantica, il nido sicuro entro cui rifugiarsi (X Agosto: padre assassinato mentre fa ritorno al nido famigliare, come una rondine che non fa in tempo a mettersi al riparo).
- Paura della morte: l’angoscia che questa scatena dall’animo umano ci mette a contatto con una dimensione sconosciuta, che fa paura. Questo è il contrario di ciò che accadeva nel Romanticismo, in cui essa assume invece connotazione positiva, di quiete.
- Dimensione onirica: dimensione ricercata in tutto il Romanticismo, correlata alla notte, spesso vista sotto un’ottica positiva. Al contrario, durante il decadentismo il sogno diventa quella dimensione attraverso cui l’uomo esprime gli istinti più reconditi, che possono dar luogo ad azioni riprovevoli, imprevedibili e incontrollabili. È l’inconscio che genera quegli istinti irrefrenabile che l’uomo sa di avere, senza però poterli controllare.
- Simbolismo: ereditato da Baudelaire (uccelli: rondine, assiuolo; fiori: gelsomino).
La novità che introduce il Pascoli è sicuramente l’innovativo linguaggio lirico, alla base di tutte le avanguardie poetiche del Novecento (critici del 900: filologo Contini e Squaratis).
Ci verranno così presentati metri molto vari, con numeri di strofe irregolari, sentiremo parlare per la prima volta di ipermetro (mentre nella metrica tradizionale l’endecasillabo è il più lungo), il tutto a vantaggio di uno stile irregolare, che riflette altrettanto contrastanti stati d’ animo. Il linguaggio è alogico. Scrive Squaratis: esistono in Pascoli più linguaggi che si amalgamano assieme: pre-grammaticale, grammaticale (più rigido e logico), post-grammaticale (con inserzione di termini stranieri).
Il fanciullino: in questo saggio, scritto nel 1897 ed edito nel 1903, Pascoli spiega come il poeta deve rapportarsi alla vita. Ovvero, deve far emergere dal suo intimo quella voce di bambino che, con l’avanzare dell’età si tende a sopprimere. Dacché solo il fanciullo vede chiaramente come è la realtà, è bene rivalutare quegli atteggiamenti tipici dell’età infantile.
Per ovviare a quel vuoto di valori, al male di vivere, il poeta si rifugia in una dimensione dove tutto viene recepito attraverso un certo senso di stupore, meraviglia.
Dentro di noi un fanciullino continua a vivere, un bambino che teme la morte (Cebes Tebano).
Giovanni Pascoli si può definire uno sperimentatore di emozioni, interessato al modo con cui il fanciullino si rapporta alla realtà, con ingenuità, autenticità e irrazionalità.
Il poeta è colui che vede ciò che il comune uomo non vede, diventa veggente, dotato di una certa sensibilità.
Questo dà una spiegazione dell’apparente facilità della lirica pascoliana, quasi banale a un primo sguardo.
Lavandare di Giovanni Pascoli: Autunno, un velo di nebbia avvolge il paesaggio desolato di una campagna novembrina.
Si sussegue una serie di immagini tratte dalla vita rurale, senza una logica consequenziale.
Campo arato a metà: appare mezzo grigio e mezzo nero, in un particolare gioco cromatico, in mezzo giace un aratro senza buoi, abbandonato. Si accavalla ora il suono dello sciabordare, ritmato dalla gora: canali dove le lavandaie solevano immergere i panni, intonando cantilene che, in questo caso, richiamano alla sfera uditiva.
Il vento soffia e la frasca nevica: dalle fronde cariche di neve piovono fiocchi di ghiaccio.
E tu non torni al tuo paese: senso di abbandono trasferito anche all’uomo: la donna sembra evocare la memoria dell’amato.
Espedienti retorici e stilistici: uso di onomatopee (sciabordare), sinestesia (associazione di più sensazioni nello stesso momento), rime interne (all’interno di uno stesso verso: “sciabordare delle lavandare”), linguaggio attento ai richiami fonici e allo stesso tempo analogico (solitudine dell’ aratro = solitudine della donna).
Novembre (Myricae): Viene analizzato il testo di Novembre di Pascoli. Siamo a S. Martino (11/11), giorno particolare conosciuto anche come “l’estate fredda dei morti”, in cui si commemora il ricordo dei defunti.
Ci vengono presentate alcune immagini di vita quotidiana, con forti richiami analogici ed allusivi:
Gèmmea l’aria: l’aria è limpida come una gemma, una pietra preziosa.
Il sole così chiaro: talmente splendente che ti sembra primavera, e quasi penseresti di cercare gli albicocchi in fiore.
Odorino amaro del prunalbo: del biancospino (Pascoli era esperto di botanica).
I rami spogli s’intrecciano a formare ragnatele sullo sfondo terso del cielo.
Vuoto è il cielo: siamo alle soglie dell’inverno, nessun uccello vola nel cielo;
Cavo al piè sonante sembra il terreno: talmente duro che risuona ai passi di chi vi cammina.
C’è silenzio intorno: solo quando soffia qualche alito di vento si ode un fragile cadere di foglie, che ci riporta alla caducità della vita umana. Domina il senso di morte, trasmesso dal paesaggio invernale che inizialmente dà l’illusione di un’atmosfera primaverile. Espedienti retorici e stilistici: ossimori (estate fredda), sinestesie (sole/cielo–odore = vista–olfatto; cadere fragile).
X Agosto di Giovanni Pascoli: 10 agosto: notte di S. Lorenzo, giorno in cui ricorre la morte del padre Ruggero, a cui il poeta dedica questa lirica.
“San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade…”.
Per tradizione, nella notte delle stelle cadenti gli uomini sono soliti esprimere un desiderio. L’espressione tanto di stelle ricalca la forma arcaica latina del genitivo partitivo.
“Perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla”.
Per analogia pare che il cielo, con il suo pianto di stelle, abbia compassione del dramma che affligge il poeta.
“Ritornava una rondine al tetto…”.
La lirica è intrisa di parallelismi: come la rondine ritorna al suo nido, così il padre ritorna a casa.
Il padre è stato ucciso perché si trovava fuori dal suo nido, quindi sottoposto ai pericoli della vita, così come lo è stata la rondine.
“Ora è là come in croce…”
Croce simbolo della passione di Cristo, della sofferenza.
“Tende quel verme a quel cielo lontano…”
Quasi a chieder pietà per la sua condizione.
“E il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano”.
I rondinini sono destinati a perire di fame.
“L'uccisero: disse: Perdono; e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono…”.
Tuttavia l’ uomo sembra aver perdonato i suoi uccisori; tra le mani reggeva due bamboline.
“Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano”.
Se ne sta ora immobile e stupito addita al cielo le sue bamboline.
“E tu, Cielo…”.
Sembra che il poeta invochi il pianto del cielo, affinchè abbia compassione di tutta questa malvagità.
La struttura è circolare: si apre con un’immagine del cielo e con essa si conclude; il ritmo, lento, è dato da una punteggiatura molto rigorosa e frequenziale, che ben rispecchia l’angoscia del poeta.
L’assiuolo (Myricae): Si tratta di una lirica paesaggistica, che si apre con la descrizione di una notte chiara, in cui la luna non s’intravede ancora, ma viene ricercata dal poeta.
L’esito di questo ricercare rivelerà una sensazione di mistero che coglierà il poeta di fronte alla natura.
La poesia si struttura su una serie di immagini, le quali si accavallano, slegate tra loro, come a voler riflettere lo stato emozionale dell’autore.
L’assiolo, è un uccello notturno preso in considerazione per il suo verso lamentoso e malinconico, che qui viene reso grazie all’ onomatopea “Chiù”.
Tale ripetersi di suoni allude all’inquietudine e al mistero che turbano l’animo del poeta.
In questa serata è appena trascorso un temporale, in lontananza si scorge ancora la cupa ombra delle nubi in un cielo che si sta rasserenando.
“Dov’era la luna?”: il poeta cerca la luna in un cielo dal chiarore perlaceo.
Il mandorlo e il melo sembrano ergersi verso l’alto, intenti a loro volta nel cercare la luna.
“Venivano soffi di lampi”: intanto giungono guizzi di lampi, in un gioco analogico che allude alla loro immediatezza.
Il bianco quasi lattiginoso del cielo si sta tingendo e rade s’intravedono le stelle.
In questo silenzio s’ode l’infrangersi delle onde del mare, in un cullare che ricorda una rima d’infanzia. È quasi una regressione alla tenera età, in un contatto panico che ricorda al poeta le cantilene materne, qualcosa che ormai non c’è più.
“Sentivo un fru fru tra le fratte, sentivo nel cuore un sussulto, com’eco d’un grido che fu.
Sonava lontano il singulto”.
Sussulto, eco, singulto (nel pianto): climax.
“Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento”.
S’alza un venticello che squassa le fronde, in un fruscio che viene associato al frinire delle cavallette nei campi.
Questi suoni stridenti sembran note di sistri (strumenti musicali che gli Egizi solevano suonare durante i riti funebri), suoni che sembran tintinnii di campanelli, che vorrebbero aprire porte che probabilmente mai più si apriranno.
Segue così una conclusione malinconica, accompagnata da un persistente canto di morte, associato al “Chiù” dell’ assiolo che canta.
I puntini di sospensione danno l’idea di una risposta che non c’è, di un mistero per il quale non esiste risposta. Rimane un senso d’amarezza.
La mia sera (Canti di Castelvecchio): Anche in questa lirica ricorre il tema del nido, sinonimo di protezione e sicurezza.
In questa lirica, simbolo della rivoluzione pascoliana, torna prepotente la presenza della natura, che riflette gli stati d’animo d’inquietudine del poeta.
È introdotta così un’immagine paesaggistica notturna, un’atmosfera serale che fa seguito ai lampi e ai tuoni di una giornata tempestosa.
A questo punto, trascorsa la burrasca, che il cielo si rischiari sotto la luce delle stelle; nei campi s’ode un “gre gre” di ranelle, una gioia leggera sfiora le tremule foglie, rincuorando l’animo del poeta.
“Si devono aprire le stelle nel cielo sì tenero e vivo”, per forza le stelle devono tornare a splendere, quasi fossero tenere corolle di fiori nel campo (reminiscenza baudelairiana).
“Là, presso le allegre ranelle, singhiozza monotono un rivo”.
S’ode anche il rumore d’un ruscello che singhiozza malinconico.
“Di tutto quel cupo tumulto, di tutta quell'aspra bufera, non resta che un dolce singulto
nell'umida sera”.
Non resta che un dolce singluto (ossimoro), un mormorio simile ad una pianto d’uomo.
La natura, pur nella sua apparente serenità, lascia intravedere una certa malinconia, espressa attraverso questa accorta scelta lessicale.
E la tempesta, che sembrava non aver fine, trova pace in questo dolce mormorio di ruscello.
“Dei fulmini fragili restano cirri di porpora e d'oro”.
Fulmini fragili (sinestesia), repentini, di breve durata, quasi emblemi della vita umana, effimera.
La nube, che durante il giorno si era fatta minacciosa, appare adesso dorata e all’orecchio giunge il verso gioioso delle rondini che si librano in aria.
“La fame del povero giorno prolunga la garrula cena”.
La fame sofferta dalle bestiole durante il giorno, costrette a rintanarsi, s’appaga ora in una festosa cena. Nemmeno una piccola parte di cibo fu concessa ai rondinini durante la tempesta.
“Nè io… che voli, che gridi, mia limpida sera!”.
Così come i piccoli, nemmeno io - dice il poeta - quel giorno ricevetti la mia parte di cibo.
“Don… Don… E mi dicono, Dormi! mi cantano, Dormi! sussurrano, Dormi! bisbigliano, Dormi! là, voci di tenebra azzurra… Mi sembrano canti di culla, che fanno ch'io torni com'era…”.
Un suono fa regredire il poeta all’infanzia, forse rievoca in lui la ninnananna materna, una voce di tenebra azzurra (sinestesia e ossimoro).
Il benessere (azzurro) si è tramutato in tenebra con la perdita della madre, a questo punto appare evidente quanto la regressione del poeta contrasti con la realtà, allo stesso modo la visione della madre si tramuta in illusione per poi dissolversi sul far della sera.
Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio): Questi versi vennero composti da Giovanni Pascoli nel 1901, in occasione delle nozze dell’amico Gabriele Briganti. La natura, ancora una volta, fa da sfondo a quest’opera e si carica di simbologie e allusività; i temi centrali sono quelli dell’amore e della fecondazione.
La lirica si apre con l’atmosfera di un paesaggio serale, che vedrà poi il susseguirsi di diverse immagini, spesso slegate tra loro.
“E s’aprono i fiori notturni, nell’ora che penso a’ miei cari”.
Mentre si schiudono i gelsomini notturni esalando un profumo di fragole rosse (colore dell’amore e della passione), il poeta rivolge il pensiero ai propri cari ed alcune falene compaiono tra i viburni dai fiori bianchi (ricorrente attenzione alla classificazione delle piante e agli aspetti botanici: Pascoli ne era esperto).
“Da un pezzo si tacquero i gridi”.
S’acquietano i canti degli uccelli, il silenzio regna sulla scena.
Solo in una casa, ancora, si odono bisbigli: quella dei novelli sposi.
“Sotto l’ali dormono i nidi, come gli occhi sotto le ciglia”.
Gli uccelli più piccoli riposano protetti sotto l’ala materna.
Un termine chiave appena accennato rimanda ad un tema caro al poeta, ricorrente nelle sue opere: il nido.
“Dai calici aperti si esala l’odore di fragole rosse. Splende un lume là nella sala. Nasce l’erba sopra le fosse”.
Mentre la notte ed il silenzio avvolgono la scena, suggerendo l’idea di qualcosa che sta giungendo a conclusione, altre forme di vita si risvegliano. I gelsomini notturni si aprono la sera per richiudersi, poi, all’alba del giorno seguente.
Dietro la corolla del fiore si cela una metafora della sensualità femminile, introdotta così fin dal primo verso.
S’intravede un lume (simbolo di qualcosa di bello che nascerà) nella casa degli sposi, poco distante, nel luogo in cui i defunti riposano, nasce una nuova, fragile vita: alcuni fili d’erba. Accanto alla prima immagine, pervasa di sensualità e seduzione emerge il dramma interiore del poeta: l’associazione di amore e morte è stata interpretata dai critici come una dimostrazione del senso di inferiorità, in quanto uomo, che sembra provare Pascoli nei confronti dell’esperienza amorosa.
“Un’ape tardiva sussurra trovando già prese le celle”.
Un’ape che si è attardata al volo giunge troppo tardi alle cellette dell’alveare, ormai tutte occupate. Esattamente allo stesso modo il poeta, di cui l’ape è chiara metafora, rimane escluso dal mondo dell’amore. Questo è forse il simbolico riferimento che Pascoli indirizza a a se stesso che, escluso dal mondo, guarda il mistero della nuova vita dall'esterno.
Il poeta finisce con il guardare alle vicende umane più naturali ed elementari, come il concepimento di un figlio, da un punto di vista distorto, di escluso, considerandole dunque con una notevole dose di perplessità e di insicurezza e con un atteggiamento assai sfuggente di ambivalenza affettiva nei confronti della materia trattata. Sembra osservare i fatti con una curiosità un po' infantile e quasi morbosa.
“La Chioccetta per l’aia azzurra va col suo pigolio di stelle”.
La costellazione delle Pleiadi, comunemente denominata Chioccetta dai contadini, risplende nel cielo simile ad una piccola chioccia seguita dai suoi pulcini, che procedono disordinati come stelle nel firmamento.
Per tutta la notte il vento porta con sé il profumo che si solleva dai gelsomini notturni. Una luce, nella casa, sale al primo piano, poi si spegne. In quella luce che non c’è più intuiamo l’intimità dell’atto d’amore tra i due sposi.
“È l’alba: si chiudono i petali un poco gualciti”.
Al sopraggiungere dell’alba i petali si richiudono un poco gualciti, consumati e in quell’urna molle e segreta che è il grembo materno è germogliata una nuova vita, qui si cova un nonsoché di felicità materna.
Biografia e opere di Giovanni Pascoli
Giovanni Pascoli nacque a San Mauro di Romagna nel 1855. Dai sette ai dodici anni studiò nel collegio “Raffaello”, che dovette lasciare in seguito alla morte del padre, ucciso da sconosciuti mentre tornava dalla fiera di Cesena. Anche se fu colpito da altri lutti familiari come la morte della madre e della sorella, continuò a studiare, vincendo una borsa di studio, con la quale s’iscrisse alla facoltà di Lettere dell’Università di Bologna. Durante gli anni di Università partecipò alle dimostrazioni in favore di Passanante. Fu arrestato e trascorse tre mesi in carcere, dopodichè fu assolto e liberato. Riprese gli studi, si laureò e subito iniziò la carriera d’insegnante di latino e greco. Insegnò per varie Università, finchè nel 1905 ottenne a Bologna la cattedra di Letteratura italiana. Morì proprio a Bologna nel 1912.Il pensiero. Il Pascoli ebbe una concezione dolorosa della vita, le cause di tutto questo furono due fatti principali: la tragedia familiare e la crisi del positivismo. La tragedia familiare è costituita da vari lutti che colpirono il poeta, infatti prima gli fu ucciso il padre, poi in rapida successione morirono la madre, la sorella maggiore, e i due fratelli Luigi e Giacomo. Questi lutti gli ispirarono il mito del “nido” familiare da ricostruire, del quale fanno parte i vivi e idealmente anche i morti, legati ai vivi dai fili di una misteriosa presenza. Secondo il poeta infatti, in una società sconvolta dalla violenza, la casa è il rifugio nel quale i dolori e le ansie si placano. Il pensiero del Pascoli fu poi anche influenzato dalla crisi del positivismo, che si verificò verso la fine dell’Ottocento e fece crollare i suoi miti, quelli della scienza liberatrice e del progresso. Infatti il poeta riconosce l’impotenza della scienza nel risolvere i problemi umani e sociali, e inoltre la accusa anche di aver reso più infelice l’uomo, distruggendo in lui la fede in Dio, che era stata per secoli il suo conforto. Perduta la fede nella scienza il poeta fa adesso riferimento al mondo dell’ignoto e dell’infinito, arrivando alla conclusione che gli uomini sono creature fragili, soggette al dolore e alla morte.
La poetica del fanciullino: La poetica del Pascoli è legata al suo modo di vedere il mistero come una realtà che ci avvolge. Questo mistero però, sia la filosofia che la scienza non hanno saputo svelare, e secondo il Pascoli, solo il poeta tramite improvvise intuizioni può scoprire il segreto della vita universale. Il Pascoli tramite queste intuizioni, elabora una sua poetica tutta particolare che prende il nome di “poetica del fanciullino”. Questo fanciullino secondo il poeta è in tutti gli uomini, ma nella maggior parte di essi però, distratti dalle loro attività, il fanciullino tace; in altri invece, cioè nei poeti, il fanciullino fa sentire la sua voce di stupore davanti alla bellezza della natura.
Il Pascoli distingue quindi la poesia pura dalla poesia applicata. La poesia pura è quella fatta di stupori, e l’oggetto di essa non è soltanto la natura, ma anche le armi, le guerre, i viaggi, tutte cose che stimolano la fantasia del fanciullino. La poesia applicata invece, è fatta di drammi e di grandi romanzi, come ad esempio l’Orlando Furioso .
Decadentismo del Pascoli. Il Pascoli contrariamente al D’Annunzio, pervenne al Decadentismo per istinto, e non per influenze esterne. Egli in seguito alla crisi del positivismo, elaborò una poetica che rientrava senza che lui stesso se ne accorgesse, nelle grandi correnti del suo tempo. Gli elementi del decadentismo pascoliano sono: 1) il senso smarrito del mistero e la sensibilità a percepire le voci provenienti dalle zone profonde dello spirito; 2) la poesia come strumento di conoscenza; 3) il simbolismo, cioè vedere le cose non nel loro aspetto reale, ma come simboli; 4) la fiacchezza di temperamento.
Analisi delle opere: La prima raccolta di poesie del Pascoli è dedicata al padre, e si intitola Myricae. Il tema della raccolta è quello della campagna, colta nei suoi vari momenti, specialmente in quelli più malinconici dell’autunno, quando è ancora vivo il ricordo dell’estate appena trascorsa e si avverte il triste arrivo dell’inverno, che richiama l’idea della morte. La raccolta successiva furono i Poemetti, mentre ad essi seguirono I canti di Castelvecchio, dedicati alla madre e considerati il continuo delle Myricae.
Motivi, struttura e forme della poesia pascoliana.
I motivi della poesia pascoliana sono quattro: il motivo delle memorie autobiografiche; il motivo della celebrazione degli ideali morali, patriottici e umanitari; il motivo georgico; il motivo del mistero della vita e della cosmicità della terra. Il primo motivo rievoca con grande commozione i momenti della vita del poeta e i lutti familiari (L’aquilone, La cavallina storna).Il secondo motivo si ricollega alla tradizione ottocentesca, quando la poesia era intesa come strumento di educazione morale, patriottica e civile. Queste poesie sono state considerate scadenti perché troppo intellettuali (I due fanciulli). Il terzo motivo si sviluppa nella contemplazione della natura e della campagna. E’ uno dei motivi più suggestivi per la grande sensibilità del poeta (Lavandare, Il gelsomino notturno). Il quarto motivo, è quello più vicino ai temi del Decadentismo. La terra appare al Pascoli come un atomo opaco, sperduto nell’immensità dell’universo. Questa visione dà al poeta un senso di solitudine, che lo rende sensibilissimo a percepire le voci misteriose che arrivano dallo spazio (La vertigine).
Per quanto riguarda la struttura e le forme della poesia pascoliana, c’è una rottura con la tradizione letteraria italiana, e il poeta dà inizio alla poesia moderna. Per comprendere questa nuova struttura, basta ricollegarsi alla poetica del fanciullino, dove questo fanciullo agli occhi del poeta assume un significato particolare, per cui anche una piccola cosa può diventare un grande simbolo. Da questo si intuisce che la poesia più profonda del Pascoli è quella dei componimenti brevi, delle sensazioni fulminee e delle fresche impressioni.
Lavandare: Nel campo, mezzo grigio nella parte non arata e mezzo nero nella parte arata, c’è un aratro senza buoi, avvolto nella nebbia leggera. Dal canale d’acqua, proviene il rumore dei panni sulle pietre prodotto dalle lavandaie, accompagnate dalle loro cantilene. Intanto inizia a soffiare il vento, che dai rami fa cadere la neve. Il paesaggio così desolato ispira sentimenti tristi e malinconici, e il poeta interpreta la canzone delle lavandaie come il lamento della solitudine. La canzone dice che è quasi inverno e l’uomo amato, non ritorna ancora al paese, e la donna, si sente sola e abbandonata, come l’aratro in mezzo al maggese.
Questa poesia fa parte della raccolta Myricae. Della poetica del fanciullino, la poesia ispira la contemplazione della natura e la percezione delle voci e dei rumori che l’attraversano. Della poetica del Decadentismo, rispecchia il simbolismo, la tendenza a vedere le cose come simbolo di realtà più profonde(l’aratro in questo caso è il simbolo della solitudine e dell’abbandono).
La mia sera. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora che la tempesta e finita ed è arrivata la sera, appariranno le stelle silenziose. Intanto nei campi si diffonde il gracidare delle rane, mentre le foglie dei pioppi tremano al vento come se fossero contente per la fine della tempesta. Poi iniziano ad aprirsi le stelle nel cielo pieno di colori teneri e vivaci, e accanto al gracidare delle rane, singhiozza il ruscello. Ora nel cielo invece dei fulmini si vedono nuvolette rosse e bionde, per i riflessi del sole che tramonta. Anche la nuvola più nera, più densa di bufera, nell’ultima ora della sera è più rosa delle altre. Durante il giorno tempestoso gli uccelli non hanno potuto cercare il cibo, e quando arriva la sera, finita la tempesta, volano allegramente e la fame patita nel povero giorno prolunga l’allegra cena, perché nel nido i piccoli non ebbero l’intera parte. E il poeta aggiunge che neanche lui l’ebbe nel passato. Il suono delle campane infine sembrano invitare al riposo il poeta e cullarlo dolcemente, facendogli ricordare l’infanzia quando la sera si addormentava sentiva per ultima la voce della madre e poi, una volta addormentatosi, più nulla.
Il nulla sembra essere il simbolo della morte, nella quale il poeta troverà un riposo sereno ed eterno.
Giovanni Pascoli, riassunto
Giovanni Pascoli nasce nel 1855 in una famiglia numerosa. In un ambiente rurale. L'infanzia fu interrotta da una serie di lutti, a 12 anni perse il padre (assassinato), l'anno successivo la madre e la sorella maggiore e l'anno dopo due fratelli. Nel 1873 inizia a frequentare l'università di Bologna avvicinandosi a idee socialiste. Dopo essere stato incarcerato per alcuni mesi (manifestazioni socialiste) prende le distanze dal movimento socialista. Si laurea in lettere. Carducci lo aveva designato come suo successore. Nel 1891 scrive Myricae. Nel 1897 pubblica la prosa al fanciullino. E sempre nello stesso anno scrive i poemetti. Nel 1903 pubblica i canti di castel vecchio. Dopo essere tornato in toscana, ed essersi riunito con le due sorelle, vive come un tradimento il matrimonio della sorella. Nel 1906 prende la cattedra di letteratura italiana a Bologna (era stata di Carducci) questo segna una svolta perche le tematiche che affronta non sono più private ma civili e patriottiche. Muore nel 1912.La poetica:Le caratteristiche portanti della produzione pascoliana sono: la fuga della realtà e la concezione di una poesia come strumento di conoscenza privilegiato. La poetica del fanciullini si articola i 4 punti:
In tutti gli individui è presente un fanciullino musico ovvero il sentimento che fa sentire la sua voce nell'età infantile per poi attenuarsi nell'età adulta. Il poeta è colui che riesce a mantenere viva dentro di se la voce del fanciullino. La fuga dalla realtà, cardine della poetica simbolista, si manifesta in Pascoli in una regressione al mondo infantile. I temi e i simboli ricorrenti nella produzione di Pascoli sono: il nido o la casa, la culla, la siepe e la nebbia;
Altro aspetto fondamentale è il modo di vedere le cose del fanciullino. Tipico del fanciullino è vedere tutto con meraviglia, tutto come per la prima volta. Scoprire cioè la poesia nelle cose stesse, nelle più grandi come nelle più piccole (poesia delle piccole cose). Attenzione è data agli elementi del mondo agreste, specie i più minuti;
Attraverso il ricorso alle analogie si creano relazioni nuove e inaspettate, che hanno un valore conoscitivo, in quanto servono a esprimere quelle realtà di carattere generale sul senso dell'esistenza umana, che non la scienza ma solo lo sguardo disinteressato del fanciullino può raggiungere;
Riguarda la funzione della poesia. La poesia ha una suprema utilità morale e sociale in quanto unisce gli uomini e li fa sentire fratelli. Avvicinandoli a un sentimento di amore reciproco. In linea col pensiero decadente la poesia non deve essere finalizzata all'edificazione morale. Al poesia è inoltre un valore consolatorio;
La poesia di Pascoli è di carattere morboso e legata ai temi dell'eros e della morte.
Nel famoso scritto "Il Fanciullino", Pascoli definisce ampiamente la sua poetica. La poesia non è razionalità, ma una perenne capacità di stupore tutta infantile, in una disposizione irrazionale che permangono dentro l'uomo anche quando si è cronologicamente lontani dall'infanzia. Il poeta viene paragonato al fanciullino che si mette di fronte alla realtà rendendo inattiva la ragione: sa attribuire significati estremamente soggettivi alle cose che lo circondano. Il poeta è privo di malvagità, è caratterizzato dalla condizione di stupore e dalla capacità di riflettere i propri stati d'animo nelle piccole cose. Il poeta-fanciullino è una figura astratta perché non tutti i fanciulli sono buoni e, imperfetta in quanto il poeta non riuscirà mai pienamente nel suo tentativo di tornare bambino.
Il carattere dominante della poesia del Pascoli è costituito dall'evasione della realtà per rifugiarsi nel mondo dell'infanzia, un mondo rassicurante, dove l'individuo si sente isolato ma tranquillo rispetto ad una realtà che non capisce e quindi teme. Il fatto che la poesia si sviluppi sulla base di una contrapposizione tra mondo esterno e mondo privato, e che il primo sia connotato negativamente, mentre il secondo positivamente, è un'altra costante in Pascoli. Ciò si ricollega al bisogno di affetto e protezione, per cui, proprio come un bambino, il poeta sente la necessità di rinchiudersi in un nido e sfuggire ai pericoli della vita. Quindi Pascoli ci vuole dire che la dolcezza dell'infanzia e della giovinezza dura poco e presto si rivela essere un'illusione. Sulla vita dell'uomo incombono tristezza, silenzio e morte e, per quanto riguarda il caso pascoliano, la nostalgia per qualcosa che è stato perso per sempre, il dolore per gli affetti strappati, lo sconforto per la malvagità umana e per l'ingiustizia che regna sulla terra.
Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli: Sul piano lessicale mescola termini precisi a volte tecnici, specifici dei linguaggi settoriali (natura, lavoro nei campi), a parole umili. Frequente è l'uso del fonosimbolismo, in particolare allitterazioni e onomatopee. Le figure retoriche predilette sono l'analogia e la sinestesia (vista olfatto, vista udito). Sul piano sintattico spicca la predilezione della paratassi.
Myricae: La prima edizione del 1891 comprendeva 22 poesie; nell'edizione definitiva, del 1903, ve ne erano 156. I temi che predominano nella raccolta sono quelli della morta e della natura sempre affrontati cono attraverso una minuziosa attenzione al dettaglio. Gran parte attinge dalle proprie vicende familiari e dal mondo della campagna. Ma la novità della poesia di Pascoli consiste nel riuscire a caricare i particolari minimi di sensi e significati simbolici. Sviluppò, così, un'idea di poesia in sintonia col simbolismo europeo. L'opera è caratterizzata da un'estrema varietà metrico-stilistica e linguistica: Pascoli abbandona i modelli tradizionali e si avvale di un linguaggio estremamente diversificato, che spazia da vocaboli di uso dialettali a colti e specialistici e concede ampi spazi all'onomatopea. Anche la sintassi tradizionale viene abbandonata: la percezione alogica, intuitiva e musicale del mondo si concretizza attraverso l'abolizione dei nessi logici.
Temporale: Appartiene alla raccolta Myricae. E' una ballata minima di settenari con rime secondo lo schema A BCBCCA. Il componimento è costituito da una serie di percezioni uditive e visive realizzate attraverso analogie, che fanno sembrare la ballata un quadro impressionistico carico di valori simbolici, in questo caso evocano angoscia e inquietudine. Il ritmo, che è più lento nei primi due e negli ultimi due versi e più sostenuto nei tre versi centrali, conferisce al componimento particolare musicalità. L'annullamento dei legami logico-sintattici accentua il carattere alogico. Numerose le analogie. Nell'ultimo verso la realtà umana è descritta attraverso una metafora tratta dal mondo animale. Pascoli era un appassionato di ornitologia. Il colore bianco del piumaggio dell'uccello, contrapposto al rosso e al nero del temporale, che evocano immagini di sconvolgimento e di dolore, rappresenta la l'innocenza, la purezza e la pace del nido domestico.
Il lampo: Il legame con Temporale è contenutistico e stilistico: analogo tra i due componimenti è lo schema compositivo, anche se nel secondo il settenario diventa endecasillabo; quasi identica è anche l'immagine centrale, il fugace apparire di una casa. E, ancora, identico è il simbolismo impressionistico che la rappresenta.
Il lampo è una ballata piccola di endecasillabi con rime secondo lo schema A BCBCCA.
Il primo verso spiega che grazie alla luce del lampo è possibile vedere la natura nella sua realtà più profonda. Gli aggettivi utilizzati per descrivere la terra (ansate, livida e in sussulto) e il cielo (ingombro, tragico e disfatto) non denotano un dato visivo ma forniscono un'interpretazione in chiave simbolica dell'evento atmosferico. In questo frangente di luce, quello che precede il tuono (tacito tumulto (ossimoro) ,si intravvede una casa bianca (nido) contro il nero del temporale. Come in Temporale, è presente la rima tra il primo e l'ultimo verso (circolarità della poesia). L'eliminazione dei nessi logico-sintattici è realizzata attraverso una sintassi nominale, che procede in modo paratattico senza congiunzioni. Numerose le assonanze e le allitterazioni. I richiami fonici diventano richiami visivi a suggerire la rapidità dell'apparizione.
Grazie alla presenza dell'occhio il fenomeno naturale diviene metafora di una tragedia umana, più in particolare il ricordo dell'assassinio del padre. Il lampo è il simbolo della realtà minacciosa del mondo, alla quale si contrappone un'unica possibilità di salvezza, il rifugio della casa-nido.
Novembre: La forma metrica del componimento: sono tre strofe saffiche (poetessa Saffa) di tre endecasillabi più un quinario a rima alternata ABAb.
Allitterazione per assonanza in “e” e “o” e per consonanza in “s” e in “r”. e in f r g nell'ultima strofa che tende a riprodurre il suono delle foglie (funzione onomatopeica). Sinestesia: “cader fragile” e “odorino amaro”, ossimoro: “estate fredda”. Una serena e tersa giornata di novembre può per un attimo suggerire un'illusione di primavera, ma si tratta di un'illusione che presto scompare, e alle iniziali impressioni subentra la constatazione di un inverno.
In questa poesia il paesaggio mostra un duplice aspetto. Sotto un'apparenza di armonia e di positività possono nascondersi la presenza e la minaccia della morte.
Nella prima strofa vi è inizialmente un'immagine primaverile (gemmea l'aria - il sole è così chiaro), l'immagine di una giornata soleggiata nel mese di novembre, durante la cosiddetta "estate di S. Martino". Ma ciò che il poeta vuole realmente rappresentare è la breve illusione della felicità. Nella bella giornata autunnale, la luce del sole e l'aria limpida danno per un istante l'illusione che sia primavera. Ma subito ci si rende conto che le piante sono secche e spoglie. Nella seconda strofa Pascoli ha voluto iniziare con un “Ma”, che segna un netto rovesciamento della situazione precedente, è il ritorno alla realtà dopo l'illusione di dolcezza primaverile, quindi della delusione.
Nella terza strofa viene confermata la realtà di morte.
X Agosto: Il titolo di questa poesia rimanda al giorno in cui fu assassinato il padre del poeta. Ma prima di evocare questo dolore privato, il poeta racconta di un'altra morte assurda, quella di una rondine uccisa mentre tornava al nido dei suoi piccoli. Ecco il dolore individuale, condiviso, diviene dolore collettivo, un dolore immenso, di fronte al quale il Cielo piange sconsolato: la notte del 10 agosto è infatti la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti (lacrime di San Lorenzo).
Forma metrica: sei quartine di decasillabi e novenari alternati a rime alternate: ABAB.
Nella seconda e nella terza strofa troviamo il seguente nucleo narrativo: mentre tornava al nido dove la aspettavano i suoi piccoli, una rondine è stata uccisa senza motivo, è caduta tra i rovi, con l'insetto che avrebbe costituito la cena dei rondinini. Ora è la, ingiustamente uccisa come Cristo sulla croce, con le ali spalancate e con quel verme inutilmente proteso verso il cielo, mentre i suoi piccoli attendono invano il suo ritorno e piangono sempre più piano.
La quarta e la quinta strofa propongono il secondo nucleo semantico: come la rondine, anche un uomo è stato ucciso mentre tornava al suo nido portando due bambole in dono alle figlie; ha avuto solo il tempo di dire perdono, non ha potuto nemmeno gridare, e quel grido inespresso è leggibile negli occhi sbarrati dal terrore. Nella casa solitaria i figli lo aspettano; egli giace immobile mostrando le bambole al cielo lontano.
L'ultima strofa chiude il componimento riprendendo la prima, l'immagine del cielo.
La struttura del testo, rievoca l'immagine della croce.
Poetica e poesie di Pascoli
Dopo aver insegnato latino e greco in diversi licei e università italiane, nel 1906 succede al Carducci come professore di letteratura italiana all'università di Bologna. Nel frattempo trova rifugio dagli affanni della vita nella casa di Castelvecchio di Barga in provincia di Lucca dove vive anche la sorella Maria.
Pascoli muore a Bologna nel 1912.
Poetica del fanciullino:Per Pascoli l'uomo e il mondo sono avvolti nel mistero, sono minacciati dal male, dall'ingiustizia e dalla morte; nè la religione, nè la scienza sono in grado di conoscere e spiegare la realtà.
Solo i poeti possono intuire il significato della vita e sondare il mistero dell'animo umano. Nel poeta, infatti, c'è una parte dell'anima che rimane fanciulla: è il fanciullino che sa percepire il segreto delle cose. Ciò perchè il poeta fanciullino conserva l'ingenuità e l'intuizione di un bambino capace di commuoversi di fronte al messaggio che inviatogli dalle cose, anche le più semplici e quotidiane.
Opere:
Raccolte poetiche
-Myricee (1891)
- Poemetti (1897)
- Canti di Castelvecchio (1903)
- Poemi Conviviali (1904)
Opere in prosa:
-Il fanciullino
-La grande proletaria.
Giovanni Pascoli nacque a San Mauro di Romagna (Forlì) nel 1855 dove trascorse un’infanzia felice finché non accadde la tragedia di cui portò sempre nell’animo il dolore: l’uccisione del padre da parte di ignoti. Altri eventi lo sconvolsero, come la morte della madre e di tre degli otto fratelli. Compì gli studi all’Università di Bologna, diventando allievo di Carducci per poi laurearsi in Lettere. Viene condannato ad alcuni mesi di carcere a cui segue un periodo di crisi, durante il quale si accentua il suo pessimismo e abbandona la politica attiva. Dopo aver insegnato latino e greco in diversi licei e università italiane, nel 1906 succede al Carducci come professore di letteratura italiana all’Università di Bologna. Muore a Bologna nel 1912.
Le opere: Per Pascoli l’uomo e il mondo sono avvolti dal mistero, sono minacciati dal male, dall’ingiustizia e dalla morte. Pascoli dopo le tante sventure familiari si è allontanato dalla fede cristiana e non crede nella provvidenza divina; secondo lui, infatti, né la scienza, né la religione sono in grado di spiegare la realtà. Solo i poeti possono intuire il significato della vita e scorgere nel mistero del destino umano la verità che sfugge alla maggioranza degli uomini. Nel poeta, infatti, c’è una parte dell’anima che rimane fanciulla ed è quell’anima di “fanciullino” che sa capire il segreto delle cose (poetica del fanciullino).
La poesia di Pascoli è la poesia delle piccole cose che nel loro più profondo significato possono rivelare frammenti di verità. Questa poesia si allontana da quella romantica per aderire a quella del Decadentismo. Pascoli rifiuta gli schemi metrici della poesia tradizionale e crea strofe e versi di misura inedita; utilizza un linguaggio nuovo (dialetto e termini letterari); usa frequentemente onomatopee per valorizzare gli effetti musicali del verso.
Le sue raccolte poetiche più importanti sono:
- “Myricae”: il titolo è costituito da un termine latino che significa “tamerici”, piccoli cespugli di campo;
- “Canti di Castelvecchio” : le poesie delle “piccole cose”;
- “Odi e Inni”.
Giovanni Pascoli, sintesi
Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 1855, da una famiglia della piccola borghesia rurale, di condizione agiata. L’armonia familiare viene interrotta dall’uccisione del padre, probabilmente da parte di un rivale che voleva prendere il suo porto di amministratore, tutto ciò porta a difficoltà economiche per la famiglia, così si trasferiscono a Rimini dove il fratello Giacomo aveva trovato un posto di lavoro per mandare avanti la famiglia. Segue un ciclo di lutti per G. Pascoli, muoiono la madre, la sorella, e i fratelli Luigi e Giacomo. Per quanto riguarda gli studi, egli entrò nel collegio degli Scolopi ad Urbino ed ebbe una formazione classica, frequentò poi la facoltà di Lettere a Bologna. Quando subì il fascino dell’ideologia socialista partecipò a manifestazioni contro il governo, per cui fu arrestato e poi rilasciato. Ottenuta la laurea divenne insegnante liceale a Matera e poi a Massa dove richiamò le altre due sorelle per ricostituire il nucleo familiare. La fragilità psicologica di G. Pascoli è espressa dal suo attaccamento alle due sorelle e ai morti, tutto ciò è causato dai traumi infantili e dai lutti familiari, così si autoesclude dalla vita esterna, non ha relazioni amorose e vorrebbe ricostituire il nucleo familiare, però non è possibile dati i molti lutti. L’affetto però non gli è negato dalle due sorelle, che assumono una figura materna, e al matrimonio di una di loro, Ida, G. Pascoli la considera una traditrice e lo porta alla depressione. La profonda psicologia del poeta ci permette di capire il perché del carattere turbato e morboso della sua poesia. Dopo il matrimonio di Ida si trasferisce con l’altra sorella in campagna, a Castelvecchio di Barga, egli rifiuta la vita cittadina, ne è disgustato, e vede la campagna come un Eden di serenità, esteriormente dunque sembra vivere una vita felice, ma non interiormente poiché il suo animo è turbato. Arriva poi all’insegnamento universitario a Messina, Pisa, Bologna, dove conosce Carducci. Le sua raccolte di liriche è “Myricae”. Le poesie più importanti sono “La vita nuova”, “Il marzocco”, “Il Convito”, “I poemetti”,”I canti di Castelvecchio”.La visione del mondo: Giovanni Pascoli ebbe una formazione positivistica, espressa anche nel suo stile classificatorio, egli usa per esempio la nomenclatura ornitologica e botanica, fa osservazioni sulla vita degli uccelli, ha una certa fiducia nella scienza, ma come gli altri poeti, la sua matrice positivistica attraversa una crisi poiché a fine secolo prendono il sopravvento tendenze spiritualistiche e idealistiche, così egli è portato a non essere più fiducioso nella scienza come unica visione del mondo, poiché al di là dei confini raggiunti dalla scienza vi è l’ignoto, una vita misteriosa, e questa tensione verso ciò che trascende non si concreta in una fede religiosa positiva, per cui la sua visione del mondo è frammentata e disgregata, in cui non esistono neanche le gerarchie tra gli oggetti materiali, ciò che è piccolo si mescola con il grande e viceversa, ogni particolare può essere ingigantito. Così porta anche a una visione simbolica della vita, poiché la sua non è una visione oggettiva del mondo bensì soggettiva, per cui gli oggetti sono carichi di significato simbolico, rimandano a qualcosa di misterioso, anche per esempio la precisione botanica, ornitologica rimanda a significati profondi, il termine diviene la formula magica che permette di andare al cuore della realtà, di scoprire l’essenza segreta delle cose. Per cui il mondo è percepito attraverso il velo del sogno, perde ogni consistenza oggettiva, così si instaurano legami segreti tra le cose, l’io e il mondo corrispondono tra loro, non si distinguono.
La poetica: La poetica pascoliana trova espressione nel saggio “Il fanciullino”, pubblicato sul “Marzocco”. Il poeta non è altro che un fanciullo, che vede le cose per la prima volta, gli attribuisce nomi, e se ne meraviglia ingenuamente, per cui la poesia è una conoscenza irrazionale e immaginosa, che ha radici Romantiche ma che Pascoli indirizza in direzione Decadente. Il poeta fanciullo ci fa arrivare alle verità più nascoste per il suo modo alogico di vedere la realtà, ci permette di cogliere l’essenza delle cose, definendosi dunque un poeta veggente, dotato di una vista più acuta di quella degli uomini comuni, e può spingere il suo sguardo al di là dei limiti. Così la poesia oltre ad essere immaginosa è anche pura, priva di fini morali o civili, anche se proprio perché è poesia pura ha una sua utilità morale, come la poesia di Virgilio, egli faceva poesia per il gusto di fare poesia, e infondeva un messaggio, egli voleva l’abolizione della lotta tra le classi e della guerra tra i popoli. Anche perché il poeta fanciullo mira alla bontà e all’amore, e in lui non ha il concetto di odio o di guerra. Il rifiuto della lotta tra le classi per G. Pascoli è evidente anche nel suo stile, non tratta solo di argomenti elevati e sublimi, ma anche di quelli più umili, poiché anche in essi vi è il sublime, anche nelle piccole cose.
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari: Il superuomo di D’Annunzio ne “Le vergini delle rocce” e il fanciullino di Pascoli sono due miti che nascono negli stessi anni ma appaiono diversi tra loro, come disse Salinari, nel mito supero mistico prevale la lussuria, il tono esaltato, l’attivismo, oggetti esotici, il lusso, il dominio, mentre in quello del fanciullino prevale l’innocenza, la sconfitta, oggetti quotidiani, la povertà. Entrambi i miti nascono da uno stesso ambito sociale essendo contemporanei, sono una risposta alle trasformazioni sociali ed economiche di fine Ottocento, la civiltà industriale riduce l’individuo a una semplice rotellina di un enorme ingranaggio, per cui i ceti medi vengono declassati a piccolo borghesi, emarginati, a causa dei grandi capitalisti che non sono in grado di dominare la grande industria, ed è così che la nozione di uomo entra in crisi, l’uomo non è più capace di crearsi il suo mondo con la sua volontà. Di conseguenza gli intellettuali vengono declassati, si trovano costretti a scrivere per il mercato, e quindi talvolta vengono rifiutati poiché non consoni alla produzione di massa, così essi si smarriscono di fronte all’età moderna. Come risposta abbiamo il mito del fanciullino di Pascoli, che fugge dunque dalla città moderna, nella campagna, l’Eden di serenità e innocenza, questo mito se mischiato al mito del nido familiare e al mito dell’infanzia permette all’uomo di vivere serenamente e di evitare i traumi della città industriale. La risposta di D’Annunzio invece è molto diversa, con il mito del superuomo egli propone un uomo dall’atteggiamento attivistico, che non fugge dalla vita moderna, ma che assume un atteggiamento onnipotente e la elogia, elogia la civiltà industriale e tutte le sue trasformazioni, per non averne più paura, ma anche il superuomo rivela tendenze di impotenza e sconfitta, infatti egli ha il gusto per la morte, e d’altronde D’Annunzio prima del “Le vergini delle rocce” scrisse anche “Il Piacere” e il “Trionfo della morte” dove i protagonisti sono degli inetti a vivere. Dunque con il mito del superuomo egli diviene un poeta vate, infonde un messaggio di attivismo e non di sconfitta, ma anche Pascoli con la sua poesia pura infonde un messaggio di pace e fratellanza, seppur in maniere meno appariscenti. Ed entrambi si indirizzano verso il pubblico piccolo-medio borghese, schiacciate dalla società moderna.
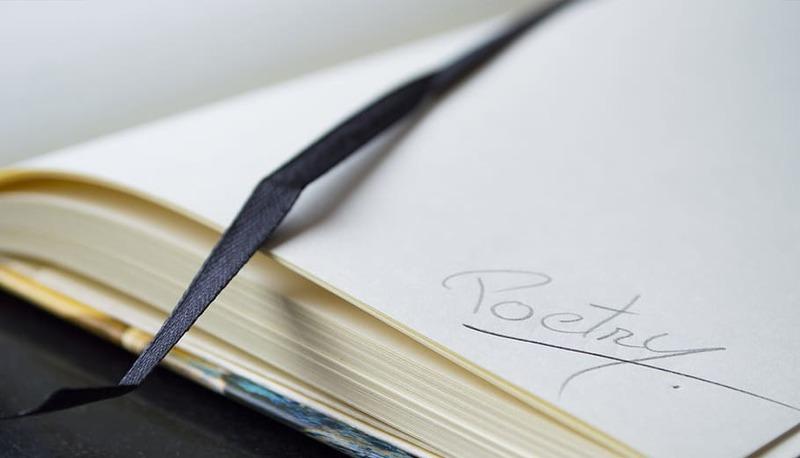
L’ideologia politica: Pascoli crede in un socialismo unitario e utopico, e affida alla poesia il compito di diffondere amore e fratellanza. Durante gli anni universitari egli subì l’influenza del socialismo e anarchismo grazie a Andrea Costa. La ribellione e le proteste contro le ingiustizie derivano dalla declassazione della classe sociale e del ruolo dell’artista, i suoi privilegi scompaiono, per cui Pascoli esprimeva la sua rabbia in atti ribelli contro la società, soprattutto a causa dell’uccisione del padre, i lutti, la povertà. Così aderì all’Internazionale socialista, e non fu una scelta dettata dalla mente bensì dal cuore. Quando fu arrestato e dopo tanto rilasciato abbandonò ogni forma di militanza attiva. Questa scelta dell’abbandono oltre ad essere dovuta a traumi personali, è anche dovuta a un cambiamento ideologico della sinistra, che passa dall’utopia al socialismo di Marx, basato sulla lotta tra le classi in cui una doveva prevalere sull’altra, mentre Pascoli aveva ancora una visione utopica, per questo rifiutava la lotta tra le classi e voleva la fratellanza, egli rifiutò la dottrina di Marx, per lui il socialismo era un impegno comune per alleviare le sofferenze, questo perché G. Pascoli aveva una visione pessimistica della vita, che non è altro che dolore e sofferenza, sulla terra domina il male, per questo gli uomini devono cercare di non farsi del male tra loro e sopire gli odi. La sofferenza stessa ha un valore morale, purifica ed eleva l’uomo, lo rende moralmente superiore, per cui deve esserci armonia tra le classi, solidarietà, ciascuno deve accontentarsi di ciò che ha. Il mondo e i valori rurali vengono idealizzati dal Pascoli, il mondo rurale è sereno e pacifico, difende i valori tradizionali della famiglia, la solidarietà, laboriosità. Il fondamento dell’ideologia di Pascoli è la celebrazione del nucleo familiare, ma questo senso di gelosia verso il nido familiare si allarga ad inglobare l’intera nazione, e qui si collocano le radici del nazionalismo pascoliano, egli sente il dramma dell’emigrazione che lo porta a pensare che esistono nazioni ricche, potenti, quelle capitaliste, e nazioni debole e oppresse come l’Italia che non riesce a sfamare il popolo e deve esportare mano d’opera, che emigrando viene schiavizzata dagli stranieri, per cui egli legittima le guerre coloniali, poiché esse sono difensive, le nazioni “proletarie” hanno il diritto di soddisfare i propri bisogni anche con la forza.
I temi della poesia pascoliana: Pascoli rientra nell’ambito culturale decadente, ma non può essere definito propriamente un poeta maledetto che va contro il mondo della borghesia, anzi egli incarna la figura del piccolo borghese, e anche in campo letterario celebra i valori borghesi, perciò la sua poesia assume una funzione pedagogica. A questo filone “ideologico” della poesia pascoliana appartiene anche la predicazione sociale e umanitaria, il sogno di un’umanità affratellata. Questa predicazione si avvale anche di miti: quello del fanciullino che può garantire fraternità agli uomini, e quello del nido familiare caldo e protettivo. Al mito del nido si collega il motivo ricorrente del ritorno dei morti che spesso sono presenti nei versi pascoliani, ma anche qui l’intento è predicatorio e pedagogico, infatti egli usa la tragedia familiare per far capire al lettore quanto male ci sia nella realtà. Pascoli così, interpreta la visione della vita e i sentimenti di strati di popolazione, e la prova di questa sintonia instauratasi tra il poeta e il pubblico è la sua fortuna scolastica. Pascoli comunque è un grande decadente, proietta nella poesia le sue ossessioni, portando alla luce zone oscure della psiche, sa esprimere le delusioni dell’anima moderna, il senso di inadeguatezza della realtà rispetto al sogno, il senso dell’irrazionale. Egli propone il mito del fanciullino, del nido protettivo, come rifugio dalle inquietudini della realtà moderna, lacerata dalla concentrazione monopolistica, conflitti tra potenze, regimi totalitari.
Le soluzioni formali: Le soluzioni formali pascoliane sono fortemente innovative, la sua sintassi è diversa da quella tradizionale in cui troviamo gerarchie di proposizioni principali, coordinate e subordinate, poiché in Pascoli troviamo il prevalere della coordinazione senza rapporti gerarchici, spesso le frasi sono ellittiche cioè mancano del soggetto o verbo. Questa frantumazione di gerarchie rivela il rifiuto di una sistemazione logica dell’esperienza, egli preferisce il prevalere dell’intuizione, della sensazione immediata. Non usa neanche un lessico tradizionale, fissato entro un unico codice, poiché mescola diversi codici linguistici tra loro, termini che trattano di settori più disparati, tuttavia non nascono scontri di livelli, poiché come afferma nel Fanciullino vuole abolire la lotta fra le classi, classi di oggetti e di parole. Quindi nei suoi testi ritroviamo termini aulici come anche termini dialettali. Quest’infrazione alla norma dominante nella poesia italiana è vista da critici come Contini come una frattura del rapporto io-mondo di Pascoli, come se egli avesse perso tutte le certezze. Sono importanti anche gli aspetti fonici della sua poesia, dove prevalgono onomatopee, ossia versi di uccelli, suoni di campane, e fonosimbolismi, ossia parole che assumono un significato di per sé, senza rimandare ad altri oggetti, e per quanto riguarda la metrica, usa apparentemente versi tradizionali, ma in realtà egli frantuma i versi, interrompendoli da pause, segni di interpunzione, parentesi.. Egli utilizza il linguaggio analogico, la metafora, che non è un semplice rapporto di somiglianza tra due oggetti, ma accosta due realtà tra loro remote, molto lontane, per questo nasce un linguaggio allusivo, e utilizza anche la sinestesia, una fusione di sensazioni.
Myricae: Pascoli pubblicò inizialmente le sue poesie su riviste, la prima raccolta vera e propria fu Myricae, che ha tre edizioni, in una prima era composta da 22 poesie dedicate alle nozze di amici, poi nella seconda divennero 72 componimenti, e nella terza 116. Il titolo è ripreso da una citazione di Virgilio nella IV Bucolica, in cui proclama l’intenzione di innalzare il suo tono poiché: non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici (le myricae). Invece Pascoli intende usare proprio le Myricae, le umili piante, come centro del tema, poiché anche le piccole cose hanno il diritto di esser trattate. I componimenti sono molto brevi, e all’apparenza sembrano quadretti di vita campestre, ma in realtà il poeta fissa la sua attenzione su particolari che si caricano di significato misterioso.
I Poemetti: I Poemetti si dividono in due raccolte, Primi poemetti, e Nuovi poemetti, sono componimenti molto più ampi rispetto a quelli delle Myricae, ma anche qui prevale la vita della campagna che si carica di intenti ideologici: il poeta vuole appunto rappresentare la proprietà rurale, depositaria di valori tradizionali e autentici, solidarietà familiare, laboriosità, bontà.. in contrapposizione alla negatività della realtà contemporanea. La vita del contadino, chiuso entro il nido, sembra dunque essere un rifugio rassicurante, un baluardo contro l’incombere della minacciosa storia, quindi si parla di utopia regressiva, egli proietta il suo ideale nel passato, e mette in rilievo quanto anche una realtà umile è degna di essere trattata in modo sublime. Prevalgono qui anche altre tematiche, inquietanti e torbide come Il vischio, una pianta parassita, vampira, che succhia la vita di un albero da frutto dando origine ad un ibrido ripugnante. Tematiche come la memoria, nell’ aquilone che fa rivivere l’infanzia, o come l’emigrazione in Italy.
I Canti di Castelvecchio: Questi canti sono stati definiti dal poeta stesso > quindi sembrano continuare la linea della prima raccolta, infatti anche qui ritornano immagini della vita di campagna, canti di uccelli e suoni campane, ricorre con frequenza il motivo della tragedia familiare e il rimando del nuovo paesaggio di Castelvecchio a quello antico dell’infanzia in Romagna.
Una poetica decadente – lettura: Il saggio uscì sul “Marzocco”, nella versione definitiva fu poi ripubblicato nella raccolta di prose dal titolo “Miei pensieri di varia umanità”. Qui risaltano i punti essenziale della teoria pascoliana della poesia: il tipo di conoscenza prerazionale e immaginoso proprio del fanciullino che coglie la realtà nella sua essenza; la verginità della parola poetica; la poesia pura senza fini ma che proprio per questo incita alla fratellanza, a un’utopica società senza conflitti; il rifiuto della separazione classica degli stili, poiché la dignità va scoperta anche nelle piccole cose. Questo concetto è espresso anche nelle metafore floreali: belli e degni di essere cantati non sono solo gli esotici e rari fiori delle >, ma anche i piccoli fiori della >.
Arano – lettura: Al sopraggiungere dell’autunno il poeta compie un’immaginaria passeggiata nella campagna toscana prima di tornare in città, sono due terzine e una quartina. Apparentemente a prima vista sembra un quadro realistico, ma in realtà ci sono profondi significati, la lirica si apre con impressioni visive con il > ossia il pampano rosso, la nebbia che sale, poi, con il verbo > al 4 verso, muta scena, e vi sono animali e persone in movimento che esprimono la realtà rurale, ma non si riduce a questo, poiché vi è un senso di malinconia, dato dalla nebbia che sale, dalle voci sperdute dei contadini, dalla loro fatica paziente, coscienti che dopo aver seminato la terra arriveranno uccelli a beccare i semi. La quartina finale invece esprime il punto di vista degli uccelli, umanizzati dal poeta che gioiscono poiché tra poco beccheranno semi, e il verso finale contiene una sinestesia: >, poiché rimanda a un suono, il verso del pettirosso, una sensazione visiva, il luccichio del metallo, che vi è anche all’inizio della poesia con il termine >.
X agosto – lettura: La poesia è diversa dalle altre di Myricae poiché non è un quadro di natura, ma rievoca la propria tragedia familiare, l’uccisione del padre che avviene il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, il poeta crede che appunto il cielo pianga stelle per questa morte. Il discorso è costruito su studiate simmetrie, la prima corrisponde all’ultima, perché riguarda il pianto del cielo, le strofe 2 e 3 invece corrispondono a quelle 4 e 5, in cui vi è il tema dell’uccisione di una rondine che non può più portare il cibo ai suoi rondinini che pian piano muoiono, paragonato all’uccisione del padre, che allo stesso modo non può far ritorno a casa. Vi sono anche allusioni a Cristo, la rondine muore su spine come in croce, come dice Pascoli, anche il padre, morendo, perdona i suoi uccisori come fece Cristo. Il tema centrale comunque è il male, la malvagità umana che uccide innocenti.
Il Gelsomino notturno – lettura: La poesia fu composta per le nozze dell’amico Gabriele Briganti, è composta di quartine di novenari. La chiave che permette di meglio interpretare la poesia è una nota che Pascoli inserì facendo riferimento alla poesia, vi scrisse che l’odore del Gelsomino notturno, un fiore che si schiude di notte, è un invito all’amore. La casa descritta nella poesia, in cui vi è acceso un lume, che poi viene spento, è la casa nuziale di Gabriele, in cui attraverso il rito di fecondazione darà alla vita il figlio Dante Gabriele Briganti. Ma all’alba, i petali del fiore si chiudono, >, il vagheggiamento del tema amoroso è turbato per Pascoli, crede che il rapporto sessuale è una violenza inferta alla carne, inoltre, possiamo capire dalle ricorrenti immagini mortuarie della poesia, che per lui, legarsi a una donna significherebbe tradire il vincolo con i suoi cari.
Biografia e liriche di Pascoli
Vita: La vita del poeta appare ordinaria, monotona e banale. La sua è un'esistenza piccolo-borghese, tutta dedita allo studio e alla composizione di poesie. Scorre la maggior parte della sua vita da solo, desideroso di pace e di quiete che egli identifica con la vita in campagna e la convivenza con le sorelle.Pascoli nasce il 31 dicembre 1855 a San Mauro di Romagna. Il padre importante amministratore assicura la famiglia buone condizioni economiche. All'età di sette anni entra come allievo al collegio Raffaello di Urbino, dove acquisisce un'ottima educazione classica. Il 10 agosto 1867, il padre viene ucciso a colpi di fucile, mentre tornava a casa, questo è un tema molto ricorrente nelle sue opere e fino alla fine si ostina vanamente nel ricercare gli assassini (rimasti impuniti).
Lutto: tema molto ricorrente in 10 agosto o la cavallina storna. Una ferita mai rimarginata, un nido disfatto (morte del capofamiglia). L'anno successivo muoiono anche la madre, il fratello e la sorella.
Pascoli, nonostante le ristrettezze economiche, si impegna per portare a termine gli studi liceali, riuscendo a conseguire una borsa di studio che gli consente di frequentare la facoltà di lettere dell'Università di Bologna. Fa parte di numerosi gruppi anarchici e socialisti, che lo coinvolgono in numerose manifestazioni, che alla fine si conclusero con l'arresto e la detenzione. Dopo la scarcerazione, e decise di chiudere per sempre con l'attività politica in seguito nascerà in lui una forma di nazionalismo visto come allargamento del nido familiare alla patria.
Nido: qualcosa che lo protegge, un'unità familiare diviene la sua misura del mondo; e senza di esso si sente perso e vulnerabile (specialmente quando la sorella Ida decide di sposarsi).
Negli ultimi anni, insieme all'ultima sorella, acquista una proprietà di campagna e vi si trasferisce. Per quanto riguarda la sua carriera, diventa sempre più famoso, e passò dall'essere un semplice professore di liceo ha stimato professore universitario. Morirà il 6 aprile 1912 dopo anni non facili e continui turbamenti.
La poetica: La poetica di Pascoli non è coerente e sistematica, un ruolo centrale nell'elaborazione di Pascoli svolge il saggio intitolato il fanciullino infanzia è un momento intatto, non toccato dal male, è l'età della perfetta innocenza a cui si ritorna grazie alla memoria (il fanciullino è presente in ognuno di noi, quando si diventa adulti la sua voce viene nascosta e non riusciamo più a sentirla). Pascoli e a livello individuale e familiare.
Pascoli continuò dicendo che il poeta è colui che sa ascoltare il fanciullino che è in lui, che prova stupore nelle cose quotidiane. Per Pascoli la poesia non si entra ma si scopre, la scopre il fanciullino nel suo ciarlare, in quanto la poesia non è qualcosa di razionale, ma è dotato di una scoperta.
Mentre nel simbolismo il poeta era veggente, in Pascoli il fanciullino scopre appunto le cose e da adulti non si riescono a cogliere. I protagonisti della poesia di Pascoli sono la campagna (umili fatiche, attrezzi da lavoro) e usa titoli impensabili fino ad allora come Galline, La polenta e Arano.
Il tema del simbolismo invece, non è esplicitamente affrontato nel fanciullino ma se ne colgono i tratti principali. Pascoli si addentra in un tessuto cifrato di simboli e allegorie.
Vita e Opere di Pascoli
Giovanni Pascoli nacque nel 1855 a San Mauro di Romagna da una famiglia agiata della borghesia rurale, era il quarto di dieci figli. Il 10 agosto 1867 il padre Ruggero fu ucciso a fucilate, mentre tornava a casa. Questa morte creò una situazione di difficoltà economica e la famiglia lasciò la tenuta per trasferirsi a Rimini. Al primo lutto seguirono quelli della mamma e della sorella e poi quelli dei due fratelli preferiti, Luigi e Giacomo. Egli ricevette un’educazione classica e frequentò la facoltà di Lettere e filosofia a Bologna grazie ad una borsa di studio. In questi anni subì il fascino socialista, ma durante una manifestazione fu arrestato e trascorse alcuni mesi in carcere; Pascoli restò fedele al socialismo, ma solo a quello umanitario. Dopo la laurea iniziò la carriera di insegnante liceale a Matera e poi a Massa, dove chiamò a vivere con sé le sorelle Ida e Mariù, ricostruendo il "nido" familiare distrutto. La chiusura nel nido rivelava la fragilità del poeta che cercava nel nido una sorta di protezione dal mondo esterno.A questo si unisce il ricordo ossessivo dei morti, le cui presenze aleggiano costantemente nel nido, riproponendo i dolori passati e inibendo i rapporti col la realtà. Infatti, non vi erano relazioni amorose, ma c’era il lui il desiderio di un vero nido in cui esercitare la figura di padre, reso irrealizzabile dal legame con il nido infantile spezzato. Le esigenze affettive del poeta furono colmate dal rapporto con le sorelle (fanciullino-figure materne e figura paterna-figlie). Il matrimonio della sorella Ida fu visto come un tradimento dal poeta. Nel 1895 Pascoli prese in affitto una casa a Castelvecchio, vicino a Lucca, considerandola un luogo di serenità e pace; una vita esteriormente serena, ma turbata interiormente da angosce e paure (morte, cataclismi storici). Egli ottenne varie cattedre universitarie e nel 1905 subentrò al suo maestro Carducci a Bologna. In questi anni universitari, pubblicò le sue raccolte liriche e vinse dodici concorsi di poesia latina ad Amsterdam. Negli ultimi anni volle gareggiare con D’annunzio e Carducci nella funzione di poeta civile (vate), con il compito di diffondere ideologie e miti. Giovanni Pascoli morì a Bologna nel 1912.
Opere: La sua formazione è di tipo positivistico (ossessiva precisione nella nomenclature e nella classificazione), ma in lui insorge la sfiducia della scienza tipicamente decadente; per lui, al di là dei confini della scienza, si apre l’ignoto e il mistero. Il mondo nella visione pascoliana appare quindi frantumato e non più ordinato; non esistono neppure gerarchie d’ordine fra gli oggetti. Gli oggetti materiali hanno un rilievo fortissimo nella poesia pascoliana; i particolari sono filtrati attraverso la visione soggettiva del poeta che li carica di valenze simboliche. Anche il suo rigore classificatorio diviene come un modo per scoprire nuovamente la realtà, indagandola a fondo. Questa percezione soggettivistica del reale si può accostare quindi ad una percezione onirica, in cui il reale perde ogni consistenza oggettiva. Si instaurano così legami tra le cose che possono essere colti solo alogicamente e attraverso strumenti non razionali (idealismo intuitivo/creativo). L’io si confonde con la realtà oggettiva e le cose acquistano una fisionomia antropomorfizzata.
La poetica pascoliana si trova espressa nel saggio "Il fanciullino". L’idea centrale è che il poeta sarebbe rappresentato dal fanciullo che vive dentro ogni uomo (puer ut poeta). Questo fanciullo vede le cose "come per la prima volta" e quindi con stupore e meraviglia, assegnando i nomi e scoprendo le somiglianze tra esse. C’è quindi una concezione della poesia come conoscenza prerazionale e immaginosa. Quest’atteggiamento a-logico consente una conoscenza profonda della realtà senza mediazioni logiche. Il poeta è quindi un veggente, dotato di una vista più acuta degli altri. Per Pascoli la poesia non deve avere fini pratici, ma deve essere pura: il poeta canta solo per cantare, senza obiettivi civili o propagandistici (come Virgilio che nel canto puro insegnava ad amare la vita). Il sentimento poetico, infatti, dando voce al fanciullino, sopisce gli odi e induce alla bontà. Pascoli ripudia il classicismo che separa le cose alte da quelle basse, secondo lui la poesia è anche nelle piccole cose che hanno un loro sublime al pari delle cose auliche.
Pascoli, negli anni universitari, aderisce al socialismo e all’anarchismo, atteggiamento tipico tra gli intellettuali piccolo-borghesi dell’epoca che si sentivano frustrati per quel processo di declassazione che li stava emarginando. Con l’arresto però si attua il distacco dalla militanza attiva.
Questo distacco è però dovuto anche alla crisi generale della sinistra che vede, nel 1879, accantonare il pensiero di Bakunin in favore di quello marxista (lotta di classe). Questo principio va contro l’animo di Pascoli, il quale sognava la fratellanza tra tutti gli uomini. Il socialismo diventa quindi per lui un appello alla bontà e alla solidarietà fra gli uomini. Alla base vi è una concezione pessimistica, basata sul dolore e sulla sofferenza della vita umana; per questo motivo gli uomini, vittime della loro condizione, devono amarsi e aiutarsi a vicenda. Per fare ciò è necessario evitare la bramosia e quindi accontentarsi di ciò che si ha. Per Pascoli inoltre la sofferenza ha un valore morale, infatti, purifica ed eleva a condizioni morali superiori (dolore utile).
Il suo ideale di vita si incarna quindi nel piccolo proprietario rurale (felicità possibile solo nel piccolo). Inoltre per Pascoli la proprietà è un valore sacro. Questo senso geloso della proprietà alla fine si allarga alla Nazione (nazionalismo). Egli sente fortemente il dramma dell’emigrazione (strappare dal nido). Distingue così le Nazioni in capitaliste e proletarie (Italia) e queste ultime non riescono a sfamare i propri figli, essendo dunque costrette alle azioni di forza (legittimazione delle conquiste coloniali, celebrazione della la guerra di Libia nel 1911).
La poesia pascoliana rivela una sensibilità decadente, ma Pascoli è l’esatto contrario del poeta maledetto, anzi incarna esemplarmente il piccolo-borghese appagato dalla sua mediocrità. La sua poesia ha fini pedagogici (accontentarsi del poco, evitare i conflitti tra classi) ed è evidente la predicazione del socialismo umanitario. Questa predicazione si avvale anche di miti (valore suggestivo): il fanciullino e il nido familiare; al nido si collega il motivo del ritorno dei morti. Proprio per il valore pedagogico delle sue opere, Pascoli può essere definito poeta vate e rivaleggiare con D’annunzio.
Pascoli, a differenza di D’annunzio che offriva alle masse un sogno evasivo di gloria, ribadisce nel pubblico le convinzioni profonde che già aveva e la fede in alcuni valori fondamentali. Quest'immagine di Pascoli, gli ha concesso la fortuna scolastica. Si è però scoperto anche un poeta diverso, tormentato e inquieto, decadente. È il Pascoli che adora il mistero, che carica di valore simbolico le parole, che disgrega l’ordine reale e esprime le sconfitte esistenziali dell’età moderna. Si delinea quindi un grande poeta dell’irrazionale. Questi "due" Pascoli hanno una matrice comune: la celebrazione del nido, della mediocrità appagata del piccolo-borghese, della fraternità umana, che sono come un baluardo rassicurante dinanzi all’insorgere di forze minacciose (paura e sgomento quindi chiusura nel nido che da protezione).
Questo modo di percepire il reale si traduce il soluzioni poetiche innovative.
L’aspetto che prevale è quello sintattico: a differenza della tradizione, vi è una prevalenza di
coordinazione, le frasi sono ellittiche, mancano del soggetto o del verbo. Questa frantumazione rivela il rifiuto dei sistemi logici e il prevalere delle sensazioni immediate e dei rapporti analogici. La conseguenza è che gli oggetti quotidiani appaiono come immersi in un’atmosfera visionaria o in un sogno. A livello lessicale il discorso è uguale. Pascoli non usa un linguaggio unico, ma mescola tra loro codici linguistici diversi senza però conflitti di livello (abolire la lotta tra le classi di parole).
Vengono utilizzati dal poeta termini aulici, dialettali, specifici o in lingua straniera. Grande rilievo hanno anche gli aspetti fonici; sono molto presenti le onomatopee che per Pascoli sono cariche di valore simbolico. È inoltre onnipresente il fonosimbolismo (i suoni tendono ad assumere un significato di per sé stessi, senza rimandare al significato della parola) che crea una trama di echi e rimandi. La metrica è apparentemente tradizionale (versi soliti), ma questi versi sono piegati in direzioni personalissime (cambia accenti e cadenze). Anche il verso è frantumato all’interno e interrotto da pause (incisi, parentesi). Sono presenti molti enjambement che accentuano la frammentazione. Il linguaggio analogico è espresso nella metafora; quest’analogia però accosta in modo impensato due realtà tra loro remote, eliminando tutti i passaggi logici intermedi.
Un procedimento affine all’analogia è la sinestesia (carica allusiva e suggestiva) che fonde diversi ordini di sensazioni. Pascoli influenzerà la poesia ermetica. Le sue poesie sono unite in raccolte poetiche che però non seguono una successione cronologica. La sua poesia è sincronica (arricchimenti, approfondimenti, mutamenti di stile), ma senza svolte radicali. Le raccolte sono: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali e Odi e Inni.
Poemetti: Essi si compongono di componimenti più lunghi e con taglio narrativo (racconti in versi), ai versi brevi subentrano le terzine dantesche. È un vero e proprio romanzo georgico (campagna e vita contadina) e la narrazione è articolata in cicli che prendono il titolo dalle varie operazioni del lavoro nei campi. Pascoli vuole celebrare la piccola proprietà rurale (depositaria dei valori tradizionali) e la vita del contadino, chiusa nel nido domestico (rifugio rassicurante contro la realtà storica minacciosa. Si tratta quindi di un’utopia regressiva (ideale nel passato). Questa rappresentazione della campagna non ha punti in contatto con quella veristica, in quanto il mondo pastorale è idealizzato e idillico e ignora gli aspetti crudi della realtà. Pascoli si sofferma sugli aspetti quotidiani e umili, mettendone in rilievo quanto di poetico è presente nelle cose umili, trasfigurandole in una luce epica.
Al di fuori di questo ciclo si collocano numerosi poemetti come: Il vischio, una pianta parassita che succhia la vita; Digitale purpurea, con al centro un "fiore di morte" che inebria le educande di un convento, Suor Virginia, in cui aleggia un presagio di morte, L’aquilone sul tema della memoria che riporta a stagioni passate facendo rivivere l’infanzia, Italy sul dramma dell’emigrazione e il dualismo tra la nuova patria industriale e l’arcaicità della campagna, La vertigine che esprime l’angoscia originata dal percepire la terra muoversi nel cosmo e il terrore di precipitare senza fine.
Canti di Castelvecchio: Continuano la linea di Myricae, infatti, ritornano immagini della vita di campagna, uccelli, alberi. I componimenti si susseguono come il succedersi delle stagioni (ciclo naturale come rifugio dalla condizione storica). Ricorre con frequenza ossessiva il motivo della tragedia familiare e il rimando del nuovo paesaggio di Castelvecchio a quello antico dell’infanzia in Romagna (legame ideale tra il vecchio e il nuovo nido costruito dal poeta). Non mancano temi inquietanti e morbosi (morte come rifugio in cui sprofondare come regressione nel grembo materno, l’eros come turbamento del fanciullo, apocalissi universali future).
Poemi conviviali: Parte di essi era comparsa sulla rivista "Il convito". Aderiscono al clima estetizzante, infatti, sono dedicati a personaggi e fatti del mito e della storia antica (Achille, Ulisse, Socrate). Il linguaggio mira a riprodurre in italiano il clima e lo stile della poesia classica; l’estetismo si rivela anche nell’assaporamento quasi sensuale dei bei nomi che sono resi nella grafia greca originaria. Compaiono tutti i temi pascoliani, infatti, il mondo antico si carica delle inquietudini e delle angosce della sensibilità moderna.
A questi poemi si possono accostare anche i Carmina latini, scritti per il concorso di poesia latina di Amsterdam. Non sono stati raccolti dal poeta e trattano degli aspetti marginali della vita romana (umili, schiavi, gladiatori). Vi si proietta l’ideologia umanitaria di Pascoli con attenzione per il messaggio cristiano che esalta la libertà e respinge la schiavitù. Nelle ultime raccolte (Odi ed inni, Poemi Italici) Pascoli assume le vesti del poeta ufficiale e celebratore delle glorie nazionali, inteso a propagandare principi morali e civili, prendendo spunto dalla storia medievale, rinascimentale e risorgimentale, emulando Carducci e D’Annunzio. Sono presenti virtuosismi linguistici e sono di difficile lettura.
Pascoli è stato inoltre saggista e critico. Oltre Il fanciullino, ha scritto saggi su Leopardi, Manzoni e soprattutto su Dante. Il poeta ha scritto inoltre delle antologie scolastiche. Lo stile di prosa è lontano da quello erudito del tempo, infatti, adotta un tono colloquiale e pacato.
per ulteriori approfondimenti su Pascoli vedi anche qua
Rapporto uomo-natura: confronto Pascoli e Leopardi
Il tema del rapporto uomo-natura diviene di nuovo centrale nella poetica del XIX secolo, favorito dalla nascita di correnti artistico letterarie come il romanticismo e il neoclassicismo. Gli autori del tempo accolgono questo nuovo sentimento e offrono una loro interpretazione sulla questione. Lo fa ad esempio Pascoli, la cui idea di rapporto uomo-natura si differenzia dall’idea leopardiana. Vediamone le caratteristiche. Mentre in Leopardi la natura è considerata inizialmente un’entità benefica che illude sì l’uomo ma proprio grazie a questa illusione lo rende capace di virtù, in un secondo periodo, quello definito dalla critica come “pessimismo cosmico”, egli parla di Natura matrigna, colpevole dell’infelicità umana di cui non si cura minimamente. L’uomo è destinato alla sofferenza mentre la natura prosegue il suo corso verso la sopravvivenza senza degnarlo di attenzioni. L’unico modo che ha l’uomo di reagire a questa sofferenza è raggiungere un equilibrio con se stesso. In Pascoli invece la natura ha totalmente un valore simbolico. Ogni cosa in natura è simbolo e compito del poeta è portare alla luce il significato invisibile di ciò di cui si fa esperienza. Questo è ben visibile nella sua poesia “Il Gelsomino notturno”, pubblicata nel 1903 e contenuta nella raccolta “I canti di Castelvecchio”. Nella sua poesia ogni cosa rappresenta qualcos’altro e il canto è pieno di figure retoriche che permettono al poeta di creare somiglianze similitudini tra la natura e una realtà altra. Per Pascoli il compito del poeta non è inventare del nuovo, ma scoprire e intuire cosa si cela dietro i simboli della natura. Inoltre, la natura pascoliana è rassicurante, e rassicura attraverso il ripetersi dei cicli stagionali. Se dunque per Leopardi il rapporto uomo-natura ha una profondità filosofica e legata alla tradizione romantica, in Pascoli abbiamo una visione fortemente moderna.Domande da interrogazione
- Cosa scrisse Giovanni Pascoli?
- Per cosa è morto Pascoli?
- Dove abitava Pascoli?
- Quali sono le poesie più famose di Giovanni Pascoli?
- Giovanni Pascoli, dove è nato?
- Giovanni Pascoli a quale corrente letteraria appartiene?
Giovanni Pascoli scrisse Myricae e le sue poesie più importanti sono: La vita nuova, Il marzocco, Il Convito, I poemetti,I canti di Castelvecchio.
Pascoli è morto a causa della cirrosi epatica.
Giovanni Pascoli visse a lungo a Castelvecchio di Barga.
Le sue poesie più importanti sono: La vita nuova, Il marzocco, Il Convito, I poemetti,I canti di Castelvecchio.
Giovanni Pascoli è nato a San Mauro di Romagna.
Giovanni Pascoli appartiene alla corrente letteraria del decadentismo.

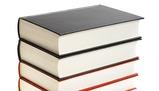





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo