Concetti Chiave
- Il Verismo è una corrente letteraria italiana dell'Ottocento, fondata da Giovanni Verga, che ritrae la vita quotidiana delle classi meno abbienti in modo realistico e senza abbellimenti.
- Il movimento si ispira al Naturalismo francese e al Positivismo, ma si distingue per il focus su contadini e ambienti rurali del sud Italia, piuttosto che sulle aree metropolitane.
- Le opere veriste sono caratterizzate da una descrizione oggettiva e impersonale della realtà, evitando commenti o giudizi da parte degli autori.
- Giovanni Verga, Luigi Capuana e altri autori veristi impiegano tecniche narrative come il linguaggio dialettale e la paratassi per riflettere la cultura e il linguaggio delle classi popolari.
- Il Verismo si differenzia dal Naturalismo per il suo tono pessimistico e per la rappresentazione della realtà sociale italiana, senza la fiducia nel progresso presente nel Naturalismo francese.
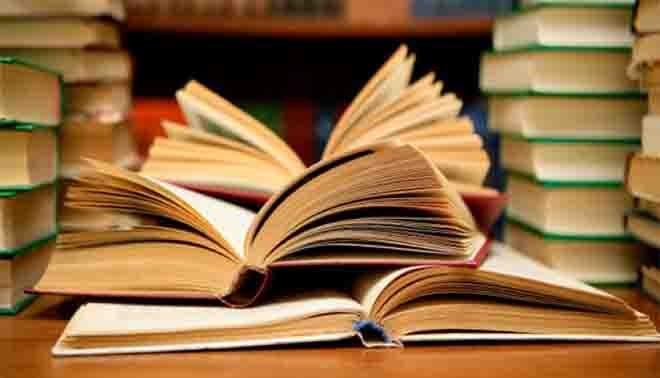 Inoltre nelle opere veriste, gli autori non devono mai commentare la realtà, ma devono solo limitarsi a descriverla.
Inoltre nelle opere veriste, gli autori non devono mai commentare la realtà, ma devono solo limitarsi a descriverla.Indice
Verismo italiano
Il Verismo è una corrente letteraria non complessa che si sviluppa nel sud Italia tra gli ultimi decenni del XIX secolo e i primi del XX secolo.Questa corrente, insieme al Naturalismo in Francia, e al Realismo in Russia e Inghilterra, si basa sul Positivismo, corrente filosofica. Il Positivismo analizza la realtà con il metodo scientifico.
Il Naturalismo e il Verismo: le differenze: Il Verismo deriva dal Naturalismo francese ma presenta anche dei caratteri diversi e originali. Tutte e due le correnti sono basate sul vero, e gli autori si propongono di raccontare la realtà, così com’è e senza abbellirla.
Mentre nel Naturalismo gli autori si occupano di descrivere le condizioni degli operai, il Verismo, che si sviluppa soprattutto nel sud Italia, si occupa dei contadini (nel sud non sono presenti industrie).
Le caratteristiche: Le caratteristiche del Verismo sono:
- la fotografia della realtà: gli scrittori devono descrivere la realtà così com’è, senza alterarla;
- il pessimismo: le opere dei veristi esprimono una concezione pessimista della vita; l’unità nazionale non ha cambiato le sorti delle classi più povere;
- l’impersonalità: gli autori non devono commentare la realtà, e devono descriverla in modo oggettivo (Giovanni Verga, nelle sue opere, cerca di rimanere imparziale; i critici, in seguito, leggendo le sue opere, diranno che non è rimasto imparziale);
- il linguaggio: viene utilizzato un linguaggio dialettale, semplice e diretto al pubblico perché i protagonisti delle opere sono le classi povere.
Lo scrittore più importante è Giovanni Verga. Altri scrittori sono:
- Luigi Capuana
- Federico de Roberto
- Matilde Serrao
- Grazia Deledda
Verismo, caratteristiche
Le radici culturali del Verismo: Il Verismo nasce in Italia nella seconda metà dell'800 come conseguenza degli influssi del Positivismo che suscitò negli intellettuali fiducia nel progresso scientifico. L'influenza del Positivismo si manifestò in vari settori, fra i quali la letteratura. Esso è un movimento filosofico che nasce in Francia attorno alla metà dell'800 e si diffonde grazie al francese A.Comte e all'inglese C. Darwin.Caratteristiche del Verismo: Verso la fine degli anni '70, grazie all'impegno critico di Luigi Capuana e al genio narrativo di Giovanni Verga, si afferma il Verismo. Fra i principali motivi che contribuirono all'affermazione di questo movimento vi fu prima di tutto la crescente attenzione verso lo sviluppo del sapere scientifico, che sembra fornire gli strumenti più adeguati all'osservazione e alla spiegazione dei fenomeni naturali e dei comportamenti umani. Il secondo elemento determinante fu l'emergere della questione sociale in genere e in particolare, il diffondersi dell'interesse per le condizioni di vita del Meridione, un argomento che costituiva la materia privilegiata per quell'analisi oggettiva della realtà che i nuovi orientamenti della cultura consideravano un'esigenza primaria. Un ulteriore motivo di diffusione fu la volontà di favorire la crescita del livello culturale dei ceti popolari.
La dottrina del Verismo fu elaborata nel centro culturale più vivace di quel periodo, l'ambiente milanese. Colui che ne enunciò per primo i canoni teorici fu L. Capuana e il suo romanzo "Giacinta", può essere considerato un vero e proprio manifesto programmatico della nuova poetica. Sulle sue teorie esercitarono il loro influsso i modelli del realismo inglese, ma soprattutto i romanzi del naturalista francese Emile Zola. Le idee del Capuana sul romanzo, ebbero una palese influenza su tutto il gruppo della Scapigliatura lombarda e in particolare su G. Verga, che fu spinto verso il definitivo abbandono della maniera tardo romantica.
Il Verismo che si diffonde in Italia, deriva direttamente dal Naturalismo, ma è fedele alla indicazioni provenienti dalla Francia più nella teoria che nell'applicazione concreta. Verismo e Naturalismo condividono una narrativa realistica, impersonale e scientifica, che non lascia trapelare nessun intervento né giudizio da parte del narratore, mentre differiscono per quanto riguarda i contesti dove sono ambientate le vicende. Il Naturalismo si focalizzava di norma su ambienti metropolitani e classi (dal proletariato all'alta borghesia) legate alle grandi città e al loro sviluppo; il Verismo invece, privilegiava le descrizioni di ambienti regionali e municipali e di gente della campagna. La piccola provincia e la campagna, con la miseria e l'arretratezza, gli stenti e le ingiustizie sociali divennero i luoghi e i temi prediletti de esso e contribuirono in modo decisivo a svelare aspetti profondi o addirittura sconosciuti della realtà sociale.
Giovanni Verga: Vita: Nasce a Catania il 2 Settembre del 1840 in una famiglia di agiate condizione economiche e di origine nobiliare. I tipi di educazione ricevuta sono sul piano politico, patriottica e risorgimentale; sul piano letterario, sostanzialmente romantica. Fondamentali nella sua vita sono gli anni fiorentini (1865-72), dove avviene l'incontro con L. Capuana, con il quale inizia un rapporto d'amicizia e un sodalizio letterario. Più tardi si trasferisce Milano, città in cui vivacissimi sono gli scambi letterari; nasce proprio in quegli anni la Scapigliatura. La fase milanese coincide con la maturità dello scrittore e con la grande stagione dei capolavori. L'ultima fase della vita del Verga è caratterizzata dallo scambio epistolare con la contessa Dina di Sordevolo, conosciuta a Roma e amata per tutta la vita. Muore a Catania nel 1922.
Personalità: Discreto, solitario e riservato pur mantenendo sempre un tratto cortese, contrario a qualsiasi forma di pubblicità, chiuso in una sorta di costante malinconia: erano questi gli aspetti del Verga. Ne emerge l'immagine di un uomo sensibile, ma dal carattere difficile, per il quale l'approdo al Verismo, rappresentò forse il mezzo ideale per nascondere se stesso dietro la propria opera. Egli visse in un'epoca di transizione, caratterizzata dal passaggio dall'idealismo dell'Italia risorgimentale allo scetticismo positivistico dell'Italia post-unitaria, tanto vero che questa rinuncia all'idealismo romantico in nome di un atteggiamento di fiducia nella scienza si tradusse nel Verga in una forma di rassegnazione e accentuò la sua visione pessimistica della vita, vista come una drammatica lotta in cui solo il più forte è destinato a vincere e il più debole, fatalmente a soccombere.
Verismo, descrizione
Dal punto di vista cronologico nasce qualche decennio dopo il naturalismo francese. Tuttavia ha in comune con il fenomeno francese la teoria dell’impersonalità. Il primo autore italiano a teorizzare il verismo fu Luigi Capuana, il quale teorizzò la "poesia del vero"; in seguito tuttavia Verga, che dapprima era collocabile nella corrente letteraria tardo romantica (era stato soprannominato il poeta delle duchesse e aveva un successo notevole) intraprese la strada del verismo con la raccolta di novelle Vita dei campi e infine col primo romanzo del Ciclo dei Vinti, I Malavoglia, nel 1881. In Verga e nei veristi, a differenza del naturalismo, convive comunque il desiderio di far capire al lettore il proprio punto di vista sulla vicenda, pur non svelando opinioni personali nella scrittura.•Il fine dell'opera d'arte: il naturalismo francese ha un approccio positivo e crede che l’opera possegga una valore sociale intervenendo nella società. l’unico senso possibile dell’attività letteraria sia nel suo essere utile alla società, concependola come impegno civile, opera prestata alla costruzione della società e alla sua crescita morale. In Italia, invece, si tende esclusivamente a denunciare una situazione esistente fondata sulla componente darwiniana secondo cui gli ultimi sono destinati a soccombere in una selezione naturale della razza.
•L'ambientazione: il naturalismo predilige luoghi suburbani. In Italia, invece, prediletto è il mezzogiorno e i paesini a vocazione agricola e peschereccia che diventano emblema del fatalismo e della povertà; Si rappresentano soprattutto le realtà sociali dell'Italia centrale, meridionale e insulare.
•Lo stile: nelle opere francesi la descrizione è quasi clinico - scientifica, secondo uno stile sobrio e asciutto. Nelle opere italiane, invece, permane il filtro letterario per cui l’impersonalità rimane nei contenuti, ma non nello stile e nella forma.
•Il verismo italiano presenta caratteri regionalistici derivanti da una situazione economica e sociale segnata dal ritardo dell'industrializzazione e dalla centralità della questione contadina. Il naturalismo francese, invece, conserva una certa integrità e omogeneità.
•Politica = gli scrittori veristi non attribuiscono, generalmente, alle loro attività letterarie quel valore politico che è invece un dato fondamentale in molti autori francesi, vicini ai movimenti popolari e socialisti.
Verismo e Realismo
Il Realismo è una corrente storica e letteraria che si sviluppa in Europa nel diciannovesimo secolo.In Italia esso si diffonderà più tardi che nel resto dell’Europa – siamo intorno al 1874 - e sfocerà nel Verismo.
Il Realismo nasce in seguito al Romanticismo, convenzionalmente terminato in Italia nel 1848, quando questo si era già unito ed identificato da tempo con il Risorgimento e aveva acquisito tematiche di carattere sociale.
Il Risorgimento faceva infatti leva sullo spirito di nazionalità, e sul fatto che i popoli fossero manifestazione dello “spirito assoluto”.
Da “nazione” si voleva cioè divenire “stato”.
Quindi, in quel periodo, lo scrittore si era fatto portavoce di quel desiderio di libertà e di quell’orgoglio nazionale che all’inizio caratterizzava una ristretta cerchia di intellettuali, ma che poi si era diffusa sempre di più.
Tutto cambia però in seguito all’Unità d’Italia, quando, per forza di cose, questa spinta cessa.
Comincia dunque, prima ancora del Realismo, una sorta di nuovo Romanticismo, un nuovo tipo di letteratura volta ad esaltare le imprese di coloro che hanno vissuto i drammi del Risorgimento.
Pian piano la parola “italiano” comincia ad avere un senso, e l’intellettuale comincia ad elogiare le imprese eroiche del recente passato.
L’azione prevale dunque sulla parola.
Allo stesso modo non sono rare le rivisitazioni della letteratura risorgimentale.
Come Padre Bresciani, che dà nuovi contenuti ai Promessi Sposi di Manzoni asserendo che la città assume nell’opera il significato di luogo di correzione, mentre Lucia – protagonista della storia - quello di fanciulla martire della società corrotta.
Lo scopo è quello di mettere i giovani in guardia contro le false promesse ed il miraggio della città e del progresso.
Sono infatti gli anni, questi, della “social novel”, come quella di Dickens.
Tempo dopo, comunque, ecco che arriva anche in Italia il Realismo, il quale si trasforma in Verismo. Esso nasce convenzionalmente 20 anni dopo il realismo, nel 1874, quando Verga pubblica “Nedda”.

Benedetto Croce osservò che in letteratura possono essere riconosciuti due tipi di Romanticismo: uno storico (e che è quello propriamente detto), ed uno “perenne”, che bene o male ha sempre caratterizzato prosa e poesia.
Lo stesso si può dunque dire del Realismo: lo stesso Dante Alighieri e lo stesso Giovanni Boccaccio ne fanno già uso nelle loro opere, per ritrarre la loro società.
Nel caso del Realismo storico, esso va dal 1850 al 1900.
Esso assume due aspetti: uno “classicista”, che è quello che troviamo nel Carducci, ed uno “fotografico e positivista”.
Quest’ultima corrente assume il nome di Naturalismo in Francia e di Verismo in Italia.
Il realismo classicista nasce invece dal rifiuto delle descrizioni romantiche dell’ “Italietta”, che avevano avuto il solo di risultato di “piangersi addosso” senza risolvere i problemi. Sentimento e intelletto vanno invece utilizzati per risolvere i problemi, ed indirizzare l’azione. Vanno perciò recuperati anche i grandi ideali individuali del mondo antico.
Per quanto riguarda Naturalismo e Verismo, invece, le ragioni per cui abbiamo in Francia e in Italia due differenti correnti realiste sono presto spiegate.
In Italia è infatti accesa la questione sociale, mentre in Francia l’urbanesimo si è già affermato, e con esso il positivismo, alla cui base vi è la convinzione che la realtà sia tutta regolata dal principio della “causalità”.
In un modo o nell’altro, comunque, la realtà sociale diventa il centro dell’interesse.
A destare quest’interesse vi è anche la teoria darwiniana, secondo cui le specie si evolvono per condizioni ambientali favorevoli e attraverso la lotta per la sopravvivenza.
La selezione naturale ha dunque come basi la capacità di adattarsi alle nuove condizioni e il saper prevalere sugli altri.
Il realismo è tale non solo nella scelta dello stile e della lingua, ma anche nella scelta dei personaggi, legati principalmente ad una realtà umile o addirittura povera.
Gli scrittori raccontano dunque la realtà così come essa appare e viene vissuta, e con il suo stesso linguaggio.
Il verismo, in particolare, ha come prerogative principali:
- Un interesse per gli umili;
- Un realismo totale, che porta anche alla descrizione di ciò che è sgradevole, come lo squallido mondo dei più poveri;
- Interesse per il linguaggio utilizzato, portando così a galla, e senza filtri, un mondo fino allora sconosciuto alla letteratura.
Una delle grandi differenze tra Naturalismo francese e Verismo italiano è proprio lo scopo della letteratura: nel Naturalismo è infatti sempre presente –più o meno esplicitamente- il ruolo dello scrittore quale “medico della società”, che ne denuncia i problemi onde risalirne le cause; nel Verismo invece, il ruolo dello scrittore è quello di puro e semplice “documentatore”.
Sempre in Francia nascerà anche il “romanzo sperimentale”, fondato cioè sull’esperienza della realtà.
per ulteriori approfondimenti sul verismo vedi anche qua
Verismo e Naturalismo
Verismo: L’idea di Zola si diffuse anche in Italia con il nome di verismo,tuttavia non si può affermare che esista un verismo come scuola o movimento organizzato ciò che era stato il Romanticismo, inoltre non fa riferimento ad una concezione omogenea della letteratura e dell’intellettuale. Il verismo racchiude esperienze che sono tra di loro diverse, ad eccezione per l’interesse per figure e ambienti popolari, il colore regionale e la rappresentazione della misera, e soprattutto hanno ben poco in comune con la scuola naturalista francese.Una teoria coerente e un nuovo linguaggio furono invece elaborati da due intellettuali meridionali che operavano in ambiente milanese,dove assorbirono le istanze del naturalismo francese e di Zola e esposero le loro diverse prospettive: Verga e Capuana.
Capuana come critico letterario del “Corriere della sera” diffuse la conoscenza di Zola con la recensione delle sue opere (in particolare l’Assomoir) ma nei suoi articoli, s’intravede chiaramente un diverso modo di intendere la letteratura e in particolare sull’accezione “sperimentale” e scientifica del romanzo. La sua visione concorda perfettamente con quella di Verga che non collabora pubblicamente al dibattito letterario ma manifesta il dissenso nelle sue opere, dove sono concretati i principi delle loro teorie . Nella recensione delle opere dell’amico, ad esempio i Malavoglia nel 1881, afferma che l’elemento scientifico senza dubbio può appartiene al romanzo ma la novità dell’assimilazione all’arte del concetto scientifico sta nella forma, questa influenza si traduce nella perfetta impersonalità dell’opera. La “scientificità” non consiste nel trasformare la narrazione in un esperimento per dimostrare tesi scientifiche ma si manifesta nella tecnica e nella forma artistica che si riassume nell’impersonalità ovvero l’eclissi dell’autore che scompare dal testo.
Accanto a questo si hanno gli sperimenti di Verga che oltre a studiare i meccanismi sociali imposta una rivoluzionaria tecnica narrativa come espressione di una forte visione pessimistica e materialistica. Tuttavia , verga non avendo a disposizione un movimento culturale alle spalle, resta tutto sommato isolato. Inoltre non esercitò mai larga influenza sulla cultura contemporanea, non creò una scuola e non costituì un modello a lungo imitato come Manzoni, se non per la sua particolare tecnica narrativa svincolate dalle loro motivazioni e ridotte a pura riproduzione esteriore di una maniera. Anzi con gli anni Novanta il romanzo veristico (o realistico) che rappresenta squarci di quadri sociali viene radicalmente soppiantato dal romanzo puramente psicologico che si concentra non più sull’ambiente sociale ma direttamente sulla sola ed esclusiva psicologia dei personaggi (vedi D’annunzio).
Differenza naturalismo francese e verismo italiano:
Il positivismo rappresenta un nuovo illuminismo,razionale e logico. Nasce in Francia e crede nel progressoin ogni campo.
Nel Verismo italiano non c’è l’ idea di progresso che invece ritroviamo nel Naturalismo! Verga afferma che la situazione italiana quella è e tale rimarrà (vedi paragone formiche). Pure se nel caso un contadino, o un qualsiasi personaggio italiano provasse a modificare il suo status e magari ad elevare la propria condizione si ritroverebbe come un outcast a vestire panni che non gli vestono e se gli dovesse andar bene ritornerebbe allo stato da cui è partito. Testimonianza di ciò sono le opere di Verga come Mastro Don Gesualdo o i Malavoglia! (vedi ideale dell’ostrica)
Il naturalismo deriva dal positivismo che seguiva gli insegnamenti di Darwin: ricordiamo che La selezione della specie di Darwin negli anni del positivismo si lega al socialismo di rivendicazione e fece nascere il cosiddetto “darwinismo sociale”: noi siamo un mondo di eletti perché solo i migliori sono andati avanti, coloro che non erano in grado a vivere i questo mondo si sono estinti. In quest’ottica anche la stratificazione sociale è vista come processo evolutivo e i deboli sono il frutto della selezione naturale.
Nel positivismo nasce anche quella che oggi noi chiamiamo sociologia ossia lo studio della società! Da ciò possiamo dedurne che il Marxismo è alla base del positivismo! Iniziano i primi studi sulla società, sulla popolazione. La società è oggetto della ricerca e infatti Comte afferma che la società si può studiare con dati scientifici dai quali si possono trarre le leggi e grazie a lui che nel 900 nacque la Sociologia.
Questo concetto passa al Romanzo Sperimentale, proprio del naturalismo francese, che è un Romanzo che analizza la folla e la società in modo asettico ossia in modo oggettivo, il narratore non da delle proprie considerazioni al riguardo (l’impersonalità ovvero l’ eclissi del narratore è la caratteristica fondamentale).
Ebbene questo realismo oggettivo del romanzo sperimentale è proprio del verismo e come il verismo è una Tecnica di scrittura! Il Verismo di Verga si avvale fondamentalmente di 3 tecniche:
→lo straniamento: il lettore delle opere di Verga è catapultato dall’autore nell’opera senza la fornitura di coordinate spazio temporali. Il lettore nel caso dei Malavoglia ad esempio si ritrova all’improvviso nella piazza di Acitrezza, circondato da decine di personaggi ,di cui l’autore non ci da descrizioni ,che parlano e dalle parole di questi personaggi, che non conosce e conoscerà man mano che la storia si evolverà, dovrà ricavare autonomamente le coordinate per ambientarsi nel racconto.
Dal momento che i personaggi non sono descritti da Verga, il lettore dovrà imparare a conoscerli e modo per conoscerli è senza dubbio seguendo le voci del popolo: infatti come nel caso di Rosso Malpelo, il lettore non ha una descrizione da parte dell’autore di Malpelo, ma x voce di popolo sa che quel personaggio è cattivo e malvagio solo perché i suoi concittadini lo reputano così, e se il popolo lo reputa così allora è veramente così!
→Questa tecnica di far parlare il popolo e di non esporre il proprio pensiero su un personaggio è definita artificio della regressione.
→Un'altra tecnica importante che caratterizza il Verismo è la paratassi ossia il continuo utilizzo da parte dello scrittore di coordinate al posto di subordinate. Ciò è evidente in quanto la trama dei romanzi di Verga è caratterizzata sempre da personaggi che appartengono al ceto basso della popolazione e quindi a quello meno colto e quindi si sa che i personaggi poco colti non possono utilizzare un lessico molto complesso ricco di subordinate ma si esprimono spesso con coordinate e periodi molto brevi, spesso utilizzando dialettismi e proverbi.
→Questa tecnica della paratassi è retta dal discorso indiretto libero : “diceva che prendeva ora il treno”
L’uso dei dialettismi e del discorso indiretto libero (ciò che è in 3° persona va in 1°) saltano i deittici (tutto ciò che ci da la dimensione di spazio-tempo,modo,persone) attualizza e rende di più il parlato basso e del volgo, così come la paratassi e la regressione.
La coralità in Verga è affidata ai personaggi attraverso i quali emergono i loro pensieri. C’è una doppia coralità neo malavoglia quella degli abitanti ci Acitrezza e della famiglia.
Tramite queste tecniche verga ottiene l’impersonalita’ della scrittura. (forse un verga decadente?)
Si nota nelle sue opere il carattere che come abbiamo detto prima distingue il naturalismo francese dal verismo: Verga nega il progresso in Italia!. Gli abitanti italiani sono così perché sono sempre stati così e resteranno così! Il progresso non c’è tanto e vero che ne I malavoglia i protagonisti che tentano di innalzare il proprio status esportando lupini, la nave “provvidenza” dei malavoglia affonda e dopo ciò essi sono costretti a vivere mille peripezie mille disagi decadendo sempre di più. → non c’è sviluppo o progresso, al massimo si ritorna al punto di partenza!
Afferma Verga: “chi cerca un vita nuova e’ destinato al fallimento”.
per ulteriori approfondimenti su verismo e naturalismo vedi anche qua
Verismo e Naturalismo, confronto
Durante il 1800, il mondo cambia completamente aspetto:- in Francia ci sono le due Repubbliche (1848/1871); in Italia c’è la conclusione del Risorgimento e la proclamazione del Regno d’Italia (1861);
- la Germania si unifica;
- in Gran Bretagna vi è la seconda rivoluzione industriale, e si sviluppa il colonialismo;
- in Russia viene abolita la servitù della gleba;
- in Usa c’è la guerra di secessione tra Nord e Sud.
Le condizioni dei lavoratori sono pessime. Essi sono costretti a sopportare orari massacranti ed inaccessibili, non hanno assistenza medica, pensione, hanno case con scarse condizioni igieniche, e inoltre salari bassissimi. Nascono allora le Trade Unions, il primo tipo di sindacato, formato dalle casse di mutuo soccorso.
Una delle situazioni peggiori, però, si ha in Francia. Alla fine del XIX secolo, c’è un’enorme differenza tra le classi sociali; anche a causa del rapido ed enorme sviluppo industriale; i contadini erano costretti a vivere ai margini della società, emigravano verso le città, vendendo il loro pezzo di terreno ai latifondisti, vi era una selvaggia speculazione dell’edilizia. I borghesi, invece, si sentivano sempre più sicuri del loro prestigio, così coltivavano l’idea di avere costruito un nuovo mondo, migliore.
La borghesia, già da alcuni decenni, assecondava una nuova corrente di pensiero: il Positivismo.
Questa filosofia aveva abbracciato la teoria evoluzionistica di Charles Darwin, secondo la quale, vi era una selezione naturale, per cui gli esseri più forti erano destinati a dominare, quelli più deboli ad essere schiacciati.
La borghesia fa sua questa teoria perché, applicata alla società, faceva credere ai borghesi di essere la classe sociale destinata a comandare e ad avere il sopravvento su tutte le altre.
In letteratura, il Positivismo, si snoda in due rami: il Naturalismo francese e il Verismo italiano.
Questi due movimenti hanno diversi esponenti, nel naturalismo, ad esempio vi sono Flaubert, Victor Hugo ed Emile Zola. Proprio quest’ultimo, nel suo modo di scrivere, esprime dei princìpi, che si notano soprattutto nel suo romanzo sperimentale.
Questi princìpi sono:
- il romanzo deve basarsi innanzitutto sullo studio della natura;
- la trama deve procedere con il metodo scientifico;
- bisogna studiare tutti gli affetti e amori della persona umana;
- bisogna usare l’impersonlità.
In Italia la situazione era diversa da quella della Francia, anche se era a tratti uguale. Vi era, infatti, la borghesia, ma i problemi erano ben diversi.
Uno di questi, e forse anche il più importante, visto che da questo scaturivano gli altri, era la questione meridionale. Tanto è vero che questo problema, portò all’immigrazione e al brigantaggio.
I letterati italiani, perciò, si trovarono in una situazione differente di quella dei naturalisti francesi, e, anche per questo motivo, tra i due movimenti letterari, vi furono delle differenze. Tra cui il fatto che nel naturalismo si dava molta più importanza al sezionamento della natura nei minimi particolari (i miserabili di Victor Hugo), mentre nel Verismo i problemi erano relativi soprattutto alle classi contadine nella vita di tutti i giorni, e, inoltre, il romanzo naturalistico è di tipo psicologico, mentre quello verista, di tipo d’ambiente.
Il maggiore esponente della cultura verista è Giovanni Verga. Il suo modo di scrivere, si differenzia in due sezioni:
- la produzione giovanile, che risente ancora l’influsso della letteratura ottocentesca;
- la produzione più matura.
In questo ciclo dovevano essere compresi cinque romanzi, ma il catanese ne portò a termine solo due: I malavoglia e Mastro don Gesualdo.
Nel primo romanzo, Verga, dà ai lettori che la provvidenza non esiste, perché è quello che pensa, ed, inoltre, non crede nel progresso.
Lo scrittore avvale i suoi personaggi di una grande autenticità, ma questo, accade, anche perché, nel romanzo o anche più semplicemente nelle sue novelle, cita molte espressioni dialettali, detti popolari, proverbi, ed anche dei paragoni (piangono i soli, asciugano i fiumi).
In Mastro don Gesualdo, tutto il racconto si aggira tutto intorno ad un nucleo centrale che è il possesso della roba. Inoltre in questo racconto, si fa evidente la morale dell’ostrica.
I romanzi di Verga, non riscorsero un immediato successo, perché le persone a cui erano riferite, erano analfabete per leggerli.
Nello stesso anno in cui furono pubblicati i Malavoglia, Antonio Fogazzaro scrisse e fece stampare la Malombra, che ebbe subito un gran successo.
Verismo, Positivismo e Naturalismo
Verismo: Il verismo è un movimento letterario che nasce in Italia alla fine del 800 sotto l’influsso del positivismo e subisce l’influenza del Naturalismo francese. Il maggiore narratore verista è Giovanni Verga, ma i principi della poetica sono enunciati da Luigi Capuana. Essi sono:- La scientificità nella ricostruzione del vero attraverso l’indagine dell’ambiente sociale, dei fattori economici e storici e degli influssi ereditari.
- L’obbiettività dello scrittore, pari a quella di uno scienziato che studia la realtà sociale.
- L’impersonalità del narratore, che deve astenersi da commenti o interventi.
- Un linguaggio che riproduce le modalità espressive dei personaggi, la cui descrizione è condotta dall’esterno con attenzione alla parole, ai gesti, alla mimica e agli atti.
- Il tono pessimistico
- Il carattere regionalistico e prevalentemente meridionalistico delle vicende narrate. Tra i realisti e veristi italiani, sono da ricordare anche Grazia Deledda, Federigo Tozzi, Fogazzaro.
- il rifiuto di forme di conoscenza di carattere intuitivo, idealistico o religioso;
- il materialismo;
- l’estensione del metodo scientifico a tutti i campi del sapere;
- l’adesione alla teoria dell’evoluzione di Darwin;
- la concezione dello scienziato come eroe del progresso e della scienza come strumento per raggiungere la verità.
- il culto dei fatti e la loro analisi oggettiva;
- il narratore impersonale;
- i personaggi significativi dei vari strati sociali e le loro storie.
- lo scrittore deve essere simile ad uno scienziato che riproduce nella sua opera l’esperienza reale e vissuta;
- l’argomento deve essere la “realtà sociale";
- la pagina scritta deve riflettere la realtà, assumere l’aspetto di “ documento oggettivo “ e non lasciare mai trasparire la soggettività dell’autore.
- occorre scrivere ritraendo la vita dal vero. La pagina letteraria deve essere “un documento umano”;
- la rappresentazione della realtà non deve essere fatta dall’esterno: deve essere una ricostruzione dall’interno, identificandone i fatti secondo il loro svolgimento. La rappresentazione richiede anche l’impersonalità dello scrittore, la cui presenza nell’opera deve risultare “invisibile”;
- la lingua e lo stile devono essere inerenti ai fatti. La lingua deve essere “ espressione obbiettiva del mondo rappresentato”, deve aderire con la mentalità dei personaggi e deve comprendere forme “ dialettali”.
Hanno un esordio verista anche Gabriele d’Annunzio, Italo Svevo e Luigi Pirandello.
Positivismo: È un movimento filosofico che si basa sulla profonda fiducia nel graduale progresso dovuto alla scienza e alla tecnica, il cui sviluppo accompagna la rivoluzione industriale. È un movimento che va dal 1870 al 1914. Alle sue origini sta il pensiero del filosofo francese Auguste Comte che nel “Corso di filosofia positiva” ipotizza un’evoluzione umana culminante nello stadio scientifico o positivo. I cardini del positivismo sono:
Naturalismo: Il naturalismo è un movimento letterario influenzato dal Positivismo nato in Francia tra la metà e alla fine del 800, che fa capo a Emile Zola e i cui presupposti sono:
Verismo, Positivismo e Naturalismo, confronto
Il positivismo: Intorno alla metà dell’Ottocento, mentre viene progressivamente esaurendosi il pensiero romantico-idealista, in tutta l’Europa si afferma un nuovo orientamento culturale che investe sia il campo speculativo e sia la “ mentalità comune”. Questa ideologia prende il nome di positivismo, che proponeva la conoscenza metafisica e l’estensione del metodo scientifico in tutti i campi. Nutre di grande fiducia nella ragione, concepita come strumento di progresso, è incentrato sulla visione laica della vita, ma si differenzia dall’Illuminismo. Infatti si faceva promotrice dell’ideale rivoluzionario di una borghesia in crescita. Ma la visione dell’uomo positivo comporta la visione di uomo totale, che manifesta se stesso in una pluralità di atteggiamenti e sentimenti.Anche in campo letterario il Positivismo esercitò un’influenza,determinando l’affermazione di un movimento chiamato Realismo ( Naturalismo in Francia e Verismo in Italia). Questo movimento assunse connotazioni diverse, ma fu caratterizzato soprattutto da un interesse degli scrittori per la realtà, specialmente quella sociale.
Il naturalismo in Francia: Il Naturalismo nacque in Francia attorno alla metà dell’Ottocento, per opera di scrittori come Emile Zola, Flaubert e Maupassant. Il vero capofila dei naturalisti francesi e il maggior teorico del movimento fu, però, Emile Zola che ne fissò i principi nella teoria del Romanzo Sperimentale. Secondo Zola lo scrittore non doveva scrivere stando seduto al tavolo di lavoro, ma sarebbe dovuto uscire in mezzo alla gente, per sperimentare le situazioni e frequentare i luoghi dove avrebbe dovuto inserire i personaggi del romanzo: avrebbe dovuto studiare gli ambienti, le reazioni della gente, limitandosi poi a scrivere in piena oggettività quello che aveva appreso, proprio come uno scienziato che riferisce il suo sperimento appena terminato. Inoltre egli è convinto che lo scrittore deve individuare i moventi delle azioni umane e dovrà andarli a cercare nella dipendenza di ogni individuo dall’ambiente in cui vive. E ciò in piena adesione all’estetica, che affermava che l’opera d’arte doveva appunto mettere in evidenza i condizionamenti dell’uomo ( cioè dell’ambiente e del momento storico). Perciò l’attenzione di Zola e degli altri naturalisti è incentrata sugli aspetti meno splendenti della realtà sociale, in particolare quelli della plebe parigina, dei diseredati, tutti analizzati in stretto rapporto con l’ambiente in cui vivono.
I principi del positivismo: Possono essere così sintetizzati:
I principi del verismo: Il maggior teorico fu Capuana, conterraneo e coetaneo di Verga, che fissò i principi fondamentali del movimento in tre punti:
Domande da interrogazione
- Quali sono le caratteristiche principali del Verismo italiano?
- In che modo il Verismo si differenzia dal Naturalismo francese?
- Chi è considerato il principale esponente del Verismo e quali sono alcune delle sue opere più note?
- Qual è il ruolo del Positivismo nel contesto del Verismo?
- Quali sono le tecniche narrative utilizzate nel Verismo per ottenere l'impersonalità?
Il Verismo italiano si caratterizza per la fotografia della realtà, il pessimismo, l'impersonalità e l'uso di un linguaggio semplice e dialettale. Gli autori descrivono la realtà senza abbellimenti, esprimendo una visione pessimista della vita quotidiana e mantenendo un approccio oggettivo.
Sebbene entrambi i movimenti si basino sulla rappresentazione del vero, il Verismo si concentra sulle classi contadine del sud Italia, mentre il Naturalismo si focalizza sugli operai e le condizioni urbane. Inoltre, il Verismo non attribuisce un valore politico alla letteratura come fa il Naturalismo.
Giovanni Verga è il principale esponente del Verismo. Tra le sue opere più note vi sono "I Malavoglia" e la raccolta di novelle "Vita dei campi".
Il Positivismo, con la sua fiducia nel progresso scientifico, ha influenzato il Verismo, spingendo gli autori a osservare e descrivere la realtà in modo oggettivo e scientifico, senza interventi personali o giudizi.
Il Verismo utilizza tecniche come lo straniamento, l'artificio della regressione e la paratassi. Queste tecniche permettono di presentare la realtà attraverso la voce del popolo, senza interventi diretti dell'autore, mantenendo così l'impersonalità nella narrazione.







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo