Concetti Chiave
- Post-World War I Italy faced significant political and social turmoil, with widespread dissatisfaction over territorial gains and economic instability.
- The rise of nationalist sentiments, particularly led by figures like Gabriele D'Annunzio, highlighted Italy's desire for greater influence and territorial expansion, despite diplomatic challenges.
- Benito Mussolini's political evolution from socialism to fascism marked the emergence of a new political force, aiming to counter socialist movements and establish a new order.
- The Fascist movement, initially struggling, gained momentum through alliances with agrarian and bourgeois interests, utilizing violent squadristi tactics to suppress socialist influences.
- Mussolini's ascent to power, culminating in the March on Rome, demonstrated a strategic alignment with existing power structures, leading to the establishment of a fascist regime in Italy.
Indice
- La delusione post-bellica
- Il patto di Londra e le sue conseguenze
- D’Annunzio e l'impresa di Fiume
- L'economia italiana in crisi
- La tensione sociale e politica
- La nascita del Partito popolare italiano
- Il biennio rosso e la risposta di Giolitti
- La nascita del fascismo
- L'ascesa del fascismo
- La marcia su Roma
- L'inizio della dittatura fascista
- Le leggi fascistissime
- Il rapporto con la Chiesa e le leggi razziali
La delusione post-bellica
Il Regno d’Italia figurava tra i vincitori della Grande Guerra, ma i frutti ottenuti da quella vittoria apparivano a tutti straordinariamente scarsi e deludenti.
Gli interventisti chiedevano a gran voce che l’elevatissimo prezzo pagato per la vittoria fosse compensato con generose concessioni territoriali, capaci di dare all’Italia tutto il prestigio e la dignità che si era meritata sul campo di battaglia. Al contrario, coloro che nel 1915 si erano battuti perchè l’Italia restasse neutrale, gridavano ancora più forte, sostenendo che nessun ampliamento territoriale avrebbe mai giustificato la terribile strage degli anni di guerra, arrivando anche a insultare gli interventisti.
Il governo italiano alimentò la tensione, tenendo un comportamento rigido e per molti versi ambiguo e irresponsabile.
Il patto di Londra e le sue conseguenze
Con il Patto di Londra, il 26 aprile 1915, il governo del regno si era impegnato a entrare in guerra con Francia e Gran Bretagna contro l’Austria-Ungheria, ma nessuno aveva messo in conto che una sconfitta austriaca avrebbe provocato la totale disgregazione dell’impero asburgico.
Durante la seconda e terza guerra d'indipendenza, l'Austria aveva perso prima la Lombardia e poi il Veneto. Si diceva, dopo la Grande Guerra, che altre regioni dominate fino ad allora dall’impero di Vienna sarebbero passate sotto amministrazione e controllo italiani.
Per questo motivo l’Italia, nel patto di Londra, non si era limitata a rivendicare Trento e Triste, bensì aveva chiesto per sé, in caso di vittoria, anche la Dalmazia, sebbene fosse abitata prevalentemente da slavi. Il governo inglese e quello francese non avevano sollevato alcuna seria obiezione al riguardo; viceversa, il patto di Londra non menzionava esplicitamente il porto di Fiume.
Nel dopoguerra, le prime difficoltà per il governo italiano sopraggiunsero nell’ottobre del 1918: la città di Fiume dichiarò la sua volontà di essere annessa al regno d’Italia.
La delegazione italiana tenne un atteggiamento arrogante e ambiguo, in quanto rivendicava sia Fiume, sia la Dalmazia. Di fronte alla netta opposizione degli alleati, il 24 aprile 1919 la delegazione italiana abbandonò Parigi in segno di protesta.
L’Italia, da tale operazione di divisione delle prede di guerra non ottenne praticamente nulla.
D’Annunzio e l'impresa di Fiume
D’Annunzio a Fiume: la festa della rivoluzione
Secondo Gabriele D’Annunzio, l’Italia aveva ottenuto una vittoria mutilata. In altre parole, il grande trionfo della patria non le avrebbe portato alcun profitto reale in termini di allargamento territoriale e di rafforzamento di prestigio.
Il 13 settembre 1919, D’Annunzio, convinto di essere una specie di profeta chiamato dal destino a difendere la gloria della nazione, si rivolse ad alcuni reparti dell’esercito: e questi, scavalcando il governo italiano, che ancora non aveva deciso nulla, si impadronirono militarmente di Fiume.
L’impresa di Fiume nacque all’insegna del nazionalismo e del desiderio di mettere le altre potenze di fronte a un fatto compiuto.
All’inizio del XX secolo, numerosi intellettuali avevano assunto un atteggiamento polemico e sprezzante nei confronti della società borghese, le cui regole soffocavano il pieno dispiegamento delle energie vitali dell’individuo. Molti di questi artisti e scrittori si ispiravano alle idee del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, che aveva lanciato il concetto di superuomo: esso si trasformò nell’appello a vivere intensamente l’esistenza e a danzarla con leggerezza (superando e ignorando tutti gli schemi borghesi), cioè a rifiutare tutti i valori che la tradizione e le autorità consideravano sacri ed eterni.
Dall’esperienza fiumana, Mussolini trasse un’eccezionale lezione, in quanto apprese che un leader veramente moderno deve imparare a relazionarmi con grandi masse di persone e a scaldare il loro animo: solo un leader dotato di grande carisma, capace di affasciare le folle, avrebbe potuto guidarle e concretizzare il proprio progetto politico, convincendole che, in realtà, stava realizzando i più autentici e profondi desideri di un intero popolo.
L'economia italiana in crisi
La difficile situazione dell’economia italiana
In tempi di guerra molti industriali si erano arricchiti grazie al materiale bellico venduto all’esercito. Ma lo stato, al contrario, sotto il profilo finanziario era di nuovo sprofondato in un abisso con un aumento delle spese e del debito pubblico, anche per le ingenti somme di denaro che i cittadini avevano prestato allo stato durante la guerra e che ora andavano restituite.
La prima conseguenza di tale situazione fu una pesante svalutazione della lira, che perse valore nei confronti delle altre valute. Ciò significò un pesante rincaro di tutti i generi che l’Italia doveva importare dall’estero: carbone, petrolio e perfino grano, visto che la mobilitazione generale aveva portato al fronte soprattutto i contadini.
Per frenare il malcontento popolare, il prezzo del pane era a tenuto artificialmente basso dallo stato, ma il contributo che esso versava a tal fine non faceva che approfondire il baratro della finanza pubblica. Il paese, dunque, era in preda all’inflazione, che divorava i redditi fissi, le rendite e i salari.
La tensione sociale e politica
Di fronte a questa situazione, le varie categorie sociali reagirono in modi diversi. Meglio organizzati dai propri sindacati, e maggiormente disposti alla lotta nei confronti della controparte, il proletariato urbano o rurale riuscì a ottenere che i salari venissero progressivamente adeguati al costo della vita. Nel caso dei ceti medi, stipendi e risparmi furono in genere rovinati dalla perdita del potere d’acquisto della lira.
A un numero sempre crescente di operai, tuttavia, l’obiettivo degli alti salari, tenacemente perseguito dal sindacato, non bastava più: fra di essi serpeggiava la voglia di procedere a un radicale mutamento della situazione sociale, mediante una vera rivoluzione socialista. Le fabbriche erano in fermento, ma lo erano ancora di più le campagne, dove i contadini procedettero spesso all’occupazione delle terre.
La difficile situazione economica e sociale riaprì le polemiche tra neutralisti e interventisti. I primi affermavano che la guerra era stata solo un inutile macello e che aveva portato il paese sull’orlo del collasso. Sul versante opposto, militari, ex combattenti e nazionalisti accusavano i sovversivi di non aver compreso l’importanza della prova sostenuta dalla patria e di volere una rivoluzione bolscevica.
In un contesto così teso e lacerato, il Presidente del consiglio Francesco Saverio Nitti era convinto che in Italia stesse per esplodere la rivoluzione comunista. Pertanto, il 14 giugno 1919 Nitti emanò una circolare telegrafica in cui invitava i prefetti a “tenersi in contatto con coloro che hanno maggiore seguito e fiducia nei partiti liberali”.
Secondo il principale esponente del governo, se la rivoluzione fosse scoppiata, lo stato non sarebbe stato in grado di fermarla con il solo sostegno dell’esercito e della polizia. L’eventuale uso della forza da parte di soggetti nazionale, contro i sovversivi rossi, era viceversa da considerare non un pericoloso sconfinamento in un campo (il cosiddetto monopolio della violenza legale) di competenza esclusiva dello stato, bensì un importante contributo alla salvezza dell’ordine sociale e delle istituzioni.
In settembre, il governo Nitti concesse un’amnistia ai disertori. Agli occhi di molti ufficiali e dei nazionalisti, lo stato liberale era del tutto inadatto a fronteggiare l’emergenza, per non dire condannato a essere travolto dalla rivoluzione imminente.
La paura di una rivoluzione era alimentata dalle dimensioni imponenti del Partito socialista italiano, che nel 1920 arrivò a conquistare più di 200 mila iscritti. Dal Congresso bolognese dell’ottobre 1919, uscì vincitrice la corrente massimalista che, approvò per acclamazione la proposta di aderire alla nuova Internazionale.
La situazione interna del partito era complessa e tormentata. I sogni rivoluzionari non erano condivisi da ampi settori del movimento operaio italiano. Il sindacato (CGdL) era più preoccupato di conquistare migliori salari e condizioni di lavoro che di preparare l’insurrezione decisiva.
Quanto al partito, la maggior parte dei deputati, guidati da Filippo Turati, aveva assunto una posizione riformista, cioè moderata, tutt’altro che favorevole ad avventure insurrezionali, dittature e a bruschi cambiamenti di regime politico o sociale.
Alla sinistra estrema del partito, nel corso del 1919 cominciò a delinearsi una corrente più determinata e decisa ad andare fino in fondo, imitando l’esempio leninista. Tra questi radicali desiderosi d’azione, si distinse in primo piano Amadeo Bordiga, che accusava il partito socialista di aver perduto qualsiasi volontà rivoluzionaria. A suo giudizio, occorreva dar vita a un disciplinato partito simile a quello bolscevico e prepararsi a un’insurrezione armata finalizzata alla conquista del potere statale.
Per Gramsci (come per tutti i socialisti) era evidente che la rivoluzione russa si era svolta secondo modalità completamente differenti rispetto a quelle previste da Marx nella sua opera più importante.
Rispetto alla concezione di Bordiga, in Gramsci c’era una maggior volontà di trasformare le masse in soggetto attivo; nella visione di Bordiga l’unico vero protagonista dell’azione rivoluzionaria era il partito.
La nascita del Partito popolare italiano
Nel 1919, per ostacolare la crescente importanza dei socialisti, il quadro politico italiano si arricchì di alcuni nuovi soggetti. La nascita del Partito popolare italiano segnò il rientro a pieno titolo dei cattolici nella dialettica elettorale e parlamentare nazionale. Si chiedeva da molto tempo una riforma elettorale che sostituisse il sistema uninominale con un sistema proporzionale, meglio capace di costruire un parlamento autenticamente rappresentativo della volontà popolare. Con un simile sistema, in un regime a suffragio universale maschile, come quello che Giolitti aveva introdotto nel 1912, si rischiava che i socialisti ottenessero tanti deputati, sia nelle campagne sia nelle città.
Per scongiurare un simile pericolo, i cattolici furono autorizzati dalla Chiesa a costituire un loro partito politico; il leader della nuova formazione politica, don Luigi Sturzo, non voleva affatto rivolgersi solo ai cattolici, ma a tutti gli italiani che si riconoscessero negli ideali e negli obiettivi del partito.
Il PPI si proponeva come partito aconfessionale (vale a dire che il programma del PPI poteva essere sostenuto anche da persone non cattoliche) e interclassista (cioè appartenenti a classi sociali differenti); sinceramente rispettoso dell’ordinamento parlamentare, chiedeva però che lo stato non diventasse mai il puro strumenti di dominio di una classe sulle altre, bensì fosse una sorta di motore che promuovesse il bene comune, cioè l’ordine to e dignitoso sviluppo della società civile in tutte le sue componenti.
Il biennio rosso e la risposta di Giolitti
Con il passare dei mesi, la tensione sociale non si ridusse minimamente e raggiunse il suo massimo livello sia nelle campagne sia nelle industrie, al punto che gli anni 1919-1920 vengono spesso denominati il biennio rosso.
Nel giugno del 1920 era diventato Presidente del consiglio Giovanni Giolitti che seguì, anche nella circostanza degli scioperi contadini e dell’occupazione delle fabbriche, la medesima linea adottata nel lungo periodo in cui era stato a guida del governo prima della guerra, tra il 1901 e il 1912. A suo parere, quando uno sciopero o una vertenza sindacale non avevano vera finalità rivoluzionaria, ma erano contrasti di carattere puramente economico, diretti a ottenere miglioramenti salariali, lo Stato doveva restare neutrale; se il governo fosse intervenuto con la forza, e l’esercito avesse provocato delle vittime tra i lavoratori, la rabbia di questi ultimi sarebbe stata inutilmente aggravata. Occorreva che il moto si sbollisse da sé, cioè si esaurisse per mancanza di sbocchi concreti e di prospettive.
In effetti, dopo quale tempo, anche in quel caso il PSI dichiarò apertamente che l’occupazione delle fabbriche non aveva risvolti politici e che si trattava solo di una forma particolarmente drastica di protesta sindacale: non era assolutamente da considerare come il prologo della rivoluzione sociale.
Il 12 novembre, Giolitti risolse la spinosa questione di Fiume; in base a un accordo con la Iugoslavia (trattato di Rapallo), l’Italia poté almeno annettersi l’Istria, mentre Fiume fu dichiarata città libera.
Nel dicembre, dal momento che D’Annunzio non si decideva ad abbandonare la città, Giolitti ordinò al generale Caviglia di attaccare militarmente la città. Nell’attacco contro Fiume furono utilizzati reparti di carabinieri e polizia ritenuti più fedeli e affidabili di quelli di fanteria. Gli ufficiali dell’esercito regolare, al momento dell’assalto, non obbedirono agli ordini o lo fecero in modo parziale, così da sabotare l’offensiva contro D’Annunzio.
Nel 1921, Giolitti affrontò la grave situazione finanziaria, abolendo il prezzo politico del pane; inoltre fu stabilita la nominatività dei titoli azionari e venne aumentata la tassa di successione. Quest’azione di risanamento della finanza pubblica provocò la netta ostilità degli imprenditori, degli agrari e anche di molti deputati liberali. Nel luglio 1921, consapevole della debolezza della sua posizione, Giolitti diede le dimissioni.
Nell’estate 1920, Lenin e gli altri dirigenti bolscevichi posero i partiti socialisti d’Europa di fronte a una secca e netta alternativa. A quelle organizzazioni che volevano aderire alla nuova Internazionale comunista gli artefici della vittoriosa rivoluzione sovietica posero 21 condizioni, da accettare in blocco, senza possibilità di negoziare o modificare nulla.
Tra queste richieste ultimative furono due quelle che lasciarono più perplessi Serrati e gli altri socialisti italiani: l’assoluta necessità di cambiare il nome del partito, da socialista in comunista, e l’espulsione dei riformisti.
Quanto ai riformisti, Serrati li difese, anche se non ne condivideva le posizioni politiche, perché si erano sempre mostrati leali verso il proletariato e verso il partito e soprattutto perché non avevano avuto esitazioni nel condannare l’intervento italiano, al momento dello scoppio della guerra mondiale; mentre i dirigenti francesi o tedeschi avevano appoggiato i loro governi, provocando la crisi dell’Internazionale socialista.
La resa dei conti definitiva si ebbe nel 1921, al congresso di Livorno. Poichè la maggioranza dei delegati presenti a Livorno propose di continuare le negoziazioni con i bolscevichi, per trovare un compromesso, coloro che appoggiavano la mozione di Imola abbandonarono la sala del teatro Goldoni di Livorno e si riunirono nel teatro San Marco, dove proclamarono formalmente la nascita del Partito Comunista d’Italia.
La nascita del fascismo
Nel 1919 aveva fatto la propria comparsa sulla scena il movimento fascista, una forza politica di segno diametralmente opposto rispetto ai bolscevichi e determinato a sbarrare loro la strada della rivoluzione con qualsiasi metodo.
L’identità del fascismo rispecchiava il complicato percorso intellettuale e politico del suo fondatore, Benito Mussolini, che aveva iniziato la sua esperienza politica nel Partito socialista.
All’interno del PSI, Mussolini fece una rapida e brillante carriera, diventando, nel 1912 direttore dell’Avanti!, il quotidiano ufficiale del partito. In questo periodo, Mussolini fu il leader indiscusso della corrente più radicale del movimento socialista, quella secondo cui fra i capitalisti e il proletariato non doveva esserci altro che guerra aperta, fino alla rivoluzione finale. Anzi Mussolini riteneva che i lavoratori dovessero sempre mantenersi pronti per quell’evento decisivo.
Fu Mussolini il vero animatore della cosiddetta settimana rossa, una grande ondata di scioperi ma che si concluse senza alcun risultato concreto.
Scoppiata la guerra mondiale, il PSI si schierò per il non-intervento dell'Italia. Mussolini, invece, scelse il campo dell'interventismo, perché aveva intuito che la guerra avrebbe logorato le economie e le istituzioni politiche di tutti i paesi coinvolti: avrebbe reso più agevoli le condizioni per una rivoluzione proletaria.
Espulso dal Partito socialista, Mussolini tentò di elaborare una linea politica propria, diversa e alternativa rispetto a quella percorsa fino ad allora. Innanzi tutto, la scelta di appoggiare l'intervento lo riconciliò con l'idea di nazione e di patria. In secondo luogo, l'andamento del conflitto e la tragica esperienza di Caporetto lo portarono alla conclusione che la lotta di classe l'avrebbe irrimediabilmente corrosa e disintegrata. Infine, lo scoppio della rivoluzione bolscevica in Russia, sfociata nella guerra civile, nel terrore e nella miseria generalizzata, lo spinse ad abbandonare definitivamente l'idea di un radicale rovesciamento dell'ordine sociale e a valorizzare il ruolo della borghesia imprenditoriale nello sviluppo economico di un paese.
Il movimento dei Fasci italiani di combattimento nacque ufficialmente il 23 marzo 1919; in tale giornata Mussolini convocò una riunione finalizzata a fondare una nuova formazione capace di porsi in alternativa sia allo stato liberale sia ai progetti rivoluzionari dei socialisti di matrice marxista. Il programma ufficiale del movimento fu pubblicato sul Popolo d’Italia,
La linea politica appare ancora decisamente spostata a sinistra, piena di rivendicazioni sociali quanto mai audaci. Il programma insisteva sulla necessità di una politica estera.
Nei mesi seguenti, Mussolini tentò di approfondire e precisare l’intreccio di rivendicazioni da sinistra e di concetti tipici della destra nazionalista. A tal fine, uscì una rivista settimanale, intitolata Il Fascio, su cui venivano pubblicati articoli di carattere programmatico per lanciare e sostenere quella che venne chiamata la “rivoluzione italiana”.
I Fasci attrassero militanti di vario tipo. Tra i primi che aderirono il movimento furono alcuni artisti futuristi, intellettuali che alcuni anni prima avevano celebrato la guerra come “sola igiene del mondo”, al loro fianco si schierarono numerosi arditi, soldati che avevano vissuto l’esperienza della guerra in uno speciale corpo d’assalto e che si erano resi celebri per il loro amore del rischio e del pericolo. Il progetto di Mussolini attrasse anche molte figure che provenivano dalla sinistra più estrema, cioè dal cosiddetto sindacalismo rivoluzionario.
All’inizio del 1920 il movimento attraversò un momento di crisi radicale e profonda; alle elezioni del novembre del 1919 (le prime con il nuovo sistema proporzionale) esso aveva raccolto pochissimi consensi.
La disfatta elettorale era il segnale evidente del fatto che lo strano miscuglio di socialismo e nazionalismo proposto dai Fasci non aveva in alcun modo colpito e conquistato le masse, le quali avevano preferito votare il il PSI o per il PPI.
L'ascesa del fascismo
La svolta si verificò nella seconda metà del 1920, in concomitanza con l’aumento dell’offensiva socialista (scioperi nelle campagne e occupazione delle fabbriche nelle grandi città). Alcune azioni clamorose divennero il simbolo del nuovo volto che il movimento fascista andò gradualmente assumendo. Il 13 luglio, a Trieste, venne incendiato l’hotel Balkan, sede delle associazioni che, all’interno della città, rappresentavano la minoranza slava.
Il 21 novembre 1920, circa 300 fascisti presero d’assalto il municipio di Bologna, per impedire l’insegnamento della nuova giunta comunale rossa (legalmente votata comunista). A seguito di questi fatti, il candidato a sindaco socialista, vincitore delle elezioni amministrative, e la nuova giunta rinunciarono all’insediamento: a loro subentrò un commissario prefettizio; i fascisti avevano raggiunto il loro obiettivo.
Nel primo semestre del 1921, finanziato e armato dai grandi agrari, il fascismo cominciò a organizzarsi in squadre d’azione. Esse si assunsero il compito di procedere allo smantellamento di tutta l’organizzazione politica e sindacale di matrice socialista, bruciando le Case del popolo, distruggendo le tipografie dei giornali e le sedi di riunione, uccidendo i dirigenti più determinati e obbligando intere giunte municipali rosse alle dimissioni.
A partire dalla fine del 1920, il fascismo si alleò apertamente con la borghesia, in funzione antisocialista. I rapporti più stretti si instaurarono in regioni a economia prevalentemente agricola (Val Padana e le Puglie, ove gli agrari erano stati pesantemente colpiti nei loro interessi dalle lotte contadine del biennio rosso 1919-1920 e dove, di conseguenza, covava maggiormente il desiderio di rivincita e di rivalsa.
Per la maggioranza, gli elementi che componevano le squadre d’azione erano giovani, spesso minorenni e qualche volta adolescenti. Tutti vissero lo squadrismo come un’esperienza affascinante, come un’avventura che permetteva loro di uscire dai canoni della rigida educazione ricevuta fino a quel momento. Quasi tutti i capi dello squadrismo erano ex-combattenti, desiderosi anch’essi di una rivalsa, ora che il movimento fascista si era definitivamente convertito al nazionalismo e aveva individuato nel socialismo il nemico mortale della nazione, si schierarono di buon grado a fianco della borghesia agraria, contro il comune nemico rosso.
La marcia su Roma
Durante le aggressioni messe in atto dalle squadre fasciste, prettamente belliche, le forze dell’ordine non intervennero per difendere le vittime: socialisti e sindacalisti erano solo dei pericolosi sovversivi che finalmente ricevevano la giusta lezione.
Lo squadrismo era sostanzialmente acefalo, in quanto il movimento fascista delle origini era privo di una rigida organizzazione e di una vera struttura gerarchica. Questa realtà emerse con estrema chiarezza in occasione del patto di pacificazione. Firmando quel documento, Mussolini impegnava il movimento fascista a cessare le azioni squadristiche. Tuttavia, i capi delle principali squadre d’azione (ras) sconfessarono l’accordo, negando addirittura che Mussolini avesse l’autorità per stipularlo.
Nel novembre 1921, il movimento dei Fasci si riorganizzò in Partito nazionale fascista (PNF). Mentre il movimento del 1919 si dichiarava apertamente repubblicano, il partito del 1921 non mise più in discussione la monarchia.
Nel corso del 1922, Mussolini ottenne la fiducia di un numero sempre crescente di alti esponenti dello stato, dell’esercito e del mondo economico. A tutti costoro, il fascismo parve una sorta di cura capace di riportare all’ordine le classi lavoratrici, i loro sindacati e i loro partiti; nessuno pensava che Mussolini e i fascisti potessero arrivare a una dittatura. Quando ci furono le elezioni politiche del 1921, Giolitti formò il cosiddetto Blocco nazionale, una lista di liberali e nazionalisti in cui inserì anche esponenti fascisti.
Mentre i socialisti, sempre più divisi, mostravano la loro debolezza, alla fine dell’ottobre 1922, fu inscenata dal fascismo la cosiddetta marcia su Roma: un numero ingente di squadristi si radunò alle porte della capitale punto ad occupare i punti nevralgici da cui si comanda un paese. C’era però un rischio: se lo stato avesse risposto con le armi, il fascismo sarebbe stato definitivamente spazzato via.
L'inizio della dittatura fascista
Il 29 ottobre 1922, Vittorio Emanuele III prese la sua decisione: mentre si rifiutò di firmare il decreto che, instaurando lo stato d’assedio, avrebbe permesso all’esercito di disperdere le squadre, il re conferì a Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo. Il fascismo, dunque, non conquistò il potere con un colpo di stato paragonabile all’assalto al Palazzo d’Inverno condotto dai bolscevichi nel novembre 1917.
Salito al potere con la complicità della monarchia e di gran parte della tradizionale classe dirigente, nei primi due anni del suo governo Mussolini procedette con una certa cautela.
Mussolini si affrettò ad abolire i due provvedimenti più antiborghesi fra quelli presi da Giolitti: l’innalzamento della tassa di successione e la nominatività dei titoli azionari.
Mussolini volle presentare il fascismo come l’unica forza capace di difendere l’onore della patria.
Il leader del fascismo si sforzò di presentare il suo movimento come la parte più sana della nazione. Secondo il suo concetto, chi era contro il fascismo era automaticamente contro l’Italia.
Fin dal 1923, alcuni osservatori antifascisti, come Giovanni Amendola e Luigi Sturzo, coniarono un nuovo aggettivo, per definire l’atteggiamento del fascismo. Essi lo definirono totalitario, al fine di precisare che il movimento di Mussolini aspirava a un controllo completo dello stato.
La svolta decisiva si ebbe nel 1924, dopo che Mussolini aveva ottenuto una revisione della legge elettorale; secondo la nuova normativa (denominata Legge Acerbo), alla lista che avesse ottenuto il 25% dei voti complessivi sarebbero stati assegnati i due terzi dei seggi, mentre il restante terzo sarebbe stato distribuito alle altre liste, su basi proporzionali.
Per ottenere la maggioranza alle elezioni, le squadre fasciste ricorsero in diversi collegi ai brogli e alla violenza. Mussolini e i suoi seguaci erano convinti che nessuno avrebbe protestato e che tutti avrebbero accettato il controllo dello stato da parte del fascismo.
All’apertura della nuova Camera, tuttavia, il deputato socialista Giacomo Matteotti osò denunciare apertamente tutte le irregolarità. Decisi a conservare il potere, i fascisti di una squadra speciale denominata Ceka, rapirono e uccisero Matteotti il 10 giugno. Tutta l’opposizione, per protesta, abbandonò la Camera, dando vita a quella che fu chiamata la secessione dell’Aventino. Gli avversari del fascismo speravano che, di fronte a un fatto simile, il re avrebbe obbligato Mussolini a dare le dimissioni.
Vittorio Emanuele III non si decideva ad intervenire, con il risultato che Mussolini riuscì a superare la crisi più grave della sua esperienza politica. Persino l’Associazione nazionale combattenti prese le distanze dal governo. Un conservatore come Salandra, alla Camera, e senatori fino ad allora tolleranti verso il fascismo chiesero le dimissioni del Presidente del Consiglio; al Senato, il conte Sforza accusò Mussolini di essere “colpevole come non mai, o incompetente come mai nessuno potè essere”.
Alla fine della vicenda, Mussolini potè assumersi la responsabilità del delitto Matteotti e di tutti gli altri crimini compiuti fino ad allora dal fascismo. La dittatura, di fatto, era iniziata.
Le leggi fascistissime
Uno dopo l'altro, a partire dal 1925, tutti gli elementi più tipici e caratteristici dello stato liberale furono eliminati. In primo luogo, ricordiamo la progressiva abolizione della libertà di stampa, realizzata attraverso la soppressione dei giornali antifascisti e il controllo di tutti i quotidiani più prestigiosi. In seguito, nel dicembre del 1925, si procedette alla liquidazione della separazione dei poteri che, secondo la concezione liberale, è il principale strumento capace di limitare il potere dello stato.
Con l'approvazione della Legge sulle prerogative del Capo del Governo, il Parlamento cessò di esercitare qualsiasi potere effettivo, in quanto nessun argomento poteva essere discusso da una delle due Camere senza la previa autorizzazione dell'esecutivo. Il Capo del Governo non era più responsabile davanti alle Camere e poteva essere revocato dal suo incarico solamente da parte del re.
Il rapporto con la Chiesa e le leggi razziali
In aggiunta alla monarchia, il Duce dovette rapportarsi con un'altra istituzione concorrente ed ineliminabile, la Chiesa cattolica. Per guadagnarne l'appoggio, Mussolini attenuò il proprio originario anticlericalismo e infine portò il Regno d'Italia a stipulare con la Santa Sede i cosiddetti accordi del Laterano (i Patti Lateranensi), che sancirono la nascita dello stato della Città del Vaticano e proclamarono il cattolicesimo religione ufficiale dello stato.
Il processo di totale cancellazione delle libertà personali ebbe sanzione formale con l'approvazione delle cosiddette leggi fascistissime, nel novembre del 1926. Innanzi tutto, fu vietato promuovere e costituire associazioni dirette a sovvertire gli ordinamenti dello stato e, più in generale, «a distruggere o deprimere il sentimento nazionale». A eccezione del PNF, tutti i partiti vennero automaticamente soppressi, mentre i 123 deputati di opposizione che parteciparono all'Aventino furono dichiarati decaduti. Per i reati più gravi, fu reintrodotta la pena di morte.
Chiunque fosse accusato di nutrire sentimenti antifascisti, era obbligato a risiedere per cinque anni in zone remote e scarsamente collegate.
con il resto del paese. A volte, la propaganda fascista cercò di minimizzare le condizioni di vita dei prigionieri obbligati al confino, dipingendolo come una specie di villeggiatura; ulteriori provvedimenti restrittivi proibirono lo sciopero, considerato un reato, e sostituirono la figura del sindaco (eletto democraticamente dai cittadini) con quella del podestà, designato direttamente dal governo.
La meta ultima del fascismo era il consenso, o meglio la piena adesione del cittadino al regime, la completa e sincera accettazione degli ideali e degli obiettivi fascisti. Per raggiungere questi scopi, si cercò di dare il massimo sviluppo possibile alle organizzazioni educative fasciste e di predisporre sempre più imponenti raduni di massa.
Mussolini dovette affrontare il problema del rapporto con il Partito fascista. Il fatto stesso che Mussolini abbia affidato la segreteria del partito a Roberto Farinacci, uno dei ras più estremisti e violenti dello squadrismo, sta a indicare che la sua posizione politica era, in un primo tempo, tutt'altro che solida.
Farinacci avrebbe voluto essere una figura di spicco all'interno del nuovo regime, sognando una sorta di diarchia tra governo e partito, o meglio tra Capo del Governo e
segretario del Partito nazionale fascista. Non appena Mussolini ebbe ulteriormente
rafforzato il suo potere, Farinacci fu costretto alle dimissioni e sostituito da Augusto Turati che procedette a una radicale epurazione all'interno del PNF.
All'interno del partito, venne poi abolita ogni forma di democrazia, sicché il Congresso del 1925 fu l'ultimo della storia del PNF. Il nuovo statuto dell'8 ottobre 1926 cancellò completamente il principio dell'elettività delle cariche, sicché i federali, da allora in avanti, vennero scelti solo da Mussolini tra uomini di sua assoluta fiducia.
L'idea di nazionalismo necessitava di un secondo esempio a cui paragonarsi.
Se un popolo è superiore, implicitamente deve esserci qualcuno di inferiore, per questo iniziano ad individuarsi delle minoranze: si manifesta ad esempio nei confronti degli ebrei.
L'obiettivo ultimo del regime era quello di trasformare l'Italia in una grande potenza; il mito (capace di suscitare l'entusiasmo e di mobilitare il popolo) assunto dal fascismo fu quello di Roma: l'Italia, in sintesi, avrebbe dovuto tornare alla potenza e alla posizione di egemonia che aveva posseduto nell'antichità. Per questo furono adottati i simboli romani (saluto).
Un modo per valorizzare la grandezza e potenza dell'Italia fu la politica coloniale, tanto che Mussolini fece leva sull'idea di una rivalsa per gli italiani, che erano stati sconfitti durante il governo Giolitti.
Nel 1935-1936 venne conquistata l'Etiopia e Vittorio Emanuele IIl fu proclamato imperatore.
Le truppe italiane varcarono il fiume Mareb che segnava il confine tra Eritrea (colonia italiana) e l'impero etiopico. L'attacco non fu preceduto da una formale dichiarazione di guerra. Questa scelta non fu dettata da motivazioni strategiche, ma fu un deliberato gesto di disprezzo.
Mussolini voleva mettere in evidenza che l'Etiopia non era uno stato sovrano, ma un territorio selvaggio, per il quale non valevano le regole del diritto internazionale.
Durante l'offensiva, l'esercito italiano fu sostenuto da una forte aviazione e fece largo uso di gas, che era già stato utilizzato in Libia contro i ribelli che si opponevano alla dominazione coloniale italiana. L'utilizzo di gas tossici fu però una violazione delle norme del diritto internazionale.
La resistenza fu inaspettata per gli italiani. Due giovani studenti eritrei lanciarono otto bombe a mano contro il generale Rodolfo Graziani e altre autorità italiane, radunate per una cerimonia ufficiale.
L'azione durò per tre giorni e furono assassinati moltissimi etiopici.
Nei mesi seguenti la vittoria contro l’Etiopia, il primo problema che si pose il regime fu quello di regolamentare le relazioni tra il popolo conquistatore e i nuovi sudditi dell'impero appena costituito. Ben presto, il regime fascista decise per una politica di netta separazione tra i due soggetti.
Ben al di là della sfera dei rapporti sessuali, era considerato reato il fatto che un italiano lavorasse per un indigeno, o frequentasse un locale riservato ai neri. Infine i meticci, cui veniva negata la piena cittadinanza e che anzi erano equiparati agli indigeni.
Domande da interrogazione
- Quali furono le delusioni dell'Italia dopo la vittoria nella Grande Guerra?
- Come reagì il governo italiano alla difficile situazione economica e sociale del dopoguerra?
- Quali furono le cause della divisione del movimento socialista italiano?
- Come si sviluppò il movimento fascista sotto la guida di Benito Mussolini?
- Quali furono le conseguenze della marcia su Roma nel 1922?
Nonostante fosse tra i vincitori, l'Italia ottenne risultati territoriali deludenti, con tensioni tra interventisti e neutralisti e un governo percepito come rigido e ambiguo.
Il governo, guidato da Nitti, temeva una rivoluzione comunista e cercò di mantenere l'ordine sociale, concedendo un'amnistia ai disertori e cercando il supporto dei partiti liberali.
La divisione fu causata da divergenze tra massimalisti e riformisti, con una corrente più radicale guidata da Bordiga che voleva seguire l'esempio leninista.
Mussolini fondò i Fasci di combattimento nel 1919, cercando di unire rivendicazioni sociali e nazionalismo, ma inizialmente il movimento ebbe scarso successo elettorale.
La marcia su Roma portò Mussolini al potere con il supporto della monarchia e della classe dirigente, segnando l'inizio del regime fascista in Italia.

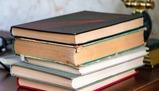





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo