Concetti Chiave
- Hegel seeks to resolve unresolved dualisms in Kantian philosophy, emphasizing the unity of reason and reality, where what is rational is real and vice versa.
- The dialectical process in Hegel’s philosophy consists of three stages: thesis (pure thought), antithesis (negation and objectification), and synthesis (unity of thought and manifestation).
- "Phenomenology of Spirit" illustrates the progression of consciousness to self-awareness, emphasizing the dialectical identity between subject and object, leading to absolute knowledge.
- Hegel critiques Kant, Fichte, and Schelling, proposing that the absolute is not a static entity but a dynamic, living process marked by the dialectical movement.
- For Hegel, the state represents the ultimate realization of ethical spirit, where individual freedom is actualized within the framework of laws, morality, and political institutions.
Indice
- Il significato della filosofia kantiana
- La filosofia come scienza dell'assoluto
- La dialettica e il progresso storico
- Critica alle filosofie di Kant e Fichte
- La concezione dell'assoluto di Schelling
- I tre momenti della dialettica hegeliana
- La fenomenologia dello spirito
- Il percorso della coscienza
- L'autocoscienza e il riconoscimento
- La dialettica servo-padrone
- La coscienza infelice e la ragione
- La ragione e il sapere assoluto
- Lo spirito e la storia
- La religione e la filosofia
- Il rapporto tra filosofia e scienze
- Il sistema hegeliano delle scienze
- La filosofia dello spirito soggettivo
- La filosofia dello spirito oggettivo
- Il diritto astratto e la moralità
- La moralità e l'eticità
- La famiglia e la società civile
- La società civile e lo stato
- Lo stato e la volontà universale
- Il diritto statale e la guerra
Il significato della filosofia kantiana
Hegel dichiara di voler cogliere il vero significato della filosofia kantiana: esso sta nella “rivoluzione copernicana”, cioè nell’idea che il mondo è costituito nella sua fondamentale ossatura dalle forme a priori e dalle categorie e (in campo morale) nella forte enfasi posta sulla libertà umana. Hegel pensa tuttavia che sia necessario liberare la filosofia critica dagli irrisolti dualismi, come il permanere di una cosa in sé che rende inaccessibile l’attività unificatrice dell’Io, il contrasto tra necessità che governa la natura e libertà ovvero il postulato della ragion pratica. Tali opposizioni generano sfiducia nella ragione e la distolgono dal compito di conoscere il reale nella sua totalità. Secondo Hegel infatti la trama del reale è essa stessa razionale, dunque tra realtà oggettiva e ragione del soggetto c’è una sostanziale identità (affinità): ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale. La ragione stessa, chiamata anche “spirito” o “idea”, si dispiega nella realtà manifestandosi nella natura; rappresenta dunque il principio unitario dal quale tutto si genera e si fonda chiamata “assoluto”.
La filosofia come scienza dell'assoluto
Il compito di comprendere unitariamente la natura spetta alla filosofia, considerata scienza in quanto sapere dell’assoluto. Nella filosofia è compresa la totalità del reale: la cosa pensante (res cogitans) e la realtà con le sue istituzioni, la cultura, la storia (res extensa).
Come per Fichte e Schelling, anche per Hegel la filosofia deve assumere una forma sistematica, in quanto solo in un sistema ogni ambito di ricerca trova una propria collocazione basata sulla ricchezza del loro contenuto spirituale, in quanto il principio è l’assoluto. Per Hegel la filosofia dello spirito occupa una posizione più alta rispetto alla filosofia della natura, in quanto tematizza ambiti nei quali è evidente la razionalità collettiva e che si riversano nella realtà umana; nella seconda invece si esprimono le leggi chimiche o fisiche frutto di un’immanente razionalità. La natura inoltre si ripete in forme sempre uguali, mentre la storia umana progredisce ed è dinamica: ogni civiltà dunque risulterà sempre più matura rispetto alle civiltà precedenti. Ecco che il progresso storico coincide con lo sviluppo dell’autocoscienza, ovvero con la coscienza di sé, dei propri pensieri, dei propri atti. Nella storia conta specialmente l’autocoscienza soggettiva di un popolo. In questo senso l’autocoscienza coincide con la libertà.
La dialettica e il progresso storico
La storia umana però non è caratterizzata da un percorso lineare, ma piuttosto si fa strada attraverso opposizione, conflitti tra opposti e superamento del conflitto: ovvero il nucleo della dialettica.
Per Hegel il compito della filosofia e della ragione è quella di superare le contraddizioni della cultura moderna, organizzare i saperi in un quadro sistematico ed elaborare una comprensione unitaria della realtà. Per realizzare ciò però la filosofia ha bisogno di compiere un’autoriforma, superando contraddizioni e lacerazioni innanzitutto in sé stessa.
Critica alle filosofie di Kant e Fichte
Hegel dunque esamina criticamente le filosofie di Kant, Fichte e Schelling. I primi due hanno il merito di aver tentato di realizzare una parziale unità di soggetto e oggetto, deducendo l’ordine del mondo dall’Io, ma hanno poi fallito in quanto non viene superata la scissione tra forma universale e materia (per Aristotele res cogitans e res extensa). Le due filosofie dunque sono contrassegnate dal formalismo, ovvero la tendenza a scomporre e dividere il soggetto dall’oggetto.
La concezione dell'assoluto di Schelling
Invece la concezione dell’assoluto di Schelling, dapprima considerata come l’unica filosofica, ora viene descritta sarcasticamente poiché è caratterizzata da una confusa indistinzione di soggetto e oggetto. Secondo Hegel infatti l’identità fra soggetto e oggetto deve contemplare anche l’autonomia reciproca, dunque l’assoluto deve essere pensato come identità dell’identità e della non identità. Inoltre l’assoluto non deve essere considerato sostanzialisticamente come sostanza o cosa, ma piuttosto è la mobile e vivente unità di un soggetto. Il soggetto per Hegel è ciò che mantiene la propria identità, mentre si esprime o si oggettiva in molteplici manifestazioni ed è consapevole di queste come proprie manifestazioni. L’assoluto è allora pensabile come un movimento, o processo, articolato in più passaggi; poiché il suo sviluppo implica dei passaggi si dice che è mediato, e non immediato come quello di Schelling.
I tre momenti della dialettica hegeliana
I tre momenti attraverso i quali l’intero si sviluppa caratterizzano la dialettica hegeliana e si articolano in questo modo:
-tesi: l’assoluto “pone sé stesso” come puro pensiero, e dunque si trova “in sé”.
-antitesi: il puro pensiero pone sé stesso in altro, dunque vi è la negazione della semplicità della tesi in altro e l’assoluto si oggettiva. Si dice che è “per sé”.
-Sintesi: l’assoluto diviene consapevole di sé, e si trova “in sé e per sé”. Ecco che abbiamo l’identità fra puro pensiero e manifestazione. Qui viene negato il rapporto di pura opposizione dell’antitesi nei confronti della tesi, per questo Hegel parla di negazione della negazione. La contrapposizione fra tesi e antitesi viene superata, oltrepassata ma conservata come momento necessario di un’unità superiore. Hegel utilizza il sostantivo aufhebung (auf: via; heben: tenere). Possiamo dire dunque che l’assoluto (o spirito) è pensiero che si manifesta e si oggettiva, diventando sempre più consapevole di sé.
Il termine dialettica deriva dall’antica tecnica della confutazione, qui rappresentata dal secondo momento (antitesi) in cui si nega la semplicità del primo. Ma il termine dialettica si può collegare anche al “dia” iniziale, ovvero alla divisione in due, cioè divisione dell’assoluto e dell’articolarsi dell’unità dell’assoluto nella molteplicità delle sue manifestazioni.
La fenomenologia dello spirito
La “Fenomenologia dello spirito” (1807) riprende il motivo platonico dell’uscita della coscienza dalla caverna dell’opinione, cioè dall’inadeguata visione del mondo. L’opera dunque presenta una sorta di scala d’accesso al pensiero filosofico che la coscienza comune deve salire per formarsi filosoficamente ed elevarsi alla filosofia, ovvero il sapere assoluto. Si tratta di esperienze sia in campo teorico che nella dimensione pratica. Lungo questo itinerario la coscienza individuale è chiamata a superare l’opinione che vi sia un’opposizione insuperabile tra soggetto e oggetto, e alla fine la coscienza giunge a far propria quest’opposizione dell’identità dialettica tra soggetto e oggetto propria della filosofia hegeliana. Questo percorso si articola rispettivamente in: coscienza, autocoscienza e ragione.
Il percorso della coscienza
-coscienza: assume un significato circoscritto e designa la certezza che la verità stia al di fuori della coscienza, cioè che il mondo sia bell’e fatto di fronte al soggetto e che a questo resti solo il compito di conoscerlo così come gli è dato. Si tratta del modo comune di vedere le cose. Durante tre fasi (certezza sensibile, percezione e intelletto) la coscienza impara che in realtà questo si tratta di un modo di vedere inadeguato e che la verità non sta nell’oggetto ma nel soggetto, dal quale (come sostiene Kant) dipende la costituzione del mondo e le leggi a priori che lo governano.
La prima figura in cui si trova la coscienza è la certezza sensibile che caratterizza la coscienza comune: la coscienza è certa che il dato sensibile immediato rappresenti la verità. Ma proprio come aveva capito Platone, in realtà si tratta di una certezza illusoria in quanto il dato sensibile è molteplice e in continuo movimento, dunque instabile e sfuggente. La crisi della certezza sensibile determina il passaggio alla seconda figura, ovvero la percezione: ora la coscienza ritiene che la verità stia nella cosa percepita cui le proprietà sensibili ineriscono. Questa visione entra in crisi quando la coscienza apprende che la cosa non è altro se non l’insieme delle sue proprietà, dunque con la negazione delle verità della percezione si passa all’intelletto, la terza e conclusiva figura. Qui la coscienza non pone più la verità nella cosa ma riconosce che la cosa non ha verità in sé stessa, al contrario solo nelle relazioni con le altre cose, specialmente nei nessi di causa, i quali per Hegel coincidono con le leggi a priori che regolano il mondo fenomenico. Il passaggio attraverso le prime tre figure della coscienza mostra dunque ad essa che la verità dell’oggetto non sta nell’oggetto ma nell’io che tiene insieme e costituisce il mondo sensibile attraverso le proprie categorie.
L'autocoscienza e il riconoscimento
-autocoscienza: conoscendo l’oggetto, il mondo (la cui costituzione è a priori), ora la coscienza è impegnata a conoscere sé stessa. E dunque la verità dell’oggetto sta in questa. Tuttavia l’autocoscienza non si raggiunge solo attraverso conoscenze teoriche, ma necessita anche di esperienze pratiche: infatti la personalità autoconsapevole si costruisce solo attraverso una serie di prove che portano la coscienza a superare i propri limiti, a misurarsi con gli altri. Attraverso la dialettica dell’autocoscienza, la coscienza è condotta a realizzare la propria libertà. Le figure della sezione riguardante l’autocoscienza, offrono un documento esemplare della dialettica della coscienza impegnata nella sua formazione. Ci mostrano inoltre l’importanza che riveste in Hegel il riconoscimento in ogni ambito della sua filosofia: il riconoscersi reciproco tra i soggetti infatti è importante non solo per l’autocoscienza, ma anche per la definizione dei rapporti economici, sociali e politici che si stabiliscono fra gli uomini. Dal riconoscimento intersoggettivo dipendono poi sia l’identità individuale di ciascuno, sia le fondamenta del diritto, della società e delle istituzioni.
L’autocoscienza si mostra dapprima come desiderio e appetito, il cui il mondo esterno ci appare come semplice strumento di soddisfazione. In questo modo però l’oggetto viene negato dal consumo che ne faccio, e una volta annientato l’appetito si ripresenta. Attraverso questa ripetizione di appetito-soddisfazione-appetito, l’autocoscienza si rende conto di non poter sussistere senza oggetto. Poiché la soddisfazione dell’appetito implica la consumazione, privazione, la negazione dell’oggetto, l’autocoscienza ha bisogno di un oggetto capace di resistere all’annientamento affinché l’appetito sia costantemente appagato. Questo oggetto risulta essere un’altra autocoscienza. Per affermarsi come tale dunque l’autocoscienza necessita di un’altra autocoscienza: si ha dunque il passaggio a una nuova figura in cui le autocoscienze sono due e hanno una relazione simmetrica, ovvero ciascuna di esse è da un lato soggetto indipendente (appetito negatore dell’oggetto), dall’altro un semplice oggetto da consumare. Questa simmetria viene superata nelle figure successive.
La dialettica servo-padrone
Abbiamo dapprima la lotta per il riconoscimento, in cui ciascuna delle due autocoscienze viene riconosciuta dall’altra quale soggetto. Ma il reciproco riconoscimento non avviene in modo pacifico, si tratta piuttosto di una lotta per la vita e la morte tra le due, in cui una delle due autocoscienze si mostra capace di autonomia rispetto al legame naturale con la vita e mettendola a repentaglio pur di vincere la contesa, mentre l’altra troppo legata alla vita si piega al più forte. Questa figura viene esaminata nella figura del servo-padrone. Quindi chi ha saputo rischiare la propria vita pur di vincere la contesa è il signore, mentre il servo è colui troppo legato all’istinto di sopravvivenza. Si tratta di un rapporto ineguale in cui la coscienza signorile appare dapprima come la vera autocoscienza, riconosciuta come tale dal servo e dominatore della natura, di cui se ne appropria attraverso il lavoro del servo e viene utilizzata per soddisfare il proprio appetito. Successivamente la relazione servo-padrone subisce un capovolgimento: sarà la coscienza servile a mostrarsi quale vera autocoscienza. È vero che il servo lavora e dipende dal signore e dalla natura, che deve manipolare per conto del primo; attraverso il lavoro però riscatta la propria subordinazione al padrone e mette in luce dialetticamente l’inferiorità del padrone verso lui. Il lavoro infatti modifica il prodotto naturale in base a un disegno razionale, in tal modo il servo supera la dipendenza dalla natura, la quale viene dominata essendo lavorata. Attraverso il lavoro la coscienza servile si oggettiva ed è in grado di riconoscere sé stessa nel prodotto. In virtù del lavoro, dell’oggetto umanizzato, si determina anche la relazione col padrone, il quale dipende per la soddisfazione dei suoi appetiti dal lavoro del servo. Tuttavia l’autocoscienza del servo rimane ancora implicita e confusa in quanto non esplicitamente pensata e consapevole. A tale scopo si richiede il passaggio della coscienza attraverso figure come l’esperienza della libertà: libertà di pensiero (che sussiste anche in condizioni di schiavitù –stoicismo-); libertà del pensiero (autonomia e indipendenza del pensiero stesso rispetto ai suoi molteplici contenuti –scetticismo-).
La coscienza infelice e la ragione
A conclusione dell’autocoscienza, troviamo la coscienza infelice, esperienza di vera infelicità che la coscienza sperimenta nel momento in cui avverte i propri limiti davanti all’infinità del sapere e comprende la propria miseria di fronte alla potenza di Dio, pensato come assolutamente altro rispetto all’uomo.
La ragione e il sapere assoluto
-ragione: ultima figura fondamentale per avvicinarsi alla definitiva consapevolezza, propria del sapere assoluto, che soggetto e oggetto sono tra loro identici, e in cui la coscienza compie la sua “rivoluzione copernicana”. Ma per permettere ciò, l’autocoscienza deve necessariamente abbandonare la coscienza infelice e cogliere sé stessa come essenza della realtà. Divenuta ragione, l’autocoscienza sa di costituire l’essenza di tutte le cose della realtà, in cui non vede altro che sé stessa. Per la ragione moderna, infatti, l’essenza del reale viene colta nel suo elemento a priori, dunque nell’Io penso e nelle sue categorie secondo Kant. A questa superiorità (preminenza) del soggetto in campo teorico corrisponde in campo morale l’assolutezza della volontà libera, e dunque sia nella conoscenza scientifica che pratica oggetto e autocoscienza coincidono. La ragiona rappresenta in questo momento un parziale superamento dell’opposizione tra coscienza (per cui la verità sta nell’oggetto) e autocoscienza ( per cui la verità sta nel soggetto e considera inessenziale l’oggetto).
Lo spirito e la storia
Giunta allo stadio della ragione, il percorso dello spirito non termina qui, ma l’ultimo passo che questo deve compiere sarà quello di acquisire la nuova prospettiva filosofica proposta da Hegel nello spirito assoluto. Sappiamo infatti che Hegel reputava idealismo e criticismo fichtiano incapaci di soccorrere al bisogno di filosofia del tempo presente, che necessitava invece di una filosofia dell’assoluto che pensa il vero come intero. Il passo che lo spirito deve compiere ora è reso possibile soltanto dal fatto che esso è già stato compiuto dallo spirito del tempo (la cultura dell’epoca). La formazione della coscienza singola dunque non avviene in una condizione di astratto isolamento, ma si svolge in un determinato tempo storico e consiste nel prender coscienza e appropriarsi della sostanza spirituale del proprio tempo che ha generato l’epoca presente, la sua cultura e la sua filosofia. In altre parole dovrà ripercorrere i passaggi attraverso i quali si è formata la cultura che contraddistinguono l’età presente. Le figure nella sezione della “Fenomenologia” dedicata allo spirito non sono più forme della coscienza individuale, ma mondi spirituali, ovvero figure delle successive civiltà storiche in cui l’assoluto si è manifestato e oggettivato nella cultura delle comunità umano, assumendo la forma di coscienza collettiva. Quindi lo spirito è storia.
A ciascuno dei mondi spirituali in cui lo spirito si oggettiva corrisponde una specifica cultura. La successione delle diverse manifestazioni dello spirito delinea una storia ideale dell’umanità, dai tempi remoti fino a quelli presenti. Durante tale percorso la soggettività autocosciente viene via via assumendo un rilievo maggiore rispetto all’elemento della sostanzialità (“assoluto” inteso non solo come sostanza, ma come soggetto e spirito). Infatti all’inizio del suo percorso lo spirito si presenta come sostanza, la soggettività autocosciente non ha alcuna importanza e l’individuo si ritrova completamente assorbito dalla dimensione collettiva, come avveniva nella polis greca. Così, secondo Hegel, lo scontro tra Antigone e Creonte della tragedia sofoclea non è un conflitto tra due individui, piuttosto tra i due opposti elementi dello spirito greco: legge pubblica e legami familiari.
Nella modernità invece individualità e libera soggettività vengono ad assumere un ruolo fondamentale, affermando la propria libertà assoluta nella rivoluzione francese. In quest’ultima, però, non si è compiuta la dialettica dello spirito, cioè non si è giunti alla costruzione di nuove istituzioni più moderne (perché appunto più libere) ed è mancata la sintesi fra sostanzialità e soggettività. La realizzazione di ciò è compito dell’epoca presente.
La religione e la filosofia
Nell’ultima parte della Fenomenologia Hegel passa ad analizzare tutte le espressioni spirituali attraverso le quali lo spirito ha preso coscienza di sé: queste sono religione e filosofia (sapere assoluto). Nella religione, la presa di coscienza di sé da parte dello spirito avviene in forma mitico-narrativa, chiamata rappresentativa: così per esempio le religioni monoteiste narrano la creazione del mondo da parte di Dio. L’autocomprensione religiosa è tanto più compiuta quanto più ci si allontana dalle religioni primitive per avvicinarci al cristianesimo. Il cristianesimo di Lutero è, infatti, per Hegel, la forma perfetta e moderna della religione, che più adeguatamente rappresenta l’identità fra umano e divino, finito e infinito: dunque l’assoluto.
La fenomenologia si conclude con la breve sezione riguardante il sapere assoluto. Esso è la filosofia adeguata al tempo in cui Hegel scrive. Qui viene definitivamente superata la contrapposizione soggetto-oggetto, e lo spirito comprende ora sé stesso nella forma del concetto (ragione filosofica) e non più in forma mitico-narrativa della rappresentazione religiosa.
“Introduzione all’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”
Lo studio della “Fenomenologia dello spirito” ci ha consentito di mettere a fuoco alcune fondamentali dottrine;
-l’idea che la sola vera conoscenza sia quella che apprende la realtà nella sua totalità e sulla base di un principio unico; ed è per questo motivo che la filosofia deve assumere la forma di un sistema;
-la concezione dell’assoluto non solo come sostanza, ma anche (e soprattutto) come soggetto e spirito;
-la spiegazione di ogni realtà come momento dell’assoluto, ovvero come sua manifestazione nel tempo storico e nello spazio;
-la dottrina dell’identità (dialettica) di soggetto e oggetto, di ragione e realtà.
Il rapporto tra filosofia e scienze
Prima di procedere allo studio della nuova opera, è bene ritornare sulla concezione di Hegel sulla filosofia e riflettere sul rapporto che egli istituisce tra questa e le altre discipline scientifiche.
In effetti, Hegel riconosce che il pensiero non opera solo nella filosofia ma anche nelle altre scienze, e in generale in tutte le attività umane delle quali esso costituisce l’aspetto peculiare e distintivo. Per quanto concerne le scienze è indubbio che anch’esse pensano, producono cioè concetti e teorie; tutta via Hegel osserva che una cosa è pensare, come fanno tutte le altre discipline, un’altra è pensare il pensiero, propria della filosofia. La filosofia infatti, ha come oggetto principale il pensiero.
Consideriamo ora il rapporto tra la filosofia e le altre scienze, non solo la fisica, biologia, chimica, ma anche il diritto, le scienze umane e sociali. Hegel le chiama empiriche poiché partono dall’esperienza e dall’osservazione e si propongono di fornire una teoria o spiegazione razionale dei dati e fatti osservati. Kant nella “Critica della ragion pura” aveva assunto come modello di scientificità la fisica, in quanto secondo egli i giudizi della fisica sono estensivi del sapere e presentano caratteri indiscutibili di universalità e necessità, dunque di oggettività. Hegel invece nega che la fisica possa realmente rappresentare un modello per la conoscenza scientifica in quanto vi sono aspetti della realtà (quali la libertà, l’anima, Dio) che non possono essere conosciuti allo stesso modo dei fenomeni fisici. Lo stesso Kant negava la possibilità di una metafisica scientifica.
Hegel, inoltre, contesta la pretesa necessità della fisica moderna, riprendendo contro Kant le obiezioni scettiche che l’avevano investita sin dalle origini e più recentemente a opera di Hume. Quest ultimo riteneva che ogni discorso intorno a “materie di fatto” non poteva che aspirare a un elevato grado di probabilità. Anche secondo Hegel è improprio parlare di necessità a proposito di leggi elaborate dalle scienze naturali in quanto queste hanno un forte carattere ipotetico, cioè i dati empirici possono essere interpretati in differenti modi e nessuna teoria, per quanto verosimile, potrà mai presentarsi coni caratteri di assoluta necessità. A differenza di Hume, Hegel sostiene tuttavia che il carattere di necessità che manca alle scienze empiriche e le quali non possono procurarsi da sole, deve esser fornito loro dalla filosofia, alla quale viene affidato un compito analogo a quello assegnato da Platone. La filosofia e le scienze filosofiche in cui si articola devono, quindi, fondare speculativamente ( dal punto di vista della ragione filosofica) le scienze empiriche, saggiandone modelli, concetti, leggi, e collocando ognuna al proprio posto nel quadro gerarchico delle conoscenze umane. Dunque possiamo comprendere ora cosa si intende col dire che la filosofia pena il pensiero: essa riflette sul pensiero contenuto nelle scienze empiriche, cioè sui concetti, leggi, teorie, per saggiare la sua conformità e la sua coerenza col movimento dialettico dell’assoluto. L’assoluto d’altronde ci dice che il vero è l’intero e gli aspetti e gli elementi particolari hanno valore e significato in quanto momenti indispensabili dello sviluppo dell’intero stesso.
Il sistema hegeliano delle scienze
Il sistema hegeliano delle scienze filosofiche si articola in tre grandi sezioni:
-Logica: è la scienza dell’idea in sé e per sé, dell’idea pura. Studia il pensiero in quanto tale e affronta problemi oggetti di metafisica e logica reinterpretandoli;
-filosofia della natura: o scienza dell’idea nel suo alienarsi da sé, si propone la fondazione speculativa delle scienze empiriche della natura (chimica, biologia, fisica). In questa sezione inoltre Hegel si confronta in particolar modo con le filosofie romantiche della natura, specie con quella di Schelling, di cui viene criticata l’interpretazione filosofica, troppo schematica e semplicistica che essa offre dei fenomeni naturali;
-filosofia dello spirito: o scienza dell’idea che dal suo alienamento torna in sé, discute i fondamenti dei saperi e delle discipline che riguardano l’uomo, sia in quanto individuo (psicologia) sia in quanto facente parte della collettività (scienza del diritto, scienza della morale, economia, ecc);
-nella sezione dello spirito assoluto, infine, Hegel s’interroga su significato e funzione dell’arte, della religione e della stessa filosofia.
Il movimento dialettico triadico (tesi, antitesi, sintesi) contrassegna tanto il sistema complessivo, quanto lo sviluppo di ogni suo momento. Conseguentemente incontreremo una spartizione triadica oltre che nella partizione generale del sistema hegeliano, anche nello svolgimento interno a ogni specifica scienza filosofica.
La filosofia dello spirito soggettivo
-spirito soggettivo: Hegel dichiara di rifarsi al “De anima” di Aristotele, in quanto ai suoi occhi rappresenta un modello che le psicologie filosofiche moderne non sono riuscite a sopravanzare. La filosofia dello spirito soggettivo si articola in:
-antropologia: ha come tema l’emergere dello spirito dall’esteriorità della natura e studia in particolare il primo momento dello sviluppo della spiritualità soggettiva, ovvero l’anima. Questa secondo Hegel è l’originaria unità psicosomatica propria dell’infante, un’unità semplice e immediata in quanto non è ancora apparsa in essa la distinzione fra dimensione spirituale e corporea, tra un soggetto e un oggetto.
-fenomenologia: scienza che si articola in coscienza, autocoscienza e ragione, corrispondenti grosso modo alla prima parte della “Fenomenologia” del 1807. Qui l’unità immediata dell’anima risulta negata e si manifesta come opposizione soggetto-oggetto, io-mondo, dando luogo alla struttura bipolare caratteristica della coscienza. Contro la filosofia moderna (da Cartesio a Kant) che considerava la coscienza come punto di partenza della ricerca filosofica, Hegel vuole dimostrare che la coscienza è invece il risultato di un precedente movimento dialettico dell’anima. La dialettica della coscienza è studiata dunque nella fenomenologia.
-psicologia: momento in cui le opposizioni della coscienza e le sue rappresentazioni dualistiche vengono superate e risolte in un’unità non più semplice e immediata come l’anima, ma mediata o dialettica: tali opposizioni sono infatti presentate ocme prodotto di un’attività unica del soggetto che è insieme conoscitiva e pratica. L’aspetto più importante è quello pratico. Il carattere fondamentale del soggetto individuale è infatti indicato nella libertà o volontà libera, la quale non è altro se non ragion pratica.
La libertà dell’individuo tuttavia resta un’astrazione se non si concretizza oggettivandosi in leggi, norme morali, istituzioni familiari, sociali e politiche. Così si giustifica il passaggio allo spirito oggettivo, nel quale l’attenzione per il singolo lascia il posto all’esame dei rapporti che legano gli individui tra loro.
La filosofia dello spirito oggettivo
-spirito oggettivo: sebbene l’eticità (lo stato) sia affrontato per ultimo nell’ordine dell’esposizione scientifica, sul piano ontologico rappresenta il fondamento unitario, l’intero che dividendosi dà luogo agli altri momenti o sfere. Un sistema sociale, economico e politico come quello delineato nell’eticità costituisce il fondamento delle relazioni tra persone giuridiche (diritto) e dei doveri morali (moralità). Per Hegel senza società e senza stato non esisterebbero né diritto né morale, i quali fuori dal contesto che li esprime sono astrazioni. Ma benchè presi isolamente questi momenti rappresentino una realizzazione parziale della libertà, essi sono necessari e apportano un contributo alla realizzazione dell’eticità.
Il diritto astratto e la moralità
-diritto astratto: è il primo ambito di realizzazione della volontà libera. Si tratta di una realizzazione precaria e povera in cui la libertà è soltanto in sé. Hegel in questa sezione affronta i diritti dell’uomo nella loro universale validità, cioè come essi sono concepibili indipendentemente dalla loro concreta attuazione. La prospettiva dominante è quella del singolo inserito all’interno dei rapporti giuridici e dunque un singolo riconosciuto dagli altri, quale persona giuridica e uguale agli altri di fronte alla legge. Quanto al contenuto la sezione del diritto privato corrisponde solo in parte a quella del diritto privato definito dalla giurisprudenza.
Hegel considera in primo luogo la proprietà. Questo è un diritto razionale in quanto ha un fondamento intersoggettivo, presuppone cioè il riconoscimento da parte degli altri che non comprende solo la garanzia del possesso di cose o beni, ma anche e soprattutto l’HABEAS CORPUS, cioè la proprietà della persona. In tal modo la proprietà riveste un’importanza enorme, di cui Hegel ne parla come della necessaria incarnazione della libertà nei beni e nel corpo.
Nel contratto Hegel vede il secondo ulteriore riconoscimento in cui conferiscono volontà differenti. Tuttavia Hegel sostiene che si tratti di un’unità precaria in quanto basata sull’arbitrio dei singoli contraenti, e passa dunque a criticare il contrattualismo politico, che pretende di fondare un’istituzione come lo stato sul contratto.
Il terzo momento è caratterizzato dalla pena. Chi compie un illecito, viola le regole del diritto di tutti, cioè nega quest’ultimo opponendovi il proprio diritto individuale. L’illecito dev’essere negato dalla pena, alla quale spetta l’ulteriore compito di reintegrare la libertà che costituisce la sostanza del diritto. Hegel dunque si spinge fino a legittimare la pena di morte contro Beccaria, sostenendo che questa sia un diritto per chi compie l’illecito, in quanto la pena deve emanare da una volontà che non si propone la difesa di un diritto o libertà particolare, ma l’affermazione dell’universalità della libertà.
La dialettica del diritto astratto conduce così a tematizzare l’universalità della volontà libera, identica in ogni uomo in quanto espressione della ragione. ma il punto di vista della persona giuridica deve essere integrato con quello del soggetto morale, a ciò spinge la convinzione di Hegel secondo cui nell’azione dell’illecito si manifesta il disagio del singolo poiché le leggi sono astratte e vincolano solo esteriormente, non offrono una motivazione che orienti ad agire bene. Si passa dunque a parlare di moralità.
La moralità e l'eticità
-moralità: si tratta di un passaggio dall’esteriorità dei rapporti giuridici all’interiorità della coscienza morale. La coscienza morale è definita da Hegel come il santuario violare il quale sarebbe sacrilego. L’interiorità della coscienza rappresenta agli occhi di Hegel un tratto costitutivo della modernità, in quanto si distingue dalle epoche precedenti per il ruolo che la libertà soggettiva assume in essa intorno alla legittimità razionale del proprio agire. Di conseguenza un moderno spirito oggettivo è tenuto ad assumere la moralità come proprio momento necessario. la coscienza morale tuttavia sfugge al proprio compito se si arrocca in una posizione di isolamento dal mondo ergendosi paladina del dover essere e opponendosi al corso della realtà. La coscienza morale secondo Hegel, invece, può realizzare il suo scopo attingendo al bene e alla razionalità del volere che essa ricerca, solo se sa riconoscere gli ideali nelle concrete istituzioni in cui vivono effettivamente. Su questa base Hegel si confronta con Kant e la filosofia morale del suo tempo evidenziandone il formalismo.
Da un lato nella sfera dell’eticità, l’inserimento nella famiglia, nella società e nello stato comporta per il singolo doveri concretamente e precisamente determinati, legati alla sua collocazione familiare, sociale e di cittadino. D’altro lato, poiché tali istituzioni sono a diversi livelli l’oggettivazione dell’idea etica (libera volontà razionale) i doveri imposti sono effettivamente legittimati dall’autonomia della ragione: essi dunque sono dettati dalla ragione che in quelle istituzioni si incarna facendosi reale.
La famiglia e la società civile
-eticità: qui la volontà libera, l’essenza dello spirito oggettivo si concretizza nella famiglia, nella società civile e nello stato.
La famiglia descritta da Hegel presenta affinità col nucleo familiare della famiglia borghese fondata sul rapporto fra genitori e figli. Con l’uscita dei figli dalla famiglia d’origine si formano nuove famiglie, d’altra parte i bisogni della famiglia non possono essere soddisfatti esclusivamente all’interno, ma richiedono la cooperazione con altre famiglie e altri produttori. La famiglia deve essere dunque pensata come un elemento di una comunità più vasta, quale è la società.
Se la famiglia è il momento dell’unità immediata, la società civile si presenta come necessario smembramento e dispersione di quell’unità che sarà superato da una più ricca unità. Nella società civile infatti si lascia il posto alla mediazione e dunque alle differenze e alle contraddizioni che in Hegel segnano ogni secondo momento dello svolgimento dialettico triadico.
La società civile e lo stato
-società civile: qui il rapporto tra singolo e totalità, di sostanziale identità nella famiglia, qui svanisce. La compatta unità della famiglia appare qui frammentata in una pluralità di individui, cioè soggetti economici privati della società borghese nella fase concorrenziale del capitalismo. La volontà dell’agire degli individui è dettata dall’interesse individuale. Tale insocievolezza non è che l’espressione di un legame etico di fondo, di una socievolezza, che si manifesterà pienamente soltanto nell’unità dello stato e della cittadinanza, ma i cui segni affiorano già nei primi momenti della società civile.
Nel primo momento designato come sistema dei bisogni la socievolezza avviene tramite interdipendenza economica. La divisione del lavoro, favorendo la specializzazione dei produttori, permette la soddisfazione di bisogni sempre più sofisticati. Ma in tal modo ciascuno dipende dal lavoro degli altri e l’egoismo del privato, convinto di lavorare solo per se stesso, in verità contribuisce anche alla soddisfazione dei bisogni degli altri, soggiacendo ad una razionalità universale. Vi è qui un evidente richiamo alla mano invisibile di Adam Smith riguardo alla capacità di autoregolamentazione del mercato. Infatti qui Hegel dimostra di avere un’approfondita conoscenza circa concetti fondamentali dell’economica politica classica, di cui Smith ne è considerato l’iniziatore. Hegel tuttavia si propone di fondare speculativamente tale disciplina e ciò lo porta alla denuncia del liberismo di Smith e della fiducia nel mercato lasciato al suo spontaneo funzionamento nella convinzione che questo trovi un suo autonomo equilibrio. Sempre nel sistema dei bisogni concorrono anche altri meccanismi come la diffusione moderna della cultura che immette l’individuo nella comunicazione con gli altri membri del corpo sociale, e l’aggregarsi di classi sociali distinte ed omogenee al loro interno (classe industriale, classe agricola, classe burocratica e dei dirigenti statali).
Il secondo momento è rappresentato dall’amministrazione della giustizia. Qui il diritto astratto si fa concreto nel sistema di leggi positive. Nella giustizia il rapporto tra singolo e totalità si rafforza, infatti attraverso l’applicazione della norma il diritto del singolo viene collegato al diritto universale.
Nel terzo momento, quello della polizia, il legame etico tra singolo e totalità si manifesta con maggior evidenza. La polizia viene intesa come amministrazione statale e le corporazioni. L’amministrazione pubblica si occupa di tutelare i beni e i diritti del singolo, inoltre si fa attivamente carico del benessere dei cittadini per mezzo di programmi educativi e politiche economiche. A tal scopo Hegel medita sulle misure atte a contrastare gli squilibri della società moderna, come la miseria. Nelle corporazioni, infine, Hegel indica il fattore di ricomposizione organizzata tra singolo e totalità, anche se tale riconciliazione riguarda una totalità ristretta a coloro che svolgono il mestiere. La corporazione dunque rappresenta il momento di passaggio attraverso cui dalla dispersione peculiare della società civile, lo spirito etico ritorna all’unità: stavolta non all’unità immediata della famiglia, ma all’unità mediata propria dello stato e delle sue istituzioni fondamentali, che è unità complessa di tutte le relazioni di cui è intessuta la società civile.
Lo stato e la volontà universale
-stato: è il momento supremo dell’eticità. In esso il riconoscimento intersoggettivo delle autocoscienze si manifesta nella condivisione di una comune cittadinanza. Qui si attua lo spirito etico (libertà concretamente realizzata). Lo stato si rivela il fondamento ontologico della famiglia e della società civile (e a maggior ragione del diritto e della moralità). Questa concezione di stato deriva da Aristotele, secondo il quale la polis precede il singolo. Hegel sviluppa una critica nei confronti del contrattualismo moderno, che vede nell’individuo il fondamento e nello stato un ente artificiale, dipendente dai singoli e dalle loro volontà particolari. Per Hegel infatti, lo stato è completa realizzazione della volontà libera, che è razionale e dunque universale perché frutto della ragione. La volontà universale punta al bene comune e dunque non deriva da una convergenza (nel contratto) delle volontà individuali legate agli interessi privatistici. Dunque la legittimazione razionale dello stato dipende dalla conformità dell’agire delle istituzioni politiche alla volontà libera dei cittadini, la quale è volontà guidata dalla ragione e che persegue l’universale e non la volontà particolare.
La totalità dello stato si articola nei momenti di: (appartenenti al diritto interno)
-universalità: facoltà di determinare e stabilire l’universale ed è prerogativa del legislativo.
-peculiarità: facoltà di applicare la legge ai casi particolari e spetta al potere esecutivo
-individualità: (massima espressione della soggettività) è peculiare del potere monarchico costituzionale. Questa rappresenta per Hegel la struttura politica fondamentale, culmine e inizio dell’intero organismo statale nella quale i distinti poteri dello stato sono raccolti a unità. Con la sua capacità di prendere decisioni, di dare concretezza alla volontà universale, la monarchia esprime l’affermarsi più compiuto della soggettività del mondo delle istituzioni oggettive dell’eticità. Hegel dunque riconosce la funzione centrale della monarchia nel sistema istituzionale ma ne rifiuta la legittimazione per diritto divino e che la soggettività monarca sia intesa come giustificazione al puro arbitrio dell’individuo: la volontà regia è razionale.
Il diritto statale e la guerra
I tre momenti in cui si articola lo stato sono:
-diritto state interno o costituzione
-diritto statale esterno: concerne le relazioni tra stati. Tra loro viene meno la solidarietà etica e ritornano alcune caratteristiche della società civile. A differenza degli individui però lo stato è autosufficiente e il rapporto tra stati ha come principio la sovranità di ciascuno, dunque essi stanno tra loro come gli uomini allo stato di natura senza che i loro rapporti giuridici siano sanciti da altro de dalla loro volontà particolare. Non vi è dunque in realtà una volontà universale che istituisce il diritto internazionale. L’assenza di una volontà generale, superiore alle volontà particolari dei singoli stati porta Hegel a prendere le distanze dall’idea kantiana della pace perpetua garantita da un ordinamento cosmopolitico, da un potere federale riconosciuto e in grado di risolvere i conflitti e le controversie. Questo ordinamento privo di fondamento etico non rappresenta l’espressione di una volontà generale, in quanto si reggerebbe sulla concordia fra gli stati. Hegel dunque ritiene inevitabile e legittimo il ricorso alla guerra per risolvere le controversie tra stati quando venga meno l’accordo tra loro.
-storia del mondo
Domande da interrogazione
- Qual è il significato della "rivoluzione copernicana" nella filosofia di Hegel?
- Come Hegel concepisce l'assoluto e la sua relazione con il soggetto e l'oggetto?
- Qual è il ruolo della dialettica nella filosofia di Hegel?
- In che modo la "Fenomenologia dello spirito" descrive il percorso della coscienza?
- Qual è la relazione tra filosofia e scienze secondo Hegel?
Hegel interpreta la "rivoluzione copernicana" di Kant come l'idea che il mondo è strutturato dalle forme a priori e dalle categorie, con un'enfasi sulla libertà umana. Tuttavia, Hegel ritiene necessario superare i dualismi irrisolti della filosofia kantiana per comprendere la realtà nella sua totalità.
Hegel vede l'assoluto non solo come sostanza, ma come soggetto e spirito. L'assoluto è un movimento articolato in più passaggi, dove l'identità tra soggetto e oggetto include anche la loro autonomia reciproca, superando la semplice indistinzione.
La dialettica è centrale nella filosofia di Hegel, caratterizzata da tre momenti: tesi, antitesi e sintesi. Questo processo permette di superare le contraddizioni e raggiungere una comprensione unitaria della realtà, dove l'assoluto si manifesta e si oggettiva.
La "Fenomenologia dello spirito" descrive il percorso della coscienza attraverso le fasi di coscienza, autocoscienza e ragione. La coscienza deve superare l'opposizione tra soggetto e oggetto per giungere alla consapevolezza dell'identità dialettica tra i due, culminando nel sapere assoluto.
Hegel sostiene che la filosofia deve fondare speculativamente le scienze empiriche, fornendo loro il carattere di necessità che manca. La filosofia riflette sul pensiero contenuto nelle scienze, valutandone la conformità con il movimento dialettico dell'assoluto.

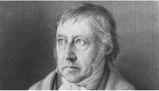





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo