Concetti Chiave
- Aristotele preferisce il termine "analitica" alla "logica" per descrivere il suo approccio, che studia la struttura dimostrativa delle scienze.
- La logica aristotelica si divide in tre aree: concetto, proposizione e ragionamento, ciascuna con un ruolo specifico nella costruzione del pensiero.
- Il sillogismo è un ragionamento in cui, dalle premesse, deriva una conclusione necessaria; è composto da tre proposizioni con termini maggiori, minori e medi.
- Aristotele identifica 256 modalità di sillogismo, ma solo 19 sono considerate valide; la veridicità delle premesse è fondamentale per la validità del sillogismo.
- La dialettica si basa su principi probabili e non necessari, utilizzata per l'oratoria e il ragionamento, distinta dalla scienza che usa principi necessari.
Questo appunto di Filosofia tratta della logica aristotelica. Nel primo paragrafo si introduce brevemente la filosofia aristotelica; nel secondo paragrafo si chiarisce la logica aristotelica; nel terzo si approfondisce l’idea di sillogismo aristotelico; nel quarto si chiarirà la dialettica aristotelica.

Indice
Logica aristotelica e il suo significato
La Alessandro di Afrodisia utilizzò invece il termine “organon” per indicare gli scritti aristotelici di logica. Secondo alcuni questo termine – il cui significato è “strumento” - serve a sottolineare la funzione introduttiva alle scienze che la logica svolge. Ci si chiede spesso se Aristotele si dedicò prima agli scritti di logica oppure a quelli di metafisica. Probabilmente le due opere sono parallele, nel senso che ogni punto non molto chiaro della sua metafisica veniva con ogni probabilità spiegato nuovamente nella logica.
Occorre inoltre ricordare che la logica non aveva per Aristotele il significato che assume ai nostri giorni: una scienza senza oggetto e senza contenuto. La logica ha invece per Aristotele un oggetto di studio, che è la struttura della scienza in generale, ed essendo l’essere l’oggetto della scienza, ecco che esso diviene indirettamente anche quello della logica.
- LOGICA DEL CONCETTO = Aristotele sostiene che gli oggetti del nostro discorso (i concetti) possono essere disposti entro una scala di universalità, e classificati tramite la loro specie e il loro genere. Ad esempio, considerando il concetto di “quadrilatero”, esso è genere rispetto a “quadrato”, ma è anche specie rispetto all’idea di “poligono”. La specie contiene, rispetto al genere, un maggior numero di caratteristiche, ma un minor numero di elementi. Di conseguenza possiamo dire che quando aumenta l’estensione, diminuisce la comprensione, e viceversa. Specie e genere stanno perciò in un rapporto inversamente proporzionale. Man mano che si entra nello specifico, l’estensione cala, fino ad arrivare alla “specie infima”, cioè quella che non ha sottospecie. Tale è l’individuo o “sostanza prima”. Percorrendo invece la catena al contrario, si arriva ai “generi sommi”, che hanno massima estensione e minima comprensione: si tratta delle dieci categorie dell’essere, di cui Aristotele parla nella sua metafisica.
- LOGICA DELLA PROPOSIZIONE = Aristotele prende in considerazione gli “enunciati apofantici”, detti anche o dichiarativi, cioè le affermazioni, perché possono essere sia veri che falsi, diversamente dai comandi o delle preghiere. Questi enunciati esprimono verbalmente i giudizi. In essi due concetti vengono uniti tramite una struttura soggetto-predicato. Aristotele prosegue suddividendo gli enunciati in base alla qualità (enunciati affermativi o negativi) e alla quantità (proposizioni universali, particolari e singole). Per esplicitare questi rapporti, i logici medievali elaborarono la struttura detta “quadrato degli opposti”.
- LOGICA DEL RAGIONAMENTO = secondo Aristotele, le proposizioni non costituiscono un ragionamento, poiché si ragiona solo passando da un enunciato all’altro con un nesso logico, in modo tale da rendere chiare sia le cause che le conclusioni. Pronunciare una sola frase o un insieme di frasi non costituisce, secondo il filosofo, un ragionamento. A questo proposito, egli introduce il concetto di sillogismo.
Struttura e validità del sillogismo
Il significato di sillogismo è appunto questo: un discorso o un ragionamento nel quale, a partire da determinate premesse, segue una conclusione ben precisa, da esse derivata. Proviamo a vedere uno dei sillogismi più famosi. “Ogni animale è mortale. Ogni uomo è animale. Ogni uomo è mortale.” Il sillogismo consta di tre proposizioni, ovvero due proposizioni di premessa ed una conclusiva. La prima è la premessa maggiore, mentre la seconda è quella minore. “Animale” è il termine medio, perché ha estensione media rispetto agli altri due. “Mortale” e “uomo” sono poi i termini maggiore e minore. Il termine medio collega il minore e il maggiore, che dunque troviamo uniti nella terza proposizione: cioè è appunto possibile poiché il termine minore è contenuto nel medio e il termine medio nel maggiore. Perciò, le caratteristiche fondamentali del sillogismo sono il suo CARATTERE MEDIATO e la sua NECESSITA’. Il termine medio costituisce la sostanza del sillogismo: l’uomo è mortale solo in quanto animale. Il principio di tutto è dunque la sostanza, da cui derivano anche i sillogismi. Perciò, i sillogismi sono UNIVERSALI.
In base alla posizione del termine medio, esistono diversi tipi (o “figure”) di sillogismo:
- Nella premessa maggiore costituisce il soggetto, nella premessa minore predicato
- Nella premessa maggiore costituisce il predicato, come pure nella premessa minore
- Nella premessa maggiore costituisce il soggetto, come pure premessa minore
- Nella premessa maggiore costituisce il predicato, nella premessa minore il soggetto
Indicando con “SUB” il soggetto (da “subjectus”) e con “PRAE” il predicato (da “praedicatus”), si hanno le seguenti disposizioni schematiche:
- SUB-PRAE;
- PRAE-PRAE;
- SUB-SUB;
- PRAE-SUB.
Poiché le premesse del sillogismo possono essere affermative o negative, universali o particolari, si avranno molte combinazioni, definite “modi del sillogismo”. Nel calcolarle si tiene conto delle proposizioni (che nel sillogismo sono 3) e delle loro forme (che sono, come detto, 4). Quindi 4³ = 64. Le figure sono invece quattro. In conclusione, i modi del sillogismo sono: 64 x 3 = 256. Ma di questi, secondo Aristotele, non tutte costituiscono un sillogismo valido. Sono solo 19 i modi concludenti. A questi sillogismi i medievali hanno dato un nome. Ogni nome è formato da tre sillabe: premessa maggiore, minore, conclusione. Le vocali di ogni sillaba hanno un significato:
- A= universale affermativa;
- E= universale negativa;
- I= particolare affermativa;
- O= particolare negativa.
Principi e definizioni nella logica
La figura perfetta è la prima per Aristotele (A,A,A), tant’è vero che tutte le figure possono essere ricondotte a questa. Il problema, per creare ragionamenti validi, non è solo quello della coerenza del sillogismo. Aristotele stesso diceva che spesso un sillogismo logicamente corretto può poi risultare falso, e questo quando sono false le sue premesse. Il filosofo si sofferma dunque su come creare sempre sillogismi perfetti e veri. Il problema fondamentale è dunque quello di ottenere le giuste premesse. Le premesse, secondo Aristotele, devono essere vere di verità intuitiva, e risultare dunque comuni a più o tutte le scienze, come il principio di non-contraddizione, il principio di identità (ogni cosa è uguale a se stessa) e il principio del terzo escluso (tra due opposti contraddittori non c’è via di mezzo).
I principi sono necessari, ma non sufficienti. Ci vogliono PRINCIPI PROPRI, cioè definizioni che enunciano l’essenza di ciò di cui si parla. Ad esempio: l’uomo (concetto) è un animale (genere prossimo) ragionevole (qualità specifica). Si individua dunque la peculiarità del soggetto. Ma come si trovano le definizioni? Grazie all’INDUZIONE, un processo mentale grazie al quale dal particolare si arriva all’universale. L’esperienza e l’induzione sono una sorta di preparazione, rappresentano la scintilla che mette in moto l’intuizione. La scienza diventa quindi per Aristotele un atto di intuizione che opera per mezzo dell’esperienza.
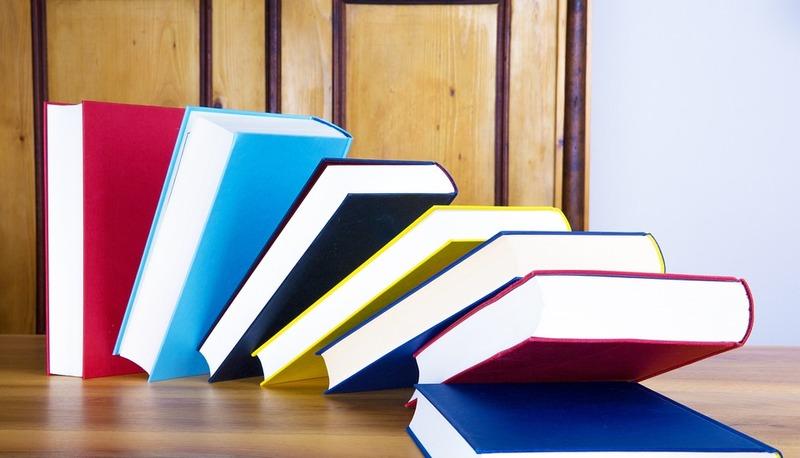
Dialettica e luoghi logici
Nei “Topici”, Aristotele definisce il concetto di dialettica, che si distingue dalla scienza per i suoi principi, che sono probabili e non necessari. Questi principi sono utilizzati nell’oratoria, oppure per esercitarsi a ragionare. Gli schemi argomentativi che si usano nella discussione sono definiti LUOGHI LOGICI. Ogni volta che in una discussione dialettica c’è una domanda che ammette due risposte contraddittorie, sorgono dei problemi: questi non sorgono, invece, nella scienza, che ammette soltanto risposte necessarie. Secondo Platone, la dialettica è la scienza propria del filosofo, la quale mette in discussione i principi delle altre scienze. Secondo Aristotele, invece, è un ragionamento debole che, partendo da premesse probabili, non conduce a niente.
Per approfondimenti sulla dialettica anche nella storia moderna, vedi anche qui
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della logica nella filosofia di Aristotele?
- Come Aristotele classifica i concetti nella sua logica?
- Qual è la struttura di un sillogismo secondo Aristotele?
- Quali sono i principi fondamentali per creare sillogismi perfetti secondo Aristotele?
- Come si differenzia la dialettica dalla scienza secondo Aristotele?
La logica per Aristotele non è una scienza, ma studia la forma comune delle scienze, ovvero il loro "processo dimostrativo". È considerata uno strumento introduttivo alle scienze.
Aristotele classifica i concetti in una scala di universalità, distinguendo tra specie e genere, con un rapporto inversamente proporzionale tra estensione e comprensione.
Un sillogismo è composto da tre proposizioni: due premesse (maggiore e minore) e una conclusione, con un termine medio che collega il termine minore e maggiore.
I sillogismi perfetti richiedono premesse vere di verità intuitiva, comuni a più scienze, come il principio di non-contraddizione, identità e terzo escluso, oltre a principi propri e definizioni essenziali.
La dialettica si basa su principi probabili e non necessari, utilizzati nell'oratoria e per esercitarsi a ragionare, mentre la scienza si fonda su risposte necessarie e principi certi.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo