Concetti Chiave
- Il voto è l'esercizio della sovranità popolare nei sistemi democratici, permettendo ai cittadini di eleggere rappresentanti che decidono per lo Stato, attraverso elezioni politiche, amministrative ed europee.
- Il sistema elettorale può essere maggioritario o proporzionale, influenzando la rappresentanza politica; l'Italia utilizza un sistema misto per le elezioni nazionali e un sistema maggioritario a doppio turno per quelle locali.
- La democrazia diretta si manifesta principalmente attraverso il referendum abrogativo, che permette al popolo di abolire leggi, e include anche il diritto di petizione e l'iniziativa legislativa popolare.
- I partiti politici, riconosciuti dall'articolo 49 della Costituzione, sono essenziali per la partecipazione democratica, formando coalizioni a causa del sistema pluripartitico italiano.
- Le forme di governo si distinguono tra monarchia, con sovrano ereditario, e repubblica, dove il capo dello Stato è eletto, con l'Italia che adotta una repubblica parlamentare.
1.
Indice
Partecipazione democratica
Nei sistemi democratici i cittadini hanno il diritto di partecipare ala vita dello Stato e di determinare l’orientamento politico. Il popolo esercita il potere sovrano solo in alcuni casi. Negli Stati democratici prevale il principio della rappresentanza indiretta: i cittadini eleggono i propri rappresentanti affinché essi possano esercitare il potere politico.
L’elettorato attivo e passivo
Elezioni e diritto di voto
La Costituzione italiana adotta un modello di democrazia rappresentativa o indiretta, in base alla quale la sovranità del popolo si manifesta nella scelta dei suoi rappresentanti, che prendono decisioni relative alla vita politica dello Stato. I cittadini esercitano il loro diritto di partecipazione attraverso lo strumento delle elezioni. Esistono 3 tipi di elezioni:
• politiche, per eleggere il Parlamento, costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;
• amministrative, relative agli enti pubblici territoriali;
• europee, per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Le elezioni politiche si svolgono ogni 5 anni, quelle comunali si svolgono ogni 5 anni come fissato dall'articolo 51 del d.lgs n. 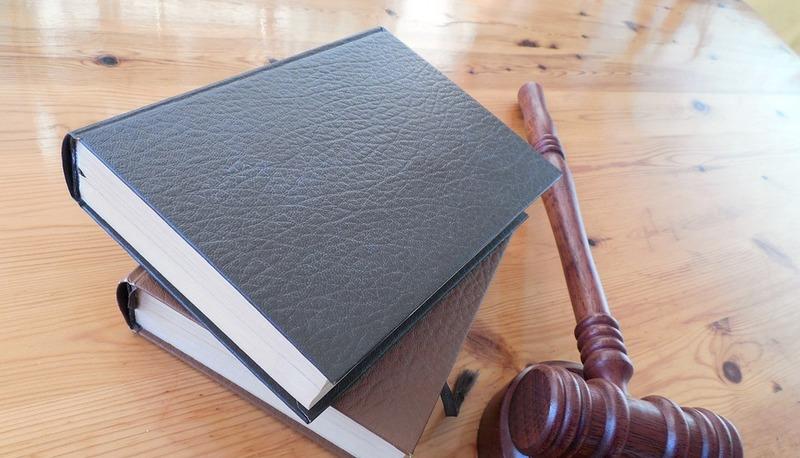 267/20004. La sovranità viene esercitata attraverso il diritto di voto, che spetta a tutti i cittadini che hanno raggiunto il 18° anno di età (articolo 48). Un cittadino può essere privato del diritto di voto solo nei casi di indegnità morale stabiliti dalla legge o a causa di una condanna penale (articolo 48). Inoltre questo articolo sancisce il suffragio universale, attribuendo il diritto di voto a tutti i cittadini.
267/20004. La sovranità viene esercitata attraverso il diritto di voto, che spetta a tutti i cittadini che hanno raggiunto il 18° anno di età (articolo 48). Un cittadino può essere privato del diritto di voto solo nei casi di indegnità morale stabiliti dalla legge o a causa di una condanna penale (articolo 48). Inoltre questo articolo sancisce il suffragio universale, attribuendo il diritto di voto a tutti i cittadini.
L’insieme dei cittadini che hanno il diritto di voto costituisce il corpo elettorale
Principio di maggioranza
Le decisioni vengono prese dal corpo elettorale in base al principio della maggioranza, secondo il quale la scelta della maggioranza degli elettori vincola anche la minoranza.
Il principio di maggioranza è una regola democratica; per essere valida, comprende anche il diritto per la minoranza di esprimere il proprio dissenso contro le decisioni prese dalla maggioranza. Gli ordinamenti giuridici democratici riconoscono alla minoranza il diritto di diventare maggioranza.
Il voto è (articolo 48):
• personale perché l’elettore non può dare ad altri l’incarico di votare al suo posto;
• eguale in a ciascuno spetta un solo voto;
• libero perché ogni elettore vota secondo il proprio convincimento politico.
• segreto perché nessuno deve venire a conoscenza di come un elettore ha votato.
L’articolo 48 definisce l’esercizio del voto un dovere civico, cioè un impegno morale e civile del cittadino.
Chi non vota contribuisce al fenomeno dell’astensionismo elettorale ma non è assoggettato a nessuna sanzione. I diritti politici che la Costituzione riconosce ai cittadini comprendono anche l’elettorato passivo, il diritto di accedere a cariche elettive: tutti possono essere eletti deputato, senatore, consigliere comunale o sindaco.
2. Il sistema elettorale
Sistema elettorale
Il sistema elettorale è l’insieme delle regole che disciplinano il modo in cui avvengono le elezioni e gli effetti che ne derivano.
I modelli di sistema elettorale possono essere ricondotti in 2 tipologie:
• il sistema maggioritario, viene suddiviso in tante aree, dette collegi, quanti sono i canditati da eleggere. All’interno dei collegi, ciascun partito presenta un solo candidato. Risulta eletto soltanto colui che ottiene il maggior numero di voti (collegio uninominale);
• il sistema proporzionale, in base al quale i partiti presentano alle elezioni una lista di candidati. Gli elettori esprimono la loro preferenza per una lista ed eventuali voti di preferenza per candidati presenti nella lista. Ogni partito otterrà un numero di seggi proporzionale ai voti ricevuti.
I 2 sistemi presentano vantaggi e svantaggi. Il sistema maggioritario favorisce la semplificazione del sistema politico, garantendo la presenza nelle istituzioni solo nei partiti maggiori; il sistema proporzionale è democratico perché permette a tutti i partiti di essere rappresentati negli organi elettivi.
Per l’elezione del Senato e della Camera è stato introdotto un sistema maggioritario con correzione proporzionale; per i Comuni e le Province è stato introdotto il sistema maggioritario a doppio turno.
Democrazia diretta
Le forme di democrazia diretta
Il principale istituto di democrazia diretta è rappresentato dal referendum abrogativo: il popolo è chiamato a decidere se eliminare o meno un provvedimento legislativo. Con il referendum il popolo può abrogare o abolire una legge, ma non può modificarla.
Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i decreti legge e decreti legislativi; non è ammesso il referendum per l’amnistia e per l’indulto. La richiesta di referendum deve essere ottenuta da 5 Consigli regionali o da 500 mila elettori. La raccolta delle firme devono essere depositate presso la Corte di Cassazione.
Istituti di democrazia diretta sono: il diritto di petizione e l’iniziativa legislativa popolare. Per mezzo dell’iniziativa popolare il popolo può intervenire nella fase iniziale del procedimento di formazione delle leggi, inviando al Parlamento una proposta di legge.
3.
Partiti politici
I partiti politici
L’articolo 49 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto della libertà di associazione politica, che si concretizza nella possibilità di aderire o di costruire un partito politico.
Il sistema politico italiano prevede il pluripartitismo , cioè l’esistenza di diversi partiti. I partiti sono associazioni private non riconosciute. Essi svolgono funzioni importanti per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese: ogni partito formula un programma e designa i propri canditati per le consultazioni elettorali. Il partito che vince le elezioni formerà il Governo. In Italia a causa dell’elevato numero di partiti non è mai successo che un solo partito raggiungesse la maggioranza assoluta; di conseguenza, le varie forze politiche hanno sempre costituito governi di coalizione. Noi abbiamo una coalizione di partiti centro-sinistra, l’Ulivo, che comprende: i Democratici di sinistra, il Partito Popolare e i Democratici, i Verdi e i Socialisti Democratici Italiani. Abbiamo anche una coalizione di partiti centro-destra, il Polo delle libertà, che comprende: Forza Italia, Alleanza Nazionale, la Lega Nord, il Centro cristiano democratico e i Cristiani democratici uniti.
4.
Forme di governo
Le forme di governo
Con l’espressione forma ci si riferisce alle competenze e ai rapporti reciproci che si instaurano tra gli organi che si occupano delle funzioni dello Stato (legislativa, amministrativa e giudiziaria).
Esistono 2 forme di governo, la monarchia e la repubblica:
• nella monarchia il capo dello Stato è il sovrano; questa figura ottiene il potere per via ereditaria;
• nella forma di repubblica è il popolo a scegliere il capo dello Stato, il quale è un suo rappresentante.
La forma di governo repubblicana può assumere 3 diversi tipi di carattere: repubblica parlamentare, repubblica presidenziale e semipresidenziale.
• nella repubblica parlamentare il capo dello Stato viene eletto dal Parlamento, egli ha il potere di sciogliere il Parlamento e stabilire nuove elezioni. (sistema adottato in Italia);
• nella repubblica presidenziale il popolo elegge il capo dello Stato. Il Presidente è capo dello Stato e del Governo. (sistema adottato dagli Stati uniti);
• nella repubblica semipresidenziale ci sono degli elementi tipici della repubblica parlamentare e presidenziale. Il Presidente viene eletto dal popolo, partecipa alle riunioni del Governo e ha il potere di sciogliere il Parlamento. (sistema adottato in Francia).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del voto nei sistemi democratici?
- Quali sono i tipi di elezioni previste dalla Costituzione italiana?
- Quali sono le caratteristiche del voto secondo l'articolo 48 della Costituzione italiana?
- Quali sono le differenze tra il sistema elettorale maggioritario e proporzionale?
- Quali sono le forme di governo riconosciute e come si differenziano?
Nei sistemi democratici, il voto è lo strumento principale attraverso il quale i cittadini esercitano la sovranità popolare, eleggendo i propri rappresentanti per determinare l'orientamento politico dello Stato.
La Costituzione italiana prevede tre tipi di elezioni: politiche per il Parlamento, amministrative per gli enti pubblici territoriali, ed europee per il Parlamento europeo.
Secondo l'articolo 48, il voto è personale, eguale, libero e segreto, ed è considerato un dovere civico.
Il sistema maggioritario elegge il candidato con il maggior numero di voti in un collegio, mentre il sistema proporzionale assegna seggi in base alla percentuale di voti ricevuti da ciascun partito.
Le forme di governo riconosciute sono la monarchia e la repubblica, con quest'ultima suddivisa in repubblica parlamentare, presidenziale e semipresidenziale, differenziate dal modo in cui viene eletto e dai poteri del capo dello Stato.







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo