Concetti Chiave
- Luigi Pirandello, noto scrittore e drammaturgo, nacque ad Agrigento nel 1867 e visse tra Germania e Italia, affrontando anche difficoltà economiche e personali.
- La poetica di Pirandello si distingue per l'enfasi sul ruolo della riflessione e sul concetto di "sentimento del contrario", che porta a una comprensione più profonda del tragico oltre il comico.
- Superando il verismo, Pirandello propone una realtà interpretabile in molteplici modi, priva di un'unica verità assoluta, e indaga la crisi dell'uomo moderno oppresso da convenzioni sociali.
- Le opere teatrali di Pirandello, come "Enrico IV", esplorano temi di alienazione e relativismo, utilizzando il teatro per rappresentare lo "scontro" dei punti di vista.
- Romanzi come "Il fu Mattia Pascal" e "Uno, nessuno e centomila" affrontano la ricerca di identità e il senso dell'assurdo, con personaggi che si sentono estranei alla vita e alle aspettative sociali.
VITA - Nacque a Girgenti (Agrigento) nel 1867. Il padre gestiva una miniera di zolfo, la madre apparteneva a una famiglia di agiati commercianti. Compiuti gli studi liceali, frequenta la facoltà di lettere all’università di Roma, ma si laureerà a Bonn, in Germania. Sposa la compaesana Maria Antonietta Portulano, figlia di un socio in affari del padre (il matrimonio fu combinato dalle famiglie). Nel 1893 si trasferisce a Roma, dove dal 1897 al 1922 insegnerà stilistica italiana, dedicandosi anche all’attività letteraria.
Indice
Crisi Economica e Scelte Politiche
Nel 1904 una frana nella miniera di zolfo segna il tracollo economico della famiglia, cui segue una crisi nervosa della moglie. Nel 1924 compì un gesto ancora oggi difficile da motivare: dopo l’assassinio di Matteotti, quando non vi era dubbio che il fascismo sarebbe diventato regime, Pirandello, tramite una lettera pubblicata su L’Impero, chiese a Mussolini la tessera d’iscrizione al Partito Fascista. Tale gesto può essere dovuto alle idee patriottiche frustrate o alle comuni posizioni antidemocratiche del tempo; l’ambiguità però risiede nel fatto che non solo si sottrasse ad ogni responsabilità ufficiale e approfondì i suoi temi consueti, di stampo tutt’altro che fascista. Nel 1925 incontra Maria Abba, che poi diventerà l’interprete di sue opere teatrali. Per Pirandello fu necessaria la separazione fra vita e letteratura - La vita, o la si scrive, o la si vive; si oppose di fatto a D’Annunzio, fautore di quella estetistica contaminazione. Morì a Roma nel 1936.
Poetica e Umorismo di Pirandello
La produzione di Pirandello è molto vasta, ma per orientarsi nei motivi e nei temi assume grande importanza il saggio de L’umorismo (1908), fondamentale enunciazione di poetica e biografia intellettuale. In esso Pirandello polemizza con l’estetica, fondata sulla distinzione fra spirito e conoscenza, e valorizza invece il ruolo della riflessione: essa assiste al nascere e al crescere dell’opera, ne segue le fasi, ne accosta gli elementi, li compara e li analizza nell’insieme; la componente riflessiva è più obiettiva del sentimento. Altro caposaldo della poetica pirandelliana è il sentimento del contrario: esso permette di cogliere attraverso la riflessione la complessità del reale, di scinderne le componenti contraddittorie e di percepire cosa si cela sotto di esse (si va così oltre il fenomenico). Per spiegare ciò, Pirandello ricorre all’esempio di una vecchia signora con i capelli tinti, vestita goffamente con abiti giovanili: ad un primo sguardo farebbe ridere, perché una realtà del genere è comica. Ma riflettendo, si capirebbe che quella signora non prova alcun piacere a pararsi come un pappagallo, forse ne soffre, ma lo fa per trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei; ora non se ne può più ridere come prima, perché la riflessione ha operato spingendo oltre il primo impatto. La differenza fra comico e umoristico risiede proprio in questo, in un approccio diverso che consente di vedere il tragico al di là del comico.
Riflessione e Realtà in Pirandello
L’intervento della riflessione che coglie la molteplicità del reale si risolve in un superamento del principio verista secondo cui esiste una realtà oggettiva che è un dato di fatto da rappresentare; inoltre, introducendo una visione dialettica (non più statica) del reale, rappresenta una realtà oppostamente interpretabile, e dunque priva di una consistenza assoluta.
Costante riferimento in Pirandello è la Sicilia, e Girgenti in particolare. Tuttavia, a differenza del siciliano verista Verga, il quale mirava a mettere in luce i meccanismi sociali, Pirandello rappresenta la crisi dell’uomo moderno, attraverso il siciliano, oppresso da una società angusta, entro pregiudizi arcaici, insicuro e scettico per esperienza fallimentare.
PERSONAGGIO PIRANDELLIANO - Prima caratteristica del personaggio di Pirandello è quella di avvertire l’oppressione che valori e convenzioni esercitano sull’uomo, limitandolo nei comportamenti. In questa rete vischiosa, il personaggio si sente un “forestiere della vita”, estraneo ad essa, e si sottolinea perciò il valore fittizio delle impalcature sociali, che opprimono il singolo. Altro aspetto è la disperata ricerca di un senso all’assurdo del vivere. Mattia Pascal deve ricostruirsi un’identità dopo uno scherzo del caso, mentre Serafino Gubbio perde la sua e diventa un semplice ruolo (girare la manovella di una macchina da presa). Il fu Mattia Pascal - Pubblicato a puntate (1904) e in volume (1910), narra la vicenda di Mattia Pascal, ammogliato con Romilda Pescatore, costretto però a tenere in casa la suocera che gli rende la vita impossibile. Asfissiato da frustrazioni e difficoltà economiche, abbandona la famiglia e si imbarca per l’America, ma si ferma a Montecarlo, dove vince una cospicua somma al casinò. Decide dunque di tornare al paese, ma legge su un giornale la sua epigrafe, dovuta al suicidio di uno sconosciuto identificato con lui. All’iniziale indignata sorpresa, segue la gioia di poter ricominciare una nuova vita sotto il nome di Adriano
Meis; tuttavia, essendo privo di documenti, anche questa esistenza si profila difficile - è in questo senso un “forestiere della vita”. Torna allora al paese in qualità di Mattia Pascal, ma Romilda si è risposata e ha una bambina, e nel paese egli è ormai un estraneo; non gli rimane altro che vivere con una zia e un prete.
Quaderni di Serafino Gubbio, operatore - Riflessioni e vicende di un protagonista-narratore che lavora presso una grande casa cinematografica come operatore della macchina da presa. Il diario è un mezzo di sfogo e vendetta alla sua alienante condizione di subordinazione. Poi, il colpo di scena: un attore spara invece che a una tigre (come da copione) a un’attrice di cui era innamorato, e la tigre lo sbrana; muoiono entrambi. Serafino riprende tutto, ma per lo shock perde la parola e vive “muto spettatore della vita”.
Uno, nessuno e centomila - Romanzo pubblicato prima a puntate (1925-1926) e poi in volume (1926), narra le vicende di Vitangelo Moscarda: un giorno la moglie gli fa notare allo specchio che il suo naso pende a destra. Il banale avvenimento diventa per Vitangelo un’occasione di riflessione sull’infinita varietà di modi in cui può apparire agli altri (può essere uno, nessuno o centomila). Spinto da ciò, compie azioni che lo distaccano da famiglia e conoscenti, in una sorta di rinuncia alla vita. Dopo varie vicissitudini trova la risposta nella solitudine, e aspira a ridursi a un semplice elemento naturale, come una nuvola.
Teatro e Temi Ricorrenti
Nella produzione teatrale ritornano i temi di quella letteraria: solitudine esistenziale derivata da relativismo gnoseologico, oppressione dell’individuo dalle convenzioni e dalle “forme”, reciproco integrarsi di grottesco e pietà. Pirandello usa una forma abusata del teatro borghese, il triangolo lei, lui, l’altro, ma lo rende funzionale alla sua problematica. Inoltre, è sbagliato distinguere le fasi narrativa e teatrale, in quanto Pirandello è stato “costretto” ad approdare al teatro: l’umorismo narrativo si fondava essenzialmente sullo “scontro” dei punti di vista, e il genere più adatto per renderlo era appunto il teatro.
Enrico IV - Dramma in 3 atti, fu scritto nel 1921 e rappresentato nel 1922. Il protagonista è un giovane aristocratico che durante una festa in costume nei panni di Enrico IV (imperatore di Germania - 1077) batte la testa e da quel momento crede di essere davvero l’imperatore. I parenti si operano a trasformare la sua vita in quella di imperatore (reggia, servitori, valletti) ma quando riacquista la ragione 12 anni dopo, scopre che l’amata Matilde Spina è diventata l’amante di Belcredi, che aveva provocato la famosa caduta da cavallo. Per ripicca, Enrico IV decide di restare pazzo, e guarderà la vita “da fuori”, da esiliato. Una sera a 20 anni dalla festa, Belcredi, Matilde e la figlia Frida arrivano alla villa, e un medico, per guarire Enrico IV mediante un altro schock, mette Frida travestita da Matilde al posto del dipinto che la raffigurava, e quasi Enrico IV impazzisce di nuovo. Poi rivela che in realtà è guarito da anni, e quando tenta di abbracciare Frida, Belcredi gli si oppone violentemente, perciò Enrico IV lo trafigge con la spada. Non gli resta che fingersi di nuovo pazzo, condanna e unico modo di restare esiliato e libero dalla realtà.
Il sentimento del contrario - Si chiarisce il concetto di “umorismo”: la riflessione interviene durante tutte le fasi di un’opera d’arte e le compara. Essa non si nasconde, si pone innanzi al sentimento, svuotata di passione, e lo analizza. Segue l’esempio della signora dai capelli tinti per separare comico da umoristico.
Flusso della Vita e Forme
La vita, un flusso continuo che investe le forme statiche - La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo di fermare in forme statiche e determinate, fino a quando il movimento, sempre più irrigidito, non si arresta. Tuttavia, in momenti particolari - “tempestosi”, tutte le “forme” crollano miseramente: l’anima si spoglia di tutte le finzioni del quotidiano, rivelando un’esistenza che ci appare priva di significato. A quel punto, noi cerchiamo di riacquistare la nostra razionalità, ma di essa non possiamo più fidarci, perché sappiamo che c’è altro sotto. Ciò che si stacca dal flusso della vita si cristallizza e diventa “forma”: questa è una “maschera” della vita, sotto di essa la nostra identità è negata, subordinata alla società, al collettivo.
L’uomo serve per la macchina - Nato in età giolittiana (1913) il cinema italiano era visto dai letterati in maniera ambigua: da una parte assicurava guadagni più rapidi e più cospicui, dall’altra significava una subordinazione dell’uomo alla macchina, dunque un’alienazione, una riduzione a “cosa”. In questo testo Serafino annota alcune riflessioni che valgono come sfogo e vendetta personale contro la vita alienata.
Attenti, si gira... - Al termine del romanzo, avviene un colpo di scena: l’attore uccide l’attrice di cui era innamorato al posto della tigre, come invece voleva il copione: qui appare un tema-chiave di Pirandello:il contrasto tra forma e vita. L’attore deve compiere il gesto (uccidere la tigre) previsto dal copione, che dunque lo condiziona, ma la vita (amore, gelosia, vendetta) irrompe in modo imprevedibile, mandando in frantumi ogni prospettiva e provocando serie conseguenze nell’estraniato Serafino Gubbio.
Identità e Malessere Interiore
La moglie di Vitangelo Moscarda fa notare al marito un particolare del naso che innesca in lui un malessere interiore, inteso come necessità di definire una propria identità e di rispondere alla domanda “Chi sono?” per sé e per gli altri. “Una conclusione” in realtà “Non conclude”, perché poiché la vita, il flusso di Vitangelo non è ancora concluso, perciò non può esserne data una definizione.
Enrico IV per sempre - Enrico IV, pur guarito dalla pazzia anni addietro, decide di continuare a fingersi pazzo (e di restare alienato) per reazione all’amore di Matilde con Belcredi. Gli sviluppi della scelta però sono imprevedibili: il medico cerca di guarirlo con un secondo shock e alla fine Enrico IV ucciderà Belcredi.
Domande da interrogazione
- Qual è stato l'evento che ha segnato il tracollo economico della famiglia di Pirandello?
- Come Pirandello definisce il concetto di umorismo nella sua poetica?
- Qual è la caratteristica principale dei personaggi pirandelliani?
- Qual è il tema centrale del romanzo "Uno, nessuno e centomila"?
- Perché Enrico IV decide di continuare a fingersi pazzo?
Nel 1904, una frana nella miniera di zolfo gestita dal padre di Pirandello ha segnato il tracollo economico della famiglia, seguito da una crisi nervosa della moglie di Pirandello.
Pirandello definisce l'umorismo come un approccio che, attraverso la riflessione, permette di cogliere la complessità del reale e di vedere il tragico al di là del comico, come illustrato nell'esempio della vecchia signora con i capelli tinti.
I personaggi pirandelliani avvertono l'oppressione dei valori e delle convenzioni sociali, si sentono "forestieri della vita" e sono in una disperata ricerca di senso nell'assurdo del vivere.
Il tema centrale del romanzo è la riflessione sull'identità e la percezione di sé, in cui il protagonista Vitangelo Moscarda si interroga su come appare agli altri, portandolo a distaccarsi dalla vita sociale.
Enrico IV decide di continuare a fingersi pazzo per reazione all'amore di Matilde con Belcredi e per restare esiliato e libero dalla realtà, nonostante sia guarito dalla pazzia anni prima.

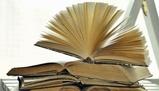





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo