Concetti Chiave
- Il Principe di Machiavelli analizza le diverse tipologie di principato e le linee guida di governo, enfatizzando l'importanza della forza e del decisionismo politico.
- Machiavelli esalta la virtù del principe, ma sottolinea che il successo dipende anche dalla fortuna e dalle circostanze favorevoli.
- L'opera analizza come il potere possa essere acquisito attraverso atti di crudeltà, ma sottolinea la necessità di alleanze e consenso.
- Nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Machiavelli esplora la politica interna ed estera della Repubblica romana, preferendola al principato.
- Machiavelli distingue chiaramente tra politica e morale, promuovendo l'osservazione della verità effettuale come principio fondamentale della politica rinascimentale.
Indice
Struttura e Temi de Il Principe
Il Principe è formato da ventisei capitoli ed è piuttosto breve. Ha una compattezza espositiva straordinaria. Si possono sottolineare alcuni nuclei tematici fondamentali. Dal primo capitolo all’undicesimo avviene la classificazione delle tipologie di principato e indicazione sulle linee di governo che il principe deve seguire. In Machiavelli non c’è enciclopedismo e ci si sofferma sui particolari. L’ambito di analisi deve essere circoscritto così come avviene negli studi tipici dello scienziato.
Analisi del Principato Nuovo
Dal terzo al quinto capitolo, Machiavelli prende in analisi il principato nuovo, cioè quello slegato dall’ereditarietà. Da notare è il concetto dell’esercizio della forza che è visto come una prassi politica positiva. Machiavelli esaltò il giusto decisionismo, il quale può portare a un uso spregiudicato di mezzi estremi, ma non c’è un autocompiacimento della violenza in quanto tale. In questa parte dell’opera si può notare come Machiavelli fondi le sue considerazioni e le leggi universali della politica su exempla illustri che provengono dal passato, soprattutto dal mondo romano. Le leggi politiche sono universali perché Machiavelli sposa quella concezione secondo cui l’uomo è inserito perfettamente nella natura, così l’agire politico è naturale.
Virtù e Fortuna nel Principato
Dal sesto al nono capitolo Machiavelli affronta la tipologia del principato nuovo che si forma senza una base di potere preesistente. Questo principato è un’occasione per esaltare le virtù del principe. Nel sesto capitolo Machiavelli affrontò il principato conquistato con armi proprie. Nel settimo capitolo si descrive il principe che acquista il potere con la fortuna e il sostegno di altri. In questo capitolo il più grande esempio di principe che raggiunge il potere con i mezzi altrui è rappresentato da Cesare Borgia. Secondo Machiavelli però il Valentino non fu abbastanza lungimirante perché, una volta eletto papa Giulio II, conobbe un irrimediabile declino. Lo scrittore fiorentino cercò di dimostrare che se non si seguono le indicazioni da lui chiarite non si può essere un vero principe e si va incontro al declino. La virtù del principe è importante, ma non sufficiente. Osservando degli esempi del passato, Machiavelli esaltò la capacità di guardare con attenzione al contesto storico in cui si vive. Gli elementi fondamentali che garantiscono il successo del principe sono la virtù, la fortuna e la circostanza favorevole. Nell’ottavo capitolo vengono analizzate le situazioni in cui il potere venne raggiunto attraverso atti di crudeltà. Questa parte fu una delle più discusse perché Machiavelli non condanna moralmente le scelleratezze compiute, ma sostiene che crimini e crudeltà sono strumenti dell’agire politico. Machiavelli chiarì che c’è una sospensione del giudizio etico perché bisogna scegliere quale sia la prassi politica più funzionale. Disse anche che un buon principe non può governare solo con mezzi cruenti perché c’è anche bisogno di alleanze e consensi. Nel nono capitolo si esamina il caso di coloro che arrivano al potere grazie al consenso popolare.
Critica delle Milizie Mercenarie
Dal dodicesimo al quattordicesimo capitolo, Machiavelli affronta i problemi interni dello stato. Nel quindicesimo capitolo descrive le qualità del principe. Riprende il tema della forza, ma viene questa volta letto nell’ambito dei rapporti tra stati. Secondo Machiavelli la questione militare è fondamentale per uno stato. Le truppe sono espressione del potere del principe. Viaggiando per l’Europa, Machiavelli capì l’importanza dell’esercito e così criticò duramente le milizie mercenarie. Criticò il ricorso a truppe ausiliarie e affermò che una vittoria conseguita con truppe ausiliarie non contribuisce a rafforzare il potere del principe, ma anzi lo sminuisce. Per Machiavelli “senza armi nessuno stato è securo”. Nel capitolo quindicesimo si può scorgere la differenza tra il Principe e gli Specula principis perché non c’è un’elencazione di virtù ideali, ma solo una descrizione realistica delle regole comportamentali attraverso continui riferimenti a esempi del passato. Nei capitoli successivi procede la riflessione sul codice comportamentale del principe. La magnanimità e la liberalità erano i migliori comportamenti cortesi. Machiavelli invece sottolineò l’importanza della parsimonia, che si scontra con la liberalità, della crudeltà, che si oppone alla mansuetudine, e dell’ipocrisia, che si contrappone all’onestà. Interessante è il ventiquattresimo capitolo, in cui Machiavelli esaminò le ragioni per cui i principi italiani avevano perso i loro stati: essi infatti non si erano preoccupati di gettare delle solide fondamenta politiche al loro potere, favorendo così un governo pressappochistico.
Fortuna e Eroismo Machiavellico
Il capitolo venticinquesimo è un’esortazione conclusiva che si distingue per l’esaltazione della fortuna. Per Machiavelli la fortuna è responsabile per metà delle nostre azioni. Il contrasto tra virtù e fortuna rimase aperto e Machiavelli lo risolse enfatizzando una concezione eroica dell’uomo in cui si esaltavano le qualità umane. L’uomo ha sempre di fronte a sé il problema della fortuna che deve essere affrontato con uno slancio di eroismo. Nel ventiseiesimo capitolo lo scrittore fiorentino esorta la casa medicea a prendere in mano la situazione italiana e a cacciare gli stranieri. Il quadro che Machiavelli dà dell’Italia è pessimistico. Nell’ultimo capitolo ritorna l’eroismo machiavellico. Egli ha una visione pessimistica e quindi esalta le virtù eroiche di cui c’è assoluto bisogno. Il Principe termina con la canzone di Petrarca intitolata Italia mia.
Discorsi e Repubblica di Machiavelli
I primi dieci libri di Tito Livio sono quelli relativi alla res pubblica romana. I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio nacquero dall’analisi di alcuni appunti in possesso di Machiavelli. Vennero stampati postumi nel 1531 e nei primi anni ne circolarono solo opere manoscritte. I Discorsi sono basati sul principio di lettura del passato per risolvere i problemi del presente. Nel primo libro si parla della politica interna, nel secondo si discute su quella estera, mentre nel terzo avviene l’analisi dei grandi cittadini della res pubblica romana che hanno contribuito alla sua grandezza. Il Principe ha la precisa struttura del trattato politico, mentre i Discorsi sono una raccolta disordinata di riflessioni. Un’altra riflessione è rappresentata dal fatto che nel Principe si parla di principati, mentre nei Discorsi Machiavelli svela la sua vera passione politica, che è la repubblica. Per Machiavelli la repubblica è la migliore forma di organizzazione statale. L’ideale politico di Machiavelli si rivela nei Discorsi. La repubblica garantisce pace, stabilità e maturità civile dei cittadini. Machiavelli non è un cultore dell’autoritarismo. L’analogia principale tra le due opere è rappresentato dal metodo di analisi.
Pensiero Politico e Verità Effettuale
Per quanto riguarda il pensiero politico di Machiavelli, una sua caratteristica è la consapevolezza del suo tempo. La situazione politica italiana mostra evidenti sintomi di decadenza. Una conseguenza è la crisi militare italiana. Secondo Machiavelli sono decaduti anche i valori civili, come accadde nella Roma tardo-repubblicana. I mali dell’uomo cinquecentesco sono l’egoismo, la chiusura in se stesso e lo scetticismo, che negano lo slancio eroico. Machiavelli era consapevole che la linea di demarcazione tra la politica e la morale era molto sottile perché entrambe si preoccupano dell’agire dell’uomo. La politica però è differente dalla morale e quindi deve rivendicare delle leggi proprie e un’autonomia concettuale. I fini politici sono diversi da quelli morali. La politica deve occuparsi di ciò che storicamente si è realizzato, non deve parlare di stati ideali. Il principio fondamentale della politica è l’osservazione della verità effettuale, che consiste nella consapevolezza di ciò che avviene realmente. Dall’osservazione della verità effettuale derivano le leggi politiche. Il procedimento passa da un esempio pratico a una legge desunta da esso, e non il contrario come avveniva nel Medioevo quando da una legge assolutamente vera si pretendeva di giudicare la realtà. Questo ribaltamento fu uno dei più grandi principi rinascimentali che caratterizzò il pensiero di Machiavelli e la rivoluzione scientifica. Il pensiero di Machiavelli è fondato sulla propria esperienza personale, su quella di altri e su quella degli antichi. Machiavelli concepiva l’uomo come costante in tutta la storia e così il pensiero dei contemporanei era equivalente a quello degli antichi. Machiavelli però non era affatto antistorico.
Domande da interrogazione
- Qual è la struttura principale de "Il Principe" di Machiavelli?
- Come Machiavelli vede il ruolo della forza nel principato nuovo?
- Qual è l'importanza della virtù e della fortuna secondo Machiavelli?
- Perché Machiavelli critica le milizie mercenarie?
- Qual è la visione di Machiavelli sulla politica e la verità effettuale?
"Il Principe" è composto da ventisei capitoli e si distingue per la sua compattezza espositiva. I primi undici capitoli classificano le tipologie di principato e le linee di governo che un principe deve seguire.
Machiavelli considera l'esercizio della forza come una prassi politica positiva nel principato nuovo, esaltando il giusto decisionismo e l'uso spregiudicato di mezzi estremi, senza autocompiacimento della violenza.
Machiavelli sottolinea che la virtù del principe è cruciale ma non sufficiente. Il successo dipende anche dalla fortuna e dalle circostanze favorevoli, come dimostrato dagli esempi storici.
Machiavelli critica le milizie mercenarie perché ritiene che non contribuiscano a rafforzare il potere del principe e che uno stato non possa essere sicuro senza un esercito proprio.
Machiavelli crede che la politica debba basarsi sull'osservazione della verità effettuale, cioè su ciò che avviene realmente, piuttosto che su stati ideali, distinguendo così la politica dalla morale.

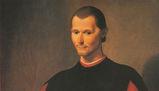





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo