Concetti Chiave
- Leopardi si distingue nel panorama romantico italiano con una visione antiromantica, proponendo un distacco dalla storia e dalla politica nella poesia, influenzato dalle sue radici illuministiche e neoclassiche.
- Le fasi della vita di Leopardi, dall'infanzia alla maturità, mostrano un'evoluzione dal "bello" al "vero", integrando razionalismo e sensibilità poetica, culminando in opere come "L'infinito" e "I Canti".
- Il rapporto tra uomo e natura in Leopardi evolve da una simbiosi a uno scontro, con la natura vista come matrigna e la ragione come una madre ambigua, riflettendo un pessimismo storico e cosmico.
- Le "Operette morali" di Leopardi, influenzate da Luciano di Samosata, combinano satira e riflessione filosofica, anticipando il pessimismo cosmico e criticando l'antropocentrismo e le illusioni umane.
- Nelle "Canzoni Pisano Recanatesi", Leopardi esplora il connubio tra ricordo e verità, con testi come "A Silvia" e "La Ginestra" che riflettono un ritorno alla poesia filosofica e un impegno sulla solidarietà umana.
LEOPARDI
Indice
- Il Romanticismo in Italia
- Leopardi e l'Illuminismo
- I Canti di Leopardi
- Operette Morali
- Canzoni Pisano Recanatesi
- A Silvia
- Confronto tra Quiete Dopo la Tempesta e Sabato del Villaggio
- La Quiete Dopo la Tempesta
- Sabato del Villaggio
- Le Ricordanze
- Canto Notturno di un Pastore Errante nell'Asia
- Ciclo di Aspasia
- Amore e Morte
- A Se Stesso
- La Ginestra
Il Romanticismo in Italia
Se si osservano le caratteristiche del romanticismo che nasce in Inghilterra e in Germania intorno al 1798, si nota come esso raggiunga le sue forme più estreme, negli altri stati invece sviluppa e continua alcuni elementi dell'illuminismo, come si vede in Italia, tenendo a volte una forte componente di realismo. In definitiva quindi in italia il romanticismo stesso si diversifica in:
Primo filone oggettivo: si riconosce in generi aperti al pubblico e di ampio respiro (Romanzo)
Filone soggettivo: nonostante manzoni proponga una lirica oggettiva (innografia) la lirica diventa ben presto espressione della soggettività.
--> 3romanzi che scrissero i manifasti del romanticisimo nel 16 :di Breme, Borsieri e Berchet.
Leopardi e l'Illuminismo
Leopardi giovanissimo interviene nel dibattito affermando che la poesia non deve tener conto della storia e della politica, stando fuori dalle sue contingenze;proponendo quindi un'idea antiromantica dovuta in parte al limitato materiale di riflessione che ha per la sua vita isolata:
- Illuminismo: La sua formazione basatasi sull'illuminismo francese lo porta ad assumere come ideoloia di riferimento l'ateismo, la ragione e il razionalismo --> questo mettere la ragione come centro del pensiero è tipico dell'illuminismo.
- Neoclassicismo: crede che l'uomo come gli antichi debba vivere secondo natura, riprendendo il tema dell'età dell'oro in "delle favole antiche" e "dei patriarchi".
-Unico elemento Romantico: Il suo modo di adattare la forma al contenuto. Interviene inoltre in dibattiti in atto nel suo paese anche con canzoni politiche scritte nel 18 e continuate fino al 20 (All'italia", "ad Angelo Mai", "sopra il monumento di Dante")--> il modello è Petrarca.
Presto la visione che L. ha della ragione si capovolge, non è infatti un autore monolitico ma molto complesso.
FASI LEOPARDIANE
-I FASE, L'INFANZIA : ce la racconta attraverso due documenti fondamentali: le lettere, alla sorella Paolina o agli intellettuali del tempo e lo Zibaldone (iniziato nel 16 che lo accompagna per tutta la sua vita --> pensieri e commenti alle poesie).
- Nel 16 ha avuto un cambio " dall'erudizione al bello ". Si converte quindi alla letteratura e allo scrivere in versi .
-Negli anni successivi (19) si è convertito "dal bello al vero ", aderendo quindi agli ideali illuministi. In questa fase tuttavia c'è un'integrazione di vero e bello, che non viene quindi messo da parte. In questo periodo scrive l'infinito gli idilli e ha una forte crisi fisica e con la famiglia.
-dal 16 al 20 sviluppa delle teorie a proposito della sua ideologia di riferimento e della poesia in essa contenuta, all'interno dello zibaldone.
- Nel 22-23 fa il viaggio a Roma, primo vero distacco da recanati e spartiacque della vita del poeta.
EVOLUZIONE RAPPORTO UOMO-NATURA
MATERIALISMO LEOPARDIANO : l'uomo è anello di una catena-->inizialmente l'uomo era in simbiosi con la natura , mano a mano che il progresso e la ragione vanno avanti questo legame si spezza (pessimismo storico) e i ruoli si scambiano : la natura diventa matrigna e la ragione madre. La ragione è al tempo stesso dannazione e elemento di distinzione tra l'uomo e gli altri esseri viventi . Per ripristinare il legame bisogna vivere attraverso l'immaginazione: i moderni non ci riescono più tranne che in alcune rare occasioni. l'illuminismo di Leopardi quindi è ambiguo, anche se lo ritroviamo totalmente nel materialismo. Sul finire di questa fase Leopardi vede incirnarsi questo suo pensiero. Il rapporto tra mondo antico e natura si va a rompere definitivamente nell'ultimo canto di saffo, anticipato da dialogo della natura e di un islandese.
ZIBALDONE
- teoria del piacere (165-172) : Leopardi si chiede il perchè dell'infelicità dell'uomo. Ritiene inizialmente che essa sia una condizione particolare dialcuni uomini, quelli che ragionano di più. Il piacere risulta irrealizzaile, nella visione sensista di Leopardi l'uomo è felice solo quando tutti i suoi sensi saranno appagati contemporaneamente e tale circostanza è impossibile. -->questo pessimismo storico e psicologico diventerà cosmico. Punto di passaggio dei due pessimismi : dialogo della natura e di un islandese. Quando scrive il passo dello zibaldone Leopardi è già nella fase degli idilli . "l'anima umana mira unicamente al piacere ossia alla felicità ". L'uomo tende quindi verso il piacere infinito. L'uomo non esisterebbe se non provasse questo desiderio. Si fa strada il pensiero dell'immaginazione: quando desideriamo una cosa ci sembra di desiderarla davvero ma in realtà desideriamo il piacere che in quel momento di appunta su quella cosa particolare. La Natura (ancora concepita almeno in parte come madre) ha fatto in modo di fornire dei surrogati per il piacere. In quest'ottica per Leopardi la condizione più felice è quella del fanciullo perchè non è ancora stato subissato dalle regole --> la cognizione del vero blocca l'immaginazione. Come anche l'immaginazione , la poesia deve tendere al vago e all'indefinito (Omero è il grande poeta dell'immaginazione, ancora il modello dell'antico). L'unico modo per raggiungere il vero piacere è con la vaghezza che scatena i sensi e le percezioni.
- Tema del vago e dell'indfinito per rimembranze della fanciullezza (514-516) : l'idea si basa sulla completezza dell'esperienza, i fanciulli (con una capacità di immaginazione maggiore) provano sensazioni in maniera più alta. Altro elemento fondamentale della poetica leopardiana -->rimbembranza, ricordo, che ha la funzione di proiettare nel passato e permette pià altre facoltà di creare sensazioni alte seppur vaghe e indefinite e lontane nello spazio. L'idea di infelicità del mondo antico appare solo con l'ultimo canto di Saffo .
- L'antico (1421): la lontananza che hanno determinate epoche e la mancanza di confini tra esse è ciò che rende l'antico indefinito. Dove ho più indeterminatezza ho più piacere in quanto la lontananza estende il piacere.
- "l'infinito" (1430-31) : Sul gioco di contrasti finito-indefinito si basa tutto l'idillio -->l'indefinito a livello spaziale causa la sensazione del perdersi
-Il presente (1521-22) : il presente è visto in maniera negativa perchè contingente e costringe a viverlo e blocca l'immaginazione.
- Teoria della visione (1744-1747) : Leopardi ci fa vedere come applicare quella teoria traducendola in immagini . Parla di situazioni in cui la luce crea l'effetto di luceombra ma anche il vasto, non percepibile interamente, da il senso di infinito.
- Teoria del suono (1927-1930) : così come le immagini anche i suoni di ciò che non si vede... (...)
- immagini e parole poeticissime (1789-1798) : Leopardi ci da delle indicazioni rapide su come usare un certo lessico per produrre piacere: spiega quali sono gli elementi che giustificano queste scelte
-La doppia visione (4418) : applicare la facoltà dell'immaginazione per vedere altro di fronte ad un oggetto sensibile è detta doppia vista . Il poeta sa dilatare l'elemento sensibile e renderlo prima intefinito e poi poetico attraverso il linguaggio appropriato.
I CANTI
I Canti di Leopardi
Le sue migliori opere in versi, secondo lui. Sono tutte composizioni poetiche non divise per generi. L. equipara infatti il canto a quello di un usignolo--> si tratta di espressione diretta dello spirito in versi. La prima elencazione ne conteneva 23 e uscì nel 31, ma ne uscirono varie riedizioni (l'ultima postuma nel 45).
1-9 : Leopardi inserisce in ordine cronologico tutte le canzoni scritte dal 18 al 22, prima le politiche poi le filosofiche.
10 : il primo amore, datato nel 17: la prima opera poetica dedicata ad un suo sentimento o stato d'animo.
11: il passero solitario scritta nel 31. la 10 e la 11 vengono messe insieme perchè il primo amore lo mette in una condizione di solitudine esistenziale identificata nell'11, il solipsismo che introduce gli idilli anche se a posteriori.
12-16: gli idilli. Il suo senso di solitudine lo fa sentire diverso dagli altri, si riappropria del senso di collettività solo negli anni del pessimismo cosmico, quando esce da Recanati. Negli idilli scrive le sue sensazioni emozionali.
Nella parte nuova ci sono gli unici testi che L. scrive nella fase del silenzio poetico: "alla sua donna" (18) "Al conte carlo pepoli" (19)
20-25 --> 6 canzoni pisano recanatesi (2a fase leopardiana)
26-29 : ciclo di Aspasia
30-34 : 2 canti di morte, forte spirito sarcastico e caustico contro i leader della società del tempo. Importante l'impegno nel lasciare una testimonianza forte e costruttiva, annullando i miti che la società si fa.
35: la ginestra (testamento spirituale di L)
Ultimi testi (in Appendici) "esperimenti poetici", testi che non si riesce a inquadrare.
Canzoni dedicate a Dante e Angelo Mai --> leopardi si fa la sua idea di Italia che è tale per radici culturali comuni
"Alla primavera" e "Inno ai patriarchi" --> tema dell'antico. Il discorso è sviluppato nel mondo classico, afferma che gli antichi vivevano con un senso di immaginazione.
"Nozze della sorella Paolina", "A un vincitore nel gioco del Pallone", temi della virtù degli antichi.
"Bruto minore", "ultimo canto di saffo" Concepisce l'idea del suicidio e proietta una risposta negativa all'infelicità della vita con due persone nel mondo classico : è un suicidio eroico di protesta, anticipa il titanismo preromantico.
- ULTIMO CANTO DI SAFFO: è il primo esempio di canzone libera leopardiiana anche se il metro non è ancora del tutto libero. L'uso della parola canto non indica un genere ma "i tristi e cari moti del cuor". In questa proiezione di se il poeta esprime vari stati d'animo : 1) di nuovo l'immagine lunare, 2) inizia con immagini dilettose e chiude con immagini tetre 3)fino al verso 18, immagini di naura in tempesta (sturm und drang). Il suicidio di Saffo è per una natura ingiusta che ha dato un corpo degorme a un animo tanto nobile, che la porta ad essere estranea a tutte le cose belle, come la natura della quale si sente rifiutata. SI suicida perchè non accetta la situazione di marginalità. Anche classicamente un corpo brutto con un grande animo è un errore, secondo la kalokagatia. Il testo adotta il linguaggio di Saffo, termini aulici e immagini classicheggianti ma anche frasi ardite e lapidarie. C'è oscillazione di un linguaggio del vero e dell'immaginazione dando un senso alla vita di Saffo con frasi lapidarie e linguaggio alto. Qualsiasi siano le virtù da un corpo brutto non emergeranno mai . La risposta a tutto questo è solo la morte, non una morte passiva ma di protesta. Il tema portante è la fanciullezza, tempo delle illusioni, poi subentra la malattia. Contrapposizioni come al di di festa.
IDILLI
Leopardi stesso li chiama così rifacendosi all'idillio ellenistico,ispirandosi in particolare a Mosco e Dione.L'idillio è un quadretto, una piccola descrizione da cui prende spunto. Questo genere è spesso stato considerato un genere realistico. Leopardi è agli antipodi di ogni idea realistica e ne vuole fare una visione dell'animo. Somiglia per certi sensi al sonetto ma L. con le sue scelte segna il passaggio alla lirica moderna rivedendo alcuni generi classici e modificandoli, usando sopratutto la canzone. La riforma Leopardiana modifica la canzone sullo schema di Petrarca in maniera progressiva. L'apice della modifica è nel '28 la canzone "a Silvia" applicando in maniera totale la canzone libera leopardiana (libera la strofa, il verso, la struttura).Il tipo di poetica è romantica: suo malgrado L. si allontana sempre di più da una visione classicista dell'arte.
- INFINITO: fu composto nel 1819 e al centro ci sta l'esperienza del poeta che infatti parla in prima persona. Tale esperienza si traduce in un processo unitario articolato in 2 momenti (struttura bipartita dal punto di vista contenutistico e metrico, a metà del componimento c'è un punto alleggerito da una sinalefe).Entrambe le parti partono da un momento preciso sul piano temporale. L'esperienza vissuta dallo stesso io che è al centro del discorso supera il dato sensibile e va verso la percezione dell'infinito.La siepe costituisce il primo momento e colpisce sul piano spaziale i sensi, il primo attimo di smarrimento viene superao nell'immaginare OLTRE la siepe, tale immaginazione costituisce il secondo momento di smarrimento. Mentre l'io è proiettato in questo infinito spaziale subentra l'udito, una nuova sensazione. L. fa un ragionamento per analogia e concepisce attraverso il piano temporale il rapporto tra contingente e passato, facendo quindi un salto e arrivando a concepire l'eterno ovvero l'infinito sul piano del tempo. Lo spavento iniziale viene sostituito dall'abbandono -->il naufragio è il momento di massima catarsi . Va alla deriva di tutto ciò che è ragione e esperienza sensoriale. Le scelte lessicali sono studiatissime. 1) uso dei determinativi: nel momento in cui l'esperienza diventa ultrasensibile la siepe diventa "quella" fino alle ultime righe nelle quali si capisce ceh non c'è più uno iato tra esp. sensibile e sovrasensibile si torna al determinativo "questo". 2)INTERMINATI SOVRUMANI INFINITO indicano l'infinito tutti soffissi che traducono la parola nel suo contrario indefinito. Le due sensazioni sono integrate e complementari --> naufragio: perfecta sintesi delle sensazioni sul piano spaziotemporale nel passaggio dall'esperienza sensibile e soprasensibile. Gli elementi del paesaggio sono scarni e stilizzati , l'interiorità invece viene resa in maniera particolareggiata. Sul piano ideologico e psicologico le premesse sono elementi filosofici (sensismo, materialismo, teoria del piacere).
- LA SERA AL DI' DI FESTA: molto diversa dall'infinito non la c'è una soluzione di continuità.Abbiamo dei richiami interni sul piano metrico . La prima parte è un racconto di un esperienza biografica mentre la seconda è più riflessiva. "tu dormi" ripetuto due volte viene contrapposto con il " non io " del poeta, escluso da ogni attenzione della donna amata. L'esperienza diretta viene filtrata da una serie di rimandi letterari . Inizialmente c'è un gioco iniziale di luce e ombra (calco omerico dell'iliade--> filtro letterario per dilatare l'esperienza e renderla più astratta e indefinita). La luna è immagine ricorrente in L. ora è simbolo di natura pacificante, quiete. Ie luci e ombre del paesaggio danno sensazioni vaghe e indefinite e per questo piacevoli --> la donna è integrata in questa sensazione di piacere il poeta ne è escluso. L'angoscia personale in cui si esprime la sensazione di esclusione che proietterà in Saffo il passaggio alla seconda parte amplia il ragionamento non più visivamente ma tramite l'udito --> un canto dell'artigiano che fischietta, simbolo che tutto passa e si ripete; al porto del dì festivo arriva il giorno di lavoro. La chiusura è un ritorno ad un tema memoriale, sensazione di dolore inconscia già provata da giovane-->ricordo fondamentale a scopo conoscitivo.L'ultima parte si relaziona all'ultima in una riflessione amplificata sul tempo eterno, lo steso dolore provato nel piccolo nella prima parte viene potenziato per essere inserito nel contesto universale. VEDI OPINIONE DI BLASUCCI.
OPERETTE MORALI
Operette Morali
Leopardi si reca a Roma di cui ci resta testimonianza nell'epistolario. Riceve una delusione quella che lui credeva fosse una situazione particolare dovuta a una contingenza (vivere a Recanati) è invece universale --> si sente estraniato, un concetto anticipato nell'ultimo canto di Saffo . Si dedica quindi alla prosa, non legandosi al sentimento ma alla ragione. Fino al 26 scrive opere satiriche, le operette morali. Il modello è Luciano di Samosata (che già nella sua poetica aveva scardinato valori politici, culturali e religiosi) che viene però rielaborato pur mantenendo lo stile dissacratore. L'ottica è moralistica e didattica nonostante la ragione (sempre più madre) scardini le false credenze. La veste fantastica viene mantenuta ed espressa al pieno nella parola operette. Vi è una scelta poetica e stilistica basata sull'invenzione e sul sogno con una forte componente pessimistica. la maggior parte delle operette sono scritte nel 24 , poi c'è il silenzio poetico, infine L ricomincia a scrivere nel 27. La maggior parte dei dialoghi prepara il pessimismo cosmico del dialogo della natura e di un islandese, fase in cui Leopardi abbandona totalmente ogni speranza.
- In "Dialogo di Tristano e di un amico " ci sono immagini di grande sofferenza molto caustiche in nome di una ragione che vuole scardinare ogni struttura. il tono è antifrastico ma l'ironia è una sorta di autoironia (Tristano=Leopardi). L. se la prende con tutti i punti di riferimento e attraverso Tristano finge di ritrttare tutto ciò che dice nel libro.
- "Dialogo della natura e di un islandese". Temi : contestazione dell'antropocentrismo dell'uomo, natura e uomo (vi è una domanda di senso, l'uomo è simbolo di specie, Leopardi sceglie spesso persone ai confini della terra come l'islandese e il pastore errante), contro il teologismo. L'uomo non chiede di essere felice ma la cessazione del dolore. La natura afferma che l'uomo è solo parte di un ingranaggio che prescinde totalmente dall'uomo. L'esistenza è fatta dell'intera realtà cosmologica. Si esprime l'idea del ciclo vitale meccanicistico: conservaizone della natura in sè. Ultima domanda : a che giova, qual'è il fine ultimo di questa infelicità universale che non aiuta nessuno? Secondo L. non esiste risposte. La fine è fiabesca e ironica --> la natura irride alla volontà di conoscenza dell'uomo che però non ha risposta. I 2 leoni -->ti mangiano per prolungare la loro vita per un giorno: la risposta è il ciclo vitale.Il vento-- la vita dell'uomo va inserita in un circolo vitale che appartiene ad un ordine cosmico di cui l'uomo è parte ma non conta nulla, arriviamo quindi all'opposto dell'antropocentrismo, l'uomo è anche irrimediabilmente infelice per natura all'interno di questo circolo che provoca solo dolore.
NUOVA SVOLTA DEL PENSIERO LEOPARDIANO CHE FA RINASCERE LA POESIA
--> il suo aiuto contro la miseria (gli tagliano i viveri( sono i romantici fiorentini del gabinetto di Viessè, che lo aiutano a girare l'italia --> Antonio Ranieri, suo amico, lo ospita a Napoli dove muore.Punto di svolta--> recupera una dimensione meno negativa. Il passaggio è preparato da un operetta morale "Dialogo di Plotino e Porfirio": Siamo nel 27, L. sceglie due filosofi entrambi neoplatonici del III sec. Trattano del tema del suicidio nelle enneadi di plotino si affronta un'origine storica di questo discorso. Importante è il discorso finale di Plotino : la natura ci ha fatto per essere infelici ma per medicare la nostra infelicità ce l'ha in parte nascosta (mediazione tra natura madre e natura matrigna). Quel senso di fastidio della vita che proviamo non è però costante: nasce il cosidetto sensus animi attaccamento naturale alla vita che ci solleva in piccoli momenti che , sensa sapere perchè , fanno rinascere il senso del nostro essere. La risposta al senso è molto più privata: è quella volontà di vivere bene gli uni con gli altri : la nostra responsabilità è non aggravare la sofferenza. QUesto concetto aggiunto al sensus animi conclude una fase di scoperta di dolore universale. Le canzoni pisano recanatesi nascono dal connubio di "ragione e sentimento".
CANZONI PISANO RECANATESI
Canzoni Pisano Recanatesi
Nascono da una situazione psicologica attestata dal dialogo di Plotino e Porfirio con la rinascita dell attaccamento alla vita del principio di solidarietà. Oggi si contesta per questi componimenti la definizione di grandi idilli perchè queste sono in genere nuovo che non ha nulla a che vedere con gli idilli ma riprende semmai la canzone filosofica ma libera dal modello già esistente . I primi due componimenti sono il Risorgimento e a silvia e vengono scritti a Pisa come testimoniato dalla lettera alla sorella Paolina del 2 maggio. In questo tipo di poesia agisce molto il motivo memoriale che va approfondendosi e diventa fulcro della poesia vera e propria. Proprio per questo infatti la parola chiave di quasi tutti testi è ricordo. Il tema del ricordo è collegato al ritorno a Recanati, tutta La percezione del luogo natio viene accostata alle 9nuove acquisizioni ideologiche come il vero. Infatti inognuna delle canzoni Pisano recanatesi ritroviamo la base ideologica di almeno un operetta morale c'è una continua alternanza tra il motivo del vero e il motivo del ricordo identificato con il termine ameni inganni.In questa fase quindi la poesia diventa di nuovo filosofica tanto che un'altra interpretazione individuava due momenti delle canzoni, quelli del vero e quelli degli ameni inganni. In realtà questi due temi non sono separati ma in stretta relazione dal momento che il vero non è un momento di non poesia ma è elemento essenziale che permette di capire l'immaginazione .Le altre canzoni Pisano recanatesi sono le ricordanze,La quiete dopo la tempesta, il sabato del villaggio l un dittico legata alla teoria del piacere), Il passero solitario ,il canto notturno di un pastore errante dell'Asia->l'unico in cui non è è presente il tema memoriale, questo componimento è la traduzione in versi del dialogo della natura e di un islandese .
A SILVIA
A Silvia
La figura di Silvia è spesso associata alla Nerina delle rimembranze icomunque entrambe traggono ispirazione dall'Aminta di tasso, diventando senpre più simboliche. Leopardi infatti utilizza questi due nomi come filtri letterari, dietro Silvia si nasconde la figura di Teresa, ragazza morta giovane a Recanati, Silvia diviene quindi un universalizzare, diventa sempre più un simbolo . I componimento inizia con l'andamento discorsivo e ci sta quasi una forma di dialogo tra Leopardi e Silvia. La prima domanda individua il motivo della Rimembranza diversi sono molto scorrevole grazie anche alla presenza dei sette mari nari il motivo musicale grazie all'uso di alcuni fonemi ricorrenti. silvia è indicata fisicamente con gli occhi a cui sono attribuiti due termini : ridenti e fuggitivi ,dando un senso di astrattezza di indefinito.La parola lieta associata alla parola pensosa stempera quella gioia fresca della gioventù e predice con un destino che lei non si aspetta.Silvia è rappresentata nel momento in cui ancora non ha nessuna consapevolezza di quello che sarà.L'illusione per leopardi finisce già con la giovinezza. La figura di silvia è resa più astratta con alcuni filtri:
FISICO: Il canto di silvia è percepito da lontano, c'è quindi uno iato tra lo spazio fisico di Silvia e tra quello del poeta.
LETTERARIO: i versi sono una ripresa del canto di Circe nel VII libro dell'eneide.
MEMORIA: allontana e astrae, il ricordo di un 'illusione è un'illusione potenziata.
RIFLESSIONE FILOSOFICA (secondo Getto): opera sopratutto nell'ultima strofa, con il tema del vero Silvia è sempre più astratta
IMMAGINAZIONE E DOPPIA VISIONE: con l'immaginazione si va al di là delle cose sensibili.
Il filtro ha quindi la funzione di togliere realismo al testo e universalizzare l'esperienza e renderla astratta,è un elemento della critica moderna che si frappone tra la realtà e la sua rappresentazione, una barriera di transizione da cui otteniamo l'universalizzazione del concetto, l'illusione e l'astrattezza della realtà. Le strofe legate al passato e quindi alla memoria sono principalmente le prime 3 , nella IV si introduce il tema del vero per poi tornare al tema della memoria nella V . La VI strofa torna alla riflessione, il simbolo e la realtà si confondono. La speranza muore con Silvia e c'è sempre un richiamo al dialogo e a un'esperienza di disillusione condivisa tra lei e il poeta. Ultimi versi: domanda retorica con trasposizione sul piano collettivo. Si intersecano illusione e vero in un processo di astrazione ma alla luce di questo il vero non può prescindere da alcuna esperienza anche la più astratta.
CONFRONTO TRA QUIETE DOPO LA TEMPESTA E SABATO DEL VILLAGGIO.
Confronto tra Quiete Dopo la Tempesta e Sabato del Villaggio
Questo dittico dedicato alla teoria del piacere presenta molte differenze tra un componimento e l'altro. Nella quiete dopo la tempesta, infatti il piacere viene visto come cessazione del dolore, anticipato, nella sua visione, dalle Operette morali.il sabato del villaggio invece presenta un'idea di piacere creato dall'attesa del bene ma una volta che si entra in possesso di questo bene esso si svilisce. Questi componimenti sono tra loro conti complementari, nella prima parte di entrambi c'è la descrizione del borgo ( che ormai fa sentire il poeta parte di una comunità) mentre nella seconda parte prende luogo la riflessione filosofica.Queste due parti però sono nelle poesie impostare con toni e strutture diversi, ad esempio sabato del villaggio c'è meno stacco tonale.
LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA
La Quiete Dopo la Tempesta
La descrizione del borgo non è realistica, sono presenti animali dell'ambiente contadino e vastità spaziale. Il mondo umano è rappresentato in alcune azioni caratteristiche come il canto, il raccogliere l'acqua e il grido dell'erbaiolo . Rappresentano qualcosa di Iterato che determinano in un gesto quotidiano e senza tempo, sono exempli, figure simbolo. La riflessione filosofica ha un tono duro e caustico caratterizzato da pause interrogative retoriche vocali chiuse e consonanti sibillanti e doppie. Particolarmente importante è l'espressione "piacer figlio d'affanno" che indica un piacere effimero e illusioro perchè ottenuto con la fatica. Il non soffrire non è felicità e da questa considerazione parte una requisitoria contro la natura.
SABATO DEL VILLAGGIO
Sabato del Villaggio
La prima parte è molto più articolata, anche secondo i simboli che rappresentano le 4 fasi della vita con caratteristiche legate alle varie età. Il primo simbolo sono i fanciulli, il secondo La donzelletta,il terzo Il legnaiuolo, il quarto La vecchiarella. La donzelletta fa parte del mondo del lavoro, I fiori sono il simbolo della festa e la fanciulla con in mano il mazzolino di rose e viole rappresenta una ripresa di Poliziano. Pascoli nella sua critica riprende questo verso affermando che è inesatto parlare di fiori cresciuti stagioni diverse; infatti contesta la poetica del vago e dell'indefinito affermando che non bisogna negare la natura delle cose .La vecchiarella é simbolo della memoria e del ricordo che da gioia solo a immaginarlo.Attraverso un gioco di ombre e luci che richiama la prima bucolica Leopardi ci introduce alle immagini del bambino ingenuo e festoso ed all'uomo adulto, ovvero lo Zappatore, forum povero ma fischiettante.il legnaiolo è un altro personaggio del mondo del lavoro. Al verso 38 inizia la riflessione: tristezza e noia vengono indicati come due poli della vita umana, la noia è assenza delle sensazioni ,cosa che per un sensista come Leopardi è peggio anche del dolore. La parte riflessiva sì stempera in un colloquio scherzoso che però non rende meno grave la realtà. Il garzoncello vive secondo Leopardi il sabato della sua vita.
Le ricordanze
Le Ricordanze
Il passato è un momento di riflessione sul vero, tutto il componimento alterna ameni inganni e vero. Il mondo degli ameni inganni ha un suo linguaggio fatto di luna, luce e ombra, immagini indefinite, strofe fluide metricamente. In questo testo è fortemente presente il tema della memoria che richiama il passato poetico del poeta,citando l 'infinito, la sera al dì di festa e a Silvia. La torre del borgo rimanda anche al passero solitario, ogni strofa termina con un preannuncio del tema successivo. si parla di un primo entrare di giovinezza di Nerina la quale, come Silvia ,muore giovane ma stavolta viene individuata in dialogo con Leopardi ( c'è infatti chiaramente il superamento di una barriera per il poeta ). Gli ultimi versi sintetizzano un po' tutto il tema del ricordo che infatti è acerbo perchè non rasserena ne pacifica : è il ricordo disilluso e quindi amaro.
CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE NELL'ASIA
Canto Notturno di un Pastore Errante nell'Asia
Questa canzone Pisano recanatese è legata al mito del buon selvaggio, infatti solo ai confini del mondo l'uomo è veramente intatto. La natura coincide con la luna che non è più personalizzata, la prima parte del componimento presenta un dialogo tra la natura, ovvero la luna silenziosa e Il pastore . lI paesaggio lunare con una descrizione del cielo e della terra che qualificano uno spazio infinito e sconfinato quasi richiamano l'infinito Leopardiano della prima fase,ma questo infinito si incarna in una prospettiva filosofica legata alla ragione e al vero. Il pastore è un filosofo primitivo,espressione del pessimismo cosmico leopardiano, perchè solo il vero e la ragione sono i suoi strumenti . La luna viene sostituita da un altro interlocutore, il gregge.
CICLO DI ASPASIA
Ciclo di Aspasia
La fase delle canzoni Pisano recanatesi è collegata ad alcuni elementi biografici, tra questi abbiamo l'amore per una donna, Fanni Tozzetti, incontrata durante il soggiorno Fiorentino. La passione non è corrisposta ed è vissuta nella sua concretezza.Dedica alla donna l'unica poesia del ciclo nella quale appare il nome Aspasia che storicamente è l'amante di Pericle, raffinatissima, di grande cultura, ma considerata di facili costumi. Il ciclo di Aspasia rappresenta un momento della vita di Leopardi in cui il poeta si ispira a qualcosa di concreto,l'amore, incarnato nell'ultimo dei 5canti e associato al tema della morte.
Il pensiero dominante
Consalvo
A se stesso
Aspasia
Amore e morte
AMORE E MORTE
Amore e Morte
Tratta un tema caro al decadentismo che infatti verrà ripreso da D'Annunzio. La morte è un bene che allevia le sofferenze e così l'amore ricambiato e non. Si fa strada il sentimento dell'amicizia che con l'amore fa sentire il poeta parte integrante della vita di tutti.
A SE STESSO
A Se Stesso
Ci sono frasi scarne e spoglie, l'andamento è spezzato per rendere un ritmo più concitato. Notiamo la presenza dello stile del vero E la brevità come sintesi del pensiero negativo di Leopardi.Come canto notturno riprendo il vanitas vanitatum. Gli ameni inganni sono inutili e vengono inseriti nel ricorrente contesto di dolore e noia. Enjambement e pause uniscono e spezzano i versi mentre aggettivi danno l'idea di dilatazione che coincide con infinito e il nulla.
LA GINESTRA
La Ginestra
Inizia citando il vangelo "E gli uomini selsero le tenebre alla luce". Leopardi intende questo frammento in maniera rovesciata: la luce è la ragione e le tenebre gli spiritualisimi (illuminismo), in una sorta di antispiritualismo e di antifinalismo.
- I STROFA
Il tono è caustico e ironico, lo stile antifrastico. Leopardi alle pendici del vesuvio (simbolo della fragilità umana rispetto alla Natura). Il motivo di fondo è polemico, e il verso di Maniani alla fine viene scritto con ironia per essere contestato. L'uomo è una povera creatura soggetta alla natura, la Ginestra è un fiore che cresce in situazioni non ottimali, si umanizza (commisera e consola)al contrario di un altro elemento della natura che distrugge, il Vesuvio. La poesia consola esattamente come fa la ginestra, è infatti portatrice del valore di solidarietà.La ginestra rappresenta la condotta di vita ideale dell'uomo che deve essere solidala ma anche antagonista in un atteggiamento mai passivo. Leopardi afferma il concetto di natura matrigna.
-2 STROFA
Continua il tono polemico, con il verso 63 una cesura segnala la presenza di Leopardi che parla in prima persona. Attacco all'800: secolo superbo e sciocco che ha abbandonato l'illuminismo, che è andato contro il vero e con cui L. non vuole avere nulla a che fare. Leopardi assume un atteggiamento costruttivo: delinea un programma di uomo alternativo.
-3 STROFA
Continua la polemica e si mette in luce l'insignificanza dell'uomo. La nobile natura va contro il comune fato, l'essere una socil catena rende quindi gli uomini tutti alleati . La base della convivenza civile è stringere gli uomini nella social catena, una convivenza basata sul vero. la grandezza della natura rende l'uomo ancora più piccolo, abbiamo un paesaggio anti idillico qul quale si specchiano le stelle del cielo, richiamo evidente al canto notturno.Anche la volta celeste mette in luce la fragilità dell'uomo. L'infinito è nel vero e nella riflessione filosofica
-4 STROFA
Dalla parola "rimembrando" si passa al ricordo delle favole umane e alle illusioni dell'umanità (Credere che gli dei scendano sulla terra, credere di essere i padroni del mondo, ..) Contestazione mirata al pensiero umano.
5 STROFA
Riprende la prima strofa si imposta su una similitudine tra uomo e formiche, il vesuvio è come un frutto che ha distrutto un formicaio.
6 STROFA
Immagine idillica del villanello prima dell'eruzione. Filo conduttore : vesuvio. LEopardi introduce l'infinito sul piano del tempo, il tempo che non fa percepire il ciclo vitale e il suo succedersi, l'uomo è impotente di fronte a esso.
7 STROFA
Ritorna sulla ginestra, che diventa anche simbolo della dignità suprema dell'uomo --> bisogna essere fragili con il coraggio di dichiararsi tali, i due punti di forza della ginestra sono appunto solidarietà e consapevolezza, fondamenti della società dell'uomo.
Domande da interrogazione
- Quali sono le caratteristiche principali del Romanticismo in Italia secondo il testo?
- Come si relaziona Leopardi con l'Illuminismo?
- Qual è l'evoluzione del rapporto tra uomo e natura secondo Leopardi?
- Quali sono i temi principali trattati nello Zibaldone di Leopardi?
- Come si caratterizzano i Canti di Leopardi?
Il Romanticismo in Italia si distingue per due filoni: uno oggettivo, aperto al pubblico e di ampio respiro, e uno soggettivo, che esprime la soggettività, nonostante Manzoni proponga una lirica oggettiva.
Leopardi, influenzato dall'Illuminismo francese, adotta l'ateismo, la ragione e il razionalismo come ideologia di riferimento, pur mantenendo un elemento romantico nel suo adattamento della forma al contenuto.
Leopardi vede l'uomo inizialmente in simbiosi con la natura, ma con il progresso e la ragione, questo legame si spezza, portando a un pessimismo storico dove la natura diventa matrigna e la ragione madre.
Lo Zibaldone esplora temi come la teoria del piacere, l'infelicità dell'uomo, il vago e l'indefinito, e la visione dell'infinito, con un focus sull'immaginazione e la poesia come strumenti per raggiungere il piacere.
I Canti di Leopardi sono composizioni poetiche che esprimono lo spirito in versi, non divise per generi, e includono canzoni politiche, filosofiche, idilli e canti di morte, con un forte spirito sarcastico e caustico.

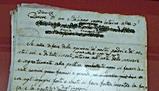





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo