Concetti Chiave
- Giovanni Verga è nato a Catania nel 1866 ed è noto per il suo contributo al verismo, un movimento letterario che si focalizza sulla rappresentazione realistica e impersonalità nelle narrazioni.
- La svolta verista di Verga avviene nel 1874 con "Nedda", segnando l'inizio di uno stile che elimina il dialetto locale per dare un respiro nazionale alle sue opere.
- Il "Ciclo dei Vinti" intende esplorare la lotta per la sopravvivenza attraverso diverse classi sociali, applicando le teorie di Darwin alla società umana.
- Il racconto "Rosso Malpelo" utilizza il narratore impersonale per rappresentare una società dominata dalla lotta per la vita, esprimendo il pessimismo di Verga attraverso una narrazione realistica.
- Opere come "La roba" esaminano il conflitto tra l'accumulo di beni e la realtà della vita, rivelando la critica di Verga verso la società e il suo sistema di valori.
Indice
Biografia e Formazione di Giovanni Verga
In questo appunto viene descritta la biografia dell'intellettuale Giovanni Verga, con analisi delle sue opere principali come per esempio i Malavoglia, Le novelle, Vita dei campi, raccolta di novelle di cui fa parte anche Una peccatrice; Storie di una capinera, Il Ciclo dei vinti, i Malavoglia, Rosso Malpelo, ecc...
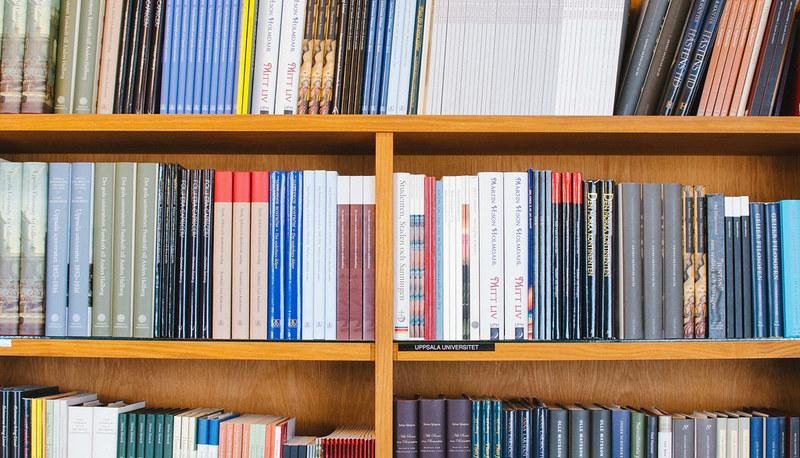
Nasce a Catania nel 1866, figlio di ricchi possidenti terrieri. Incarna l’aristocratico conservatore di fine ‘800.
La sua formazione passa attraverso l’azione di un precettore, un uomo dal punto di visto culturale, un mediocre letterario, ma un grande patriota, intriso di sentimenti liberali.
Nel 1862 infatti scrive un primo testo I Carbonai della Montagna.
Nel 1872 si trasferisce a Milano, dove entra a contatto con gli Scapigliati e scrive i cosiddetti “romanzi mondani”: “Eva”, “Eros” “Tigre Reale”.
Sono romanzi che si iscrivono in un clima ancora tardo-romantico, rappresentando ambienti aristocratici e incentrandosi su passioni complesse di anime elevate. Sono ancora scritti con un linguaggio enfatico e emotivo.
per ulteriori approfondimenti sulla biografia di Giovanni Verga vedi anche qua
Opere e Temi Principali
Un esempio è sicuramente “Una peccatrice” del 1866, melodramma autobiografico di un borghese siciliano che conquista il successo ma che si ucciderà per disperazione amorosa. Quest'opera fa parte della celebre raccolta di novelle scritte dal Verga e note con il titolo Vita dei campi. Si descrive la vita di Lisabetta, una donna che vive in campagna in una situazione di grande povertà e che per vivere è costretta a svolgere la professione di domestica presso una famiglia benestante. La vicenda indaga profondamente sulla psicologia di Lisabetta che vive un conflitto interiore perenne tra la sua infanzia e innocenza e le tentazioni rappresentate dalla vita adulta, come ad esempio il tentativo di seduzione da parte di un uomo. I temi che vengono descritti in questo racconto sono:
- come vivono le donne nelle campagne;
- le sfide che queste ultime devono affrontare.
Verismo e Tecniche Narrative
La peccatrice si può definire come un'opera molto significativa del Verga perché pone al centro della vicenda sentimenti e i dubbi dei protagonisti centrali. “Una peccatrice” e “Storia di una capinera”, molto distanti dal verismo, sono drammi ottocenteschi. Le storie si basano su aspetti melodrammatici.
Altra opera è “Eva” rappresenta forse il romanzo più vicino alla polemica anticapitalista degli Scapigliati, poiché narra la storia di un pittore siciliano che rinuncia ai suoi ideali per una ballerina abituata a una vita lussuosa e noncurante dell’arte.Il successo letterario lo otterrà quando si trasferisce a Firenze.
Negli anni ‘80 inizia a scrivere il “Ciclo dei vinti”, ma riuscirà a pubblicare solo due dei 5 romanzi previsti, ovvero “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”.
Pubblicò anche due raccolte di novelle: Vita dei Campi (1881) e Novelle Rusticane.
Dal 1884 comincia a interessarsi di teatro, viene rappresentata “La cavalleria rusticana”, che verrà raccolta nei Canti. Un Turiddo è innamorato di una giovane donna, nel tempo in cui lui è via, lei si sposa con un altro uomo. Durante un duello fra I due uomini il protagonista morirà. Il successo è dovuto anche all’interpretazione di Eleonora Duse.
“Nedda” viene definito un tempo di passaggio verso il verismo, soprattutto per l’ambientazione siciliana. Descrive la vita misera di un bracciante, ma pur essendo di ambientazione rurale non è verista perché il narratore esprime dei giudizi da intellettuale, il linguaggio che I personaggi mettono in atto, non è il linguaggio dei siciliani, piuttosto è la trascrizione di un linguaggio colto. Citò in alcuni passaggi il dialetto siciliano ma fu una delle ultime volte. La scelta di eliminare il dialetto è dovuta al voler dare un respiro nazionale alla pubblicazione.
Gli errori sintattici, grammaticale, la parlata corrisponde però alla popolazione siciliana.
“Rosso Malpelo” 1878 è il primo vero romanzo verista.
L’approdo al verismo è il frutto di una chiarificazione progressiva di proposti già radicati, la conquista di strumenti concettuali e stilistici più maturi come l’impersonalità e la concezione materialista della realtà.
Inoltre, la svolta verista non va interpretata come allontanamento dagli ambienti eleganti e mondani, dato che egli si propone di tornare a studiarli con strumenti più incisivi. Le “basse” sfere sono il punto di partenza del suo studio die meccanismi, della società, poiché in esse tali meccanismi sono meno complitati e meglio identificabili. Lo scrittore intende successivamente applicare il suo metodo anche alle sfere superiori, sino al mondo dell’aristocrazia e della politica.
Luigi Capuana, nella “Prefazione ai Malavoglia” (p. 296) afferma come la letteratura deve perseguire i propri fin, che sono artistici, e l’unico modo che avrà per avvicinarsi allo spirito della scienza sta nel metodo con cui si rappresentala realtà. La perfetta impersonalità dell’autore è la tecnica da usare.
La “Prefazione” al racconto “L’amante di Gramigna” ha la forma di una lettera indirizzata a Salvatore Farina, questi era il direttore di un’importante rivista milanese, nella quale fu pubblicata l’opera verghiana “L’amante di Raja”. Farina era contrario alle ideologie veriste, per questo Verga nella prefazione argomenta i suoi convincimenti letterari.
Si possono desumere alcuni punti essenziali della apoetica di Verga:
- L’impersonalità: essa viene intesa come "eclisse" dell’autore, che deve sparire dal narrato, non deve filtrare i fatti attraverso la sua "lente", ma deve mettere il lettore "faccia a faccia con il fatto nudo e schietto". Il lettore deve seguire lo sviluppo di certe passioni come se non fossero raccontate, ma si svolgessero di fronte a lui. L’opera, pertanto, deve sembrare "essersi fatta da sé".
-Teoria della regressione: si delinea in relazione all’impersonalità e all’eclisse dell’autore. Il fatto sarà raccontato "così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare", deve essere sostituito cioè il narratore portavoce dell’autore con un’anonima voce narrante che ha i medesimi principi ideologici e il medesimo modo d’esprimersi della massa popolare descritta.
-L’eclisse dell’autore porta con sé l’eliminazione di minute descrizioni psicologiche della narrativa romantica. Dai semplici comportamenti dei personaggi, dai loro gesti e parole dal loro modo di > potranno essere ricavate dal lettore la personalità di ciascuno di loro.
Da qui deriva il rifiuto di una facile drammaticità e da oggetti romanzeschi plateali, i quali saranno sostituiti da una ricostruzione scientifica dei processi psicologici, fondata su una rigorosa consequenzialità logica e su rapporti necessari di causa e di effetto. Questa fiducia nelle leggi di causa. Effetto che regolano la vita interiore è un tratto tipico della narrativa di impianto naturalistico. È una concezione che rimanda all’ideologia positivistica che tutta la realtà sia retta da leggi ferree e precise.
→ Vedi la Commedia Umana, Prefazione a Germinie..| riferimento chiaro al Naturalismo.
Bisogna sacrificare, il pathos, la drammaticità.
r.26 quando la mano dell’artista sarà invisibile, nessuna macchia del peccato d’origine (l’idea originale dell’autore) sarà visibile e l’opera sembrerà essersi fatta da sé, allora sarà perfetta.
Nella “Prefazione al Ciclo dei Vinti” (p.350) alla riga 53 si colloca un’affermazione di capitale importanza: "Chi osserva questo spettacolo (lotta per l’esistenza) non ha il diritto di giudicarlo". Questa frase è rivelatrice del profondo pessimismo dello scrittore, che dà origine alla poetica dell’impersonalità e alla tecnica narrativa della regressione.
Pessimismo e Critica Sociale
La società è per lui dominata dal meccanismo della per la vita, nozione proveniente dall’opera di Charles Darwin, un meccanismo crudele per cui il più forte sopraffà necessariamente il più debole. Gli uomini sono mossi solamente dall’interesse economico, dalla ricerca dell’utile, dall’egoismo e dalla volontà di sopraffare gli altri per raggiungere i proprio obiettivi.
È una legge di natura universale, immodificabili, pertanto non esistono alternative alla realtà esistente (la sua visione è materialista e atea, esclude ogni consolazione religiosa). Se è impossibile modificare la realtà, ogni intervento giudicante appare inutile e privo di senso, e allo scrittore non resta che riprodurre la realtà così com’è, per questo che Verga adotta la tecnica dell’impersonalità.
È chiaro che un simile pessimismo ha una connotazione fortemente conservatrice e così associa un rifiuto per le ideologie progressiste contemporanee, democratiche e socialiste, che egli giudica “fantasie infantili” o “interessanti inganni”. Però questo pessimismo conservatore no implica affatto un’accettazione della realtà esistente, anzi gli consente di cogliere con straordinaria acutezza e precisione il negativo della realtà, la disumanità della lotta per la vita, il trionfo dell’utili e della forza, sprezzante verso ogni valore umanitario. Il pessimismo non è dunque un limita della rappresentazione di Verga, ma è al contrario la condizione del suo valore critico e conoscitivo. Dando origine a soluzioni narrative innovative, lo preserva dai limiti quali il patetismo, il sentimentalismo per le miserie degli umili e il mito del progresso che risolverà tutti i problemi. La scelta di regredire nell’ottica popolare, di raccontare il punto di vista della lotta per la vita costituisce la dissacrazione di ogni mito populistico progressivo. Per sottolineare la negatività del progresso moderno, Verga non contrappone ad essa il mito della campagna come Eden di innocenza e come antidoto alla società moderna come Rousseau: anche il mondo primitivo della campagna è retto dalle stesse leggi del mondo moderno. Verga non è uno scrittore che offre immagini consolatorie del mondo, ma è uno scrittore lucido che stimola la conoscenza critica della realtà.
Sull’adozione dei nuovi modelli narrativi esercitò un influsso determinante la letteratura di Zola, che suggerì a Verga la tecnica della regressione.
La “Vita dei campi” è una raccolta di racconti che prende vita nel 1880 seguendo la poetica verista. In questi racconti spiccano le figure caratteristiche della vita contadina siciliana e viene applicata la tecnica narrativa dell’impersonalità (tranne Fantasticheria). Accanto alla rappresentazione verista e pessimista del mondo rurale si può trovare ancor auna traccia di un atteggiamento romantico, di vagheggiamento nostalgico di quell’ambiente arcaico come una sorta di paradiso perduto di innocenza, I temi principali sono quello dell’amore e del conflitto fra l’individuo diverso e il contesto sociale che lo espelle. Nella Cavalleria Rusticana viene invece trattato il tema del conflitto tra amore e interesse economico.
Malpelo si chiamava così per I suoi capelli rossi, associati a una malvagità naturale. L’inizio è una stortura logica che rivela un pregiudizio superstizioso, proprio di una mentalità primitiva che non apparitene allo scrittore, ma alla massa popolare. Il narratore è interno al mondo rappresentato.
Dunque il narratore è inaffidabile, non è portatore di verità, non capisce le motivazioni dell’agire di Malpelo.
Il passaggio in cui muore suo padre, “Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia”.
È descritto come un cane arrabbiato.
v.84 Malpelo butta via il pane, manco non fosse grazia di Dio, lo butta via perché ha una reazione normale. È appena morto suo padre. Malpelo è un filosofo a suo modo:
-insegna a ranocchio a difendersi, poiché è consapevole della durezza della vita.
Mostra di essere consapevole della sua condizione “io sono Malpelo”. Il giudizio del narratore, che coincide con il pensiero popolare, accompagna Malpelo per tutto il suo percorso.
Pur essendosi formato nell’ambiente disumano della cava, Malpelo ha conservato dei valori disinteressati: la pietà filiale, il senso della giustizia, l’amicizia, la solidarietà altruistica. Il punto di vista del narratore con le sue incomprensioni e deformazioni esercita su questi valori un processo di straniamento, fa sembrare strano ciò che in realtà è normale. Ciò deriva dal fatto che il narratore è appunto portavoce della visione di un mondo disumano dominato dalla legge di sopravvivenza. Questo straniamento ha la funzione di negare i valori, di mostrarne l’impraticabilità in un mondo dominato dal meccanismo brutale della lotta per la vita. L’artificio narrativo esprime tutto il pessimismo di Verga.
Il mondo rurale non è qui mitizzato come paradiso di innocenza e autenticità, come in “Fantasticherie”. Anzi appare anch’esso dominato dalle stesse leggi che regolano gli strati più evoluti.
Nella seconda parte del racconto emerge il punto di vista del protagonista, che esprime la visione cupa e pessimistica del ragazzo indurito dalla disumanità della vita di fatiche, angherie e patimenti. Rosso ha colto perfettamente l’essenza della legge che regola la realtà. Su questa presa di coscienza regola la sua condotta. Nella sua figura si delinea l’eroe intellettuale, portatore di una consapevolezza lucida dei meccanismi di una realtà immodificabile (Leopardi).
“Rosso malpelo” rappresenta un’analisi dura e impietosa delle leggi sociali, dotata di altissimo valor conoscitivo e critico.
Perché è un romanzo verista?
-La scelta di utilizzare il narratore impersonale, un personaggio allo stesso livello di Malpelo che esprime le credenze del popolo.
-Forma inerente al soggetto: modo in cui si esprimono i lavoratori, nel momento in cui cade il pilastro “fa pouf” → modo basso in cui viene raccontata una cosa.
per ulteriori approfondimenti su Vita dei campi vedi anche qua
“Perché tutti sono i vinti, i vincitori di oggi sono i vinti di domani”.
Ciclo dei Vinti e Analisi Sociale
Parallelamente alle novelle, Verga si dedica alla scrittura di un ciclo di romanzi ispirati al modello di Rougon-Macqaurt con l’intenzione di tracciare un quadro sociale passando in rassegna tutte le classi, dai ceti popolari, alla borghesia di provincia, fino all’aristocrazia. Il criterio unificante è il principio della lotta per la sopravvivenza, che lo scrittore ricava dalle teorie di Darwin sull’evoluzione e applica alla società umana, dominata da conflitti di interesse dove il più forte trionfa. Verga si sofferma sui vinti di questa guerra universale. Al ciclo viene premessa una prefazione che chiarisce gli intenti dello scrittore. Nel primo romanzo “I Malavoglia” > è preso alle sue sorgenti, si tratta della semplice >. Nelle basse sfere il meccanismo sociale è meno complicato e si può osservar con più facilità. Nei romanzi successivi sarà analizzata la > nel suo progressivo elevarsi attraverso le classi sociali, dall’ardita ricchezza nella borghesia di provincia (Mastro don Gesualdo) alla vanità aristocratica (Duchessa di Leyra), all’ambizione politica (L’onorevole Scipioni) e artistica (L’uomo di lusso): Anche lo stile e il linguaggio devono adeguarsi e modificarsi gradualmente in questa scala ascendente.
Verga ci descrive quelle che sono le sue scelte. Bisogna comprendere cos’è per Verga il verismo. I Malavoglia sono una costruzione letteraria. Quando scrive il romanzo è a Milano, distante dalla Sicilia, ambientazione del libro. Si basa su studi precedenti per costruire un mondo letterario da cui partire. Il romanzo rimane opera d’arte, anche se quello che è descritto, l’ambiente è un artificio letterario da cui partire per comprendere i meccanismi della società. Bisogna partire dalle basse sfere, poiché è naturale scomporre per comprendere. Verga parte da quelli che sono i bisogni primordiali dell’uomo, i bisogni elementari, e nelle basse sfere questi sono i desideri.
“La bramosia degli ignoti”. Questo stimolo è qualcosa di imprescindibile, la volontà di prevaricare gli altri ci accomuna, conseguentemente alla legge di sopraffazione.
Il progresso è qualcosa di grandioso che si porta dietro degli aspetti negativi, ovvero i vinti. Questi saranno i protagonisti del suo romanzo. Partirà dalle basse sfere in quanto è più facile comprendere questi meccanismi.
La sua affermazione della forma soggetto → per esprimere a pieno ciò che vuole deve dire, deve adattar e il linguaggio ai personaggi che sta descrivendo. Il punto di vista di Verga si immerge nel mondo dei personaggi. Esempio: p.361 capitolo primo.
Riga 46 → punto di svolta.
Il progresso può essere valutato, apprezzato da quell’osservatore...r.39. Nonostante il progresso, le cose meravigliose che ci circondano, l’uomo non può cambiare. Ciò che costa non importa a nessuno, i vinti vengono tralasciati.
I personaggi non vengono descritti, compaiono sulla scena, comprenderemo di più delle loro personalità attraverso le loro parole e le loro azioni.
Entriamo in questo mondo senza nessuna possibilità di anticipare, se non comprenderlo leggendo.
Nel finale della prefazione emerge il pessimismo verghiano.
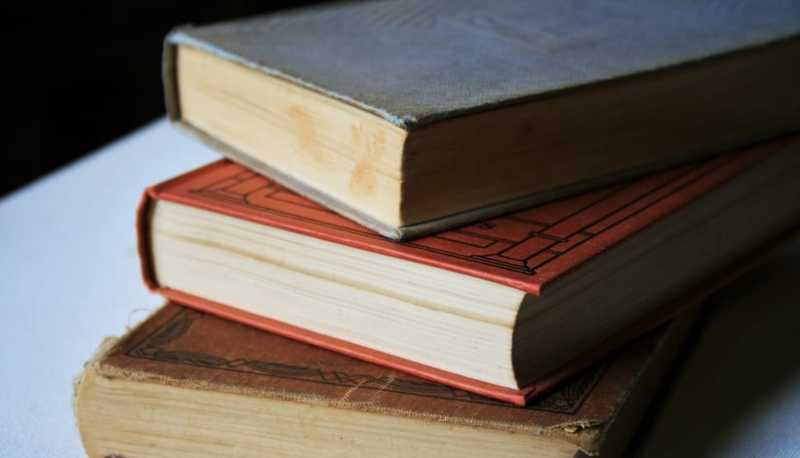
Conclusioni e Riflessioni Finali
Mosca dichiara il suo amore per Mena. Mena si sta occupando dei bambini di sua sorella.
Se io mi maritassi, le persone tornerebbero a parlare di mia sorella”
Racconta quella che è la bontà dei sentimenti e la rassegnazione alla vita.
Rappresentazione di un amore puro, Alfio ci prova fino alla fine. Ma Mena non è più una donna da maritare, perché è una Malavoglia. Alfio prende atto di questa cosa. Da quel momento in poi si misero il cuore in pace e si rassegnarono. La fine lascia aperto il romanzo: ritorno di Tony e la sua partenza. È tornato per dire che non tornerà più. Ormai ha visto, ha capito, ha voluto far proprie quelle che erano le bramosie per un futuro indefinito. Non fa più parte di quel nucleo, quindi deve andare via. Anche lui porta dietro qualche segno. Chiede delle persone. Prima di andarsene fa un giro per la casa.
L’addio avviene all’alba, un momento particolare della giornata.
È stato Rocco Spatu → infondo alla scala sociale dei reietti. Lui ha una posizione, un suo posto nella città, mentre Tony non ce l’ha, deve andarsene. La conclusione è molto simbolica, lirica, distacco dalle antiche radici.
“Il mare, che non ha paese neanche lui”. Quello che lui prova, sente in quel momento che non ha più posto in quella che era la sua casa. Il cane che gli abbaia dietro, che non lo riconosce è un altro simbolo. Tony ha una spinta interiore da un luogo in cui non si riconosce più.
Se Vita dei Campi sono delle novelle che mettono delle premesse per arrivare ai Malavoglia, Novelle Rusticane mettono delle premesse per arrivare alla logica utilitaristica del Mastro don Gesualdo.
Quest’uomo scala i gradini del successo, ma è comunque un vinto, rimane da solo. La figlia che si è affacciata alla nobiltà del paese, guarda con disprezzo le umili origini del padre, mentre i suoi vecchi compagni lo allontanano, considerandolo come un arricchito.
La popolazione a Bronte insorge al grido “Viva la libertà” senza veramente sapere cosa fosse questa libertà.
La popolazione è descritta come un fiume in tempesta.
Il testo non è prettamente verista, vi sono dei giudizi che ci fanno comprendere la parte in cui si schiera Verga.
V15. “A te, sbirro che hai applicato la giustizia solo per chi non aveva niente”. Verga ha a conoscenza la situazione dei contadini, la narrazione rimane vicina alla concezione che ha Verga del mondo e della storia.
Nino Bixio applica una giustizia sommaria. Questo racconto ci spiega l’immobilità, tutto resta uguale. Inutilità
della rivoluzione, ognuno pensa a sé stesso. → Darwinismo sociale.
Inizia con una descrizione quasi mitica, di quelli che sono i possedimenti di Mazzarò attraverso l’utilizzo di iperboli e esagerazioni.
Mazzarò scala i gradini del successo, a poco a poco accumula “la roba”, che è meglio del denaro.
Nella prima fase il narratore è un narratore colto, vi è un approccio simile a quello dei Malavoglia. Scompare poi però la visione mitica iniziale, si contraddice subito dopo. La roba diventa un tutt’uno con Mazzarò. Il linguaggio è basso ma il tono è solenne. La visione del mondo che il narratore ha nella seconda parte del testo è perfettamente in stile con quella che è la visione di Mazzarò. Si tratta del Verga verista, immerso nel mondo descritto. → tecnica narrativa dell’impersonalità. Analizza i fatti e non li commenta. Vi è una visione eroica di Mazzarò. Lo straniamento ha la funzione di far emerge come la legge dell’utile domini il mondo in ogni classe sociale, in ogni luogo.
La roba è una specie di mantra che viene ripetuto nel testo, in sottofondo.
Il finale è tragico: “di una sola cosa gli rodeva, incominciava a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla dov’era…andava ammazzando a colpi di bastone i galli e tacchini gridando "roba mia, venite con me”. Mazzarò è anch’esso un vinto, teoria del darwinismo sociale ben presente.
Le sue basse manovre sono presentate come eroiche, nel finale emerge il conflitto fra questa mentalità e la realtà della vita. Non vi è l’accettazione che quello che si ha resterà dopo di noi.
Testo storicamente ben definito → passaggio di consegne fra la nobiltà e la borghesia arricchita. Ciò emerge nel passaggio in cui il barone vanta il suo stemma, che non potrà mai appartenere a Mazzarò. Ma egli del titolo non sa cosa farsene, non è “roba”.
Da una parte la rivoluzione economica può far pensare a un progresso, ma i valori rimangono gli stessi (Libertà), Mazzarò è un controllore più fiscale, più maligno, gira tutto il giorno in mezzo alla campagna con lo schioppo in spalla.
- Il viandante → il primo narratore, colto, che proietta su quello che è la visione del racconto la prospettiva dell’autore vero e proprio, malinconia, tristezza, anticipa quella che sarà la sconfitta
- Il lettighiere → presentazione eroica di Mazzarò
- Il narratore popolare → analizza il finale.
Domande da interrogazione
- Qual è l'importanza del verismo nelle opere di Giovanni Verga?
- Come si manifesta il pessimismo nelle opere di Verga?
- Quali sono i temi principali del "Ciclo dei Vinti"?
- In che modo Verga utilizza la tecnica dell'impersonalità nelle sue opere?
- Qual è il ruolo della critica sociale nelle opere di Verga?
Il verismo è centrale nelle opere di Verga, poiché rappresenta la realtà in modo oggettivo e impersonale, eliminando il giudizio dell'autore e mettendo il lettore di fronte ai fatti nudi e crudi. Questo approccio permette di esplorare i meccanismi sociali e le leggi naturali che governano la vita umana.
Il pessimismo di Verga si manifesta attraverso la rappresentazione della società come dominata dalla lotta per la sopravvivenza, dove il più forte prevale sul più debole. Questo pessimismo è legato a una visione materialista e atea della realtà, che esclude ogni consolazione religiosa e critica le ideologie progressiste.
Il "Ciclo dei Vinti" esplora la lotta per la sopravvivenza attraverso diverse classi sociali, dai ceti popolari all'aristocrazia. Verga si concentra sui vinti di questa lotta, evidenziando come il progresso e l'ambizione portino inevitabilmente alla sconfitta e all'isolamento.
Verga utilizza la tecnica dell'impersonalità eliminando la presenza dell'autore nel racconto, permettendo ai fatti di emergere senza filtri. Questo approccio consente al lettore di osservare lo sviluppo delle passioni e dei conflitti come se si svolgessero davanti ai suoi occhi, senza interventi o giudizi esterni.
La critica sociale nelle opere di Verga si manifesta attraverso la rappresentazione delle disuguaglianze e delle ingiustizie della società. Verga mette in luce la brutalità della lotta per la vita e l'egoismo umano, criticando le ideologie progressiste e mostrando la disumanità del progresso moderno.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo