Concetti Chiave
- La storia di Nastagio degli Onesti nel Decameron esplora il tema degli amori infelici con lieto fine, ambientata nella Ravenna medievale, un secolo prima della scrittura dell'opera.
- Boccaccio ribalta il tradizionale tema della caccia infernale, trasformandolo in uno strumento di conquista amorosa, eliminando il suo carattere religioso e moralistico.
- Nastagio evolve da cavaliere cortese a eroe borghese, sfruttando astutamente le situazioni per il proprio vantaggio, rappresentando una nuova mentalità pratica e borghese.
- La novella trasforma l'amor cortese in una visione più realistica, dove il matrimonio diventa il punto d'arrivo della passione amorosa, superando le tragedie dell'amore adulterino.
- L'insistenza sul concetto di "piacere" nella novella sottolinea la nuova prospettiva di Boccaccio sul tema amoroso, evidenziando un cambiamento culturale nella percezione dell'amore.
Il tema della quinta giornata sono gli amori infelici che si concludono con un lieto fine. Partendo da questo spunto, la narratrice Filomena racconta la vicenda di Nastagio degli Onesti, ambientata a Ravenna (precisamente nella pineta di Classe) nella prima metà del Duecento, dunque un secolo prima rispetto a quando viene scritto il Decameron. Sfruttando tale distanza temporale, Boccaccio delinea un Medioevo cavalleresco e cortese, in parte diverso dal suo, su cui però si proiettano già i valori della nuova civiltà borghese.
● l’inadeguatezza dei modelli cortesi rispetto alla realtà
● le virtù dell’amore borghese
Indice
La strategia di Nastagio
Nastagio intuisce allora di poter sfruttare a proprio vantaggio ciò che ha visto. Per il venerdì successivo organizza in quella medesima pineta un banchetto, a cui invita la famiglia dei Traversari. Come previsto, a fine pasto irrompono sulla scena il cavaliere e la donna, la cui macabra uccisione impressiona i commensali e specialmente la donna amata da Nastagio. La giovane riconosce l’analogia tra il proprio comportamento e quello della donna punita: per timore di subire il medesimo castigo infernale, accetta quindi di sposare Nastagio.
Il motivo della caccia tragica
Nella cultura medievale era molto diffuso il motivo della caccia tragica o infernale (una visione terrificante in cui le vittime corrono nude e straziate da cani nella foresta), intesa come punizione esemplare dei peccatori: la incontriamo, per esempio, nell’Inferno di Dante (nel canto XIII gli scialacquatori, cioè i dilapidatori dei propri beni, fuggono nella foresta inseguiti da cagne rabbiose che li dilaniano) e in una famosa predica del frate Jacopo Passavanti, contemporaneo di Boccaccio. L’autore del Decameron riprende il tema, privandolo però di ogni carattere religioso e moralistico. Anzi, ne ribalta il messaggio e il valore esemplare: infatti la donna commette una grave colpa non quando acconsente alle pressanti richieste d’amore del suo spasimante, ma quando si rifiuta. Il motivo tradizionale della caccia si muta qui in uno strumento di conquista.
La trasformazione del tema amoroso
Il narratore sottolinea questa trasformazione nella sequenza finale: descrivendo la resa della ragazza amata da Nastagio e delle donne ravennati, ripete per più volte il sostantivo e il verbo “piacere” («gli dovesse piacere d’andare a lei», r. 153; «ella era presta di far tutto ciò che fosse piacer di lui», rr. 153-154; «dove le piacesse», r. 155; «voleva il suo piacere», rr. 155-156; «gli fece risponder che le piacea», r. 158; «più arrendevoli a’ piaceri degli uomini», r. 164). Tale insistenza conferma la nuova prospettiva con cui Boccaccio tratta qui il tema della caccia tragica e, più in generale, la tematica amorosa nel Decameron.
Evoluzione dei valori cavallereschi
Come sappiamo, Boccaccio si era formato in gioventù leggendo i romanzi cavallereschi francesi, che avevano lasciato in lui tracce profonde. All’inizio del racconto, Nastagio appare ancora come un tipico rappresentante dell’antico mondo cortese: vive infatti l’amore senza risparmiarsi, dando fondo a tutto il suo patrimonio, senza essere ricambiato dall’amata. Non ottenendo alcun risultato deve però ritirarsi, solitario, nella pineta di Classe. In questa sconfitta l’autore raffigura i limiti degli antichi valori cavallereschi. Nella seconda parte della novella lo spirito cortese viene riequilibrato, e corretto, dalla nuova mentalità borghese. Piuttosto che continuare a spendere inutilmente denaro, Nastagio decide saggiamente di sfruttare per i propri interessi personali la scena a cui ha assistito nella pineta. Il saper trarre vantaggio dalle situazioni offerte dal caso è una virtù tipicamente borghese: una virtù nuova per Nastagio, e per il mondo da cui proviene.
Il cambiamento della visione amorosa
Non è però solo Nastagio a mutare. Nel racconto possiamo osservare anche una trasformazione dell’antico precetto, tipico del mondo cavalleresco, dell’amor cortese riassunto da Dante nel celebre verso «Amor ch’a nullo amato amar perdona» (Inferno V, v. 103;): non si può resistere, diceva Francesca da Rimini (avida lettrice di romanzi cavallereschi), alla forza della passione; tutto deve esserle sacrificato. Nella visione cortese, inoltre, l’amore poteva realizzarsi solo come passione adulterina, al di fuori del matrimonio: una visione quindi rischiosa, che spesso conduceva a esiti tragici come nel caso di Paolo e Francesca. Il racconto di Boccaccio trasforma tale prospettiva: punto d’arrivo della passione amorosa diviene, adesso, il matrimonio. All’inizio, Nastagio consuma sé e il proprio denaro senza ottenere alcun risultato, se non la freddezza dell’amata; dopo le nozze trova finalmente il proprio equilibrio («con lei più tempo lietamente visse», rr. 161- 162). Rispetto al servizio d’amore cortese, il matrimonio è un’unione più solida: meno romantica, forse, ma più realistica e concreta.
Domande da interrogazione
- Qual è il tema principale della quinta giornata del Decameron?
- Come Nastagio degli Onesti sfrutta la visione della caccia tragica a suo vantaggio?
- In che modo Boccaccio trasforma il tema della caccia tragica?
- Quali sono le differenze tra i valori cavallereschi e quelli borghesi nel racconto di Nastagio?
- Come cambia la visione dell'amore nel racconto di Boccaccio rispetto alla tradizione cortese?
Il tema principale è quello degli amori infelici che si concludono con un lieto fine, come illustrato nella storia di Nastagio degli Onesti.
Nastagio organizza un banchetto nella pineta dove invita la famiglia dei Traversari, e la macabra scena della caccia tragica convince la donna amata a sposarlo per evitare un simile destino.
Boccaccio priva il tema della caccia tragica di ogni carattere religioso e moralistico, ribaltandone il messaggio per farne uno strumento di conquista amorosa.
I valori cavallereschi, rappresentati dall'amore disinteressato e non ricambiato, vengono corretti dalla mentalità borghese, che valorizza il saper trarre vantaggio dalle situazioni.
La visione dell'amore si trasforma da una passione adulterina e tragica a un amore che culmina nel matrimonio, considerato più solido e realistico.



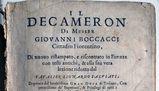





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo