
Oggi 21 giugno 2017 più di mezzo milione di maturandi sta affrontando la Prima Prova di maturità 2017. Tra le varie tracce scelte dal MIUR per la Maturità 2017 come tipologia A è uscito l'analisi di un testo di Giorgi Caproni. Noi di Skuola.net ci siamo impegnati per proporre una soluzione, ma solo dopo le ore minime di consegna Consigliamo comunque di non copiare le soluzioni perché potresti compromettere il tuo esame!
Soluzione analisi del testo maturità 2017
Giorgio Caproni, “Versicoli quasi ecologici” in Res amissa
Comprensione del testo
1 - Nella seguente lirica Giorgio Caproni espone il tema dell’azione distruttrice dell’uomo nei confronti della natura; l’autore infatti accusa l’uomo di essere colui che “uccide” la natura, invitandolo però a non compiere più queste azioni. Successivamente l’autore invita gli uomini a non elogiare chi trae profitto dalla distruzione della natura, Caproni utilizza come esempio l’uccisione dei pesci ma si riferisce a tutto ciò che comprende la natura stessa: i boschi e i mari. Per l’autore infatti la natura è portatrice d’amore e per lui lo stesso amore finisce dove questa muore e chi resta non può far altro che sospirare rendendosi conto che il paese si sta “guastando”.
Infine l’autore negli ultimi versi sostiene esplicitamente che la terra tornerà a essere bella nel momento in cui l’uomo scomparirà, perché è proprio lui che soprattutto per profitto sta distruggendo tutto ciò che di bello c’è nella terra stessa.
2 - Analisi del testo
2.1 Il significato di questa particolare lirica è attinente al titolo della raccolta in cui è contenuta intitolata “Res amissa” ,che significa “cosa perduta”, poiché l’autore rimprovera l’uomo di causare, tramite le sue azioni, la “perdita” della natura. Nello specifico per Caproni in questo componimento le “cose perdute” sono: il mare, il vento, i pini, i pesci uccisi per guadagni e tutti gli elementi naturali della terra ma la cosa che si sta perdendo per eccellenza è la natura stessa e colui che porta a questa perdita è l’uomo con le sue azioni.
2.2 La lirica presenta un’unica strofa ma se leggiamo attentamente l’intero componimento possiamo notare che può essere diviso in due parti: la prima parte comprendente i versi dall’uno al dieci è caratterizzata da una serie di imperativi negativi in cui l’autore invita l’uomo e non compiere quelle azioni che sono nocive per la natura, questa prima parte ha quindi una funzione educatrice nei confronti dell’uomo; nella seconda e ultima parte invece l’autore descrive gli elementi naturali come portatori d’amore e sostiene quindi che nel momento in cui questi cesseranno di esistere allora finirà anche l’amore stesso, sostenendo infine che la terra tornerà a essere bella solo nel momento in cui l’uomo non ci sarà più vuole indicare in questa seconda parte la soluzione al problema ecologico che affligge la terra.
2.3 Le azioni dell’uomo nei confronti della natura sono indicate nel componimento da una serie di verdi che nella maggior parte dei casi sono posti in negativo, l’uomo infatti, per l’autore, non deve “uccidere” la natura, non deve “soffocare” il canto degli animali e non deve “fulminarli” (inteso come uccisione rapida degli animali). l’autore utilizza la negazione proprio per indicare il fatto che lui vuole contrastare queste azioni che gli uomini compiono. Da queste azioni potrebbe e mergere, a primo avviso, un atteggiamento passivo da parte della natura nei confronti dell’uomo ma l’autore nella conclusione della lirica ci dice esplicitamente che la terra, quindi la natura stessa, sarebbe più bella se lo stesso uomo scomparisse, l’uomo quindi può compiere qualsiasi azione negativa nei confronti della natura ma non riuscirà mai a abbatterla definitivamente.
2.4 Nei versi sette e otto il poeta scrive: “ e chi per profitto vile fulmina un pesce”, rivelando al lettore la motivazione per cui l’uomo compie quelle determinate azioni nei confronti della natura; questa motivazione è esplicitamente il profitto personale, il guadagno che l’uomo ottiene tramite lo sfruttamento delle risorse naturali, in questo caso l’autore fa riferimento alla pesca ma accusa anche le altre azioni che portano alla diminuzione di tutte le risorse naturali.
2.5 L’autore in questo componimento critica la società moderna che talvolta elogia chi compie azioni irrispettose nei confronti della natura; questa critica viene esposta da Caproni nei versi dieci e undici in cui l’autore con la sentenza: “non fatelo cavaliere del lavoro” accusa chi premia coloro che, tramite determinate azioni, traggono profitto dalla natura.
2.6 L’autore nell’intero componimento indica il fatto che l’uomo senza la natura non potrebbe sopravvivere dichiarando che l’uomo stesso è fatto di mare, di vento di pini quindi della natura intera come sostiene nel verso 6 “anche di questo è fatto l’uomo”, ma in particolar modo l’uomo ha bisogno della natura per il proprio sostentamento infatti l’uomo da sempre vive grazie a ciò che essa gli offre. La natura al contrario secondo il poeta potrebbe vivere senza l’uomo anzi vivrebbe meglio come lo stesso scrittore sostiene negli ultimi tre versi “ come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l’uomo, la terra”.
2.7 Nell’ultima parte della poesia Caproni definisce il mondo “guasto” a causa di ciò che l’uomo ha compiuto e il sentimento di chi resta è quello dei sospiri cioè della tristezza e della rassegnazione al fatto che ciò che è andato perduto non può essere in alcun modo recuperato.
2.8 L’autore attua determinate scelte stilistiche per coinvolgere il lettore e fargli capire il significato della poesia; i versi non presentano la stessa misura e questo fa si che il lettore venga coinvolto dalla poesia stessa, inoltre l’intero componimento è colmo di enjambement, questa determinata figura retorica aiuta il lettore a interessarsi maggiormente a ciò che sta leggendo poiché l’interruzione dei un determinato concetto in un verso e il continuo di questo nel verso successivo invita il lettore a voler proseguire con la lettura. Nonostante questa lirica non segua uno schema tradizionale sono comunque presenti rime assonanze e consonanze; le rime sono presenti nei versi due e tre: vento/ lamento, nei versi quattro e cinque: lamantino/ pino e nei versi tredici e quattordici: foresta/resta; le assonanze nei versi quindici e sedici: vasto/guasto e nei versi diciassette e diciotto: bella/terra; le consonanze nei versi tre e quattro: lamento/lamantino. L’utilizzo di queste scelte stilistiche da parte dell’autore sono quindi utili alla comprensione generale del testo.
A cura di Simona Pani




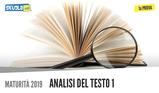

 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo