Concetti Chiave
- Alessandro Manzoni, autore del Romanticismo italiano, fu influenzato dalla cultura milanese dell'800 e dalla sua conversione religiosa, che influenzò profondamente le sue opere.
- Manzoni si dedicò principalmente alla ricerca del "Vero" nella letteratura, opponendosi agli eccessi mitologici del Romanticismo, privilegiando invece la verosimiglianza e l'utilità morale delle opere.
- Le sue tragedie storiche, "Il Conte di Carmagnola" e "Adelchi", si distinguono per la base storica e la critica alla sostituzione di un dominatore con un altro nell'Italia medievale.
- "I Promessi Sposi" è un romanzo storico che ha rivoluzionato la letteratura italiana, introducendo una lingua più moderna e dando voce agli umili, con personaggi sia positivi che negativi.
- L'"Addio ai monti" è un passaggio lirico del romanzo che esprime i sentimenti di perdita e nostalgia di Lucia mentre lascia il suo paese, riflettendo anche le riflessioni dell'autore sulla condizione umana.
Questo appunto di Italiano illustra in breve la produzione letteraria di Alessandro Manzoni, insieme al contesto biografico e storico-letterario che l'ha caratterizzata. In seguito, si descrivono e commentano brevemente l'Adelchi e i Promessi Sposi.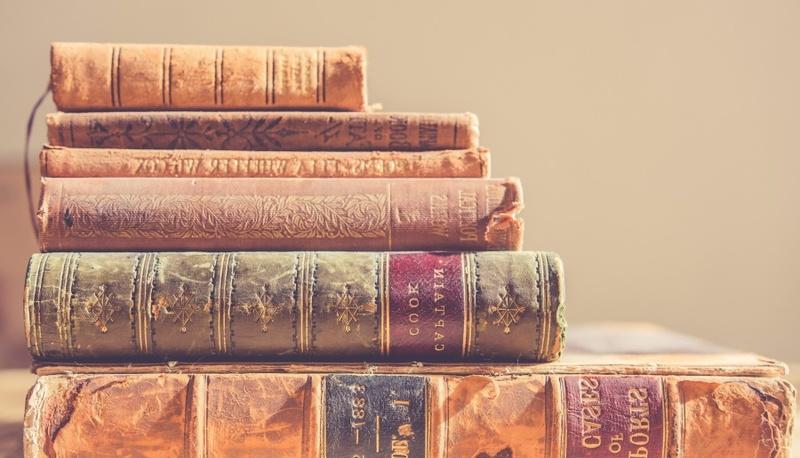
Indice
Alessandro Manzoni e il Romanticismo
Alessandro Manzoni è uno scrittore del Romanticismo italiano. Nacque a Milano nel 1785 e morì nel 1873. Figlio di Giulia Beccaria e del Conte Manzoni (anche se è quasi certo che non sia figlio suo, ma bensì di un altro tra diversi uomini, tra cui Carlo Imbonati). Ricevette un’educazione molto religiosa e visse la sua giovinezza a Milano, dove fece studi di carattere umanistico. La Milano dell’’800 era molto attiva culturalmente: vi erano i caffè, i giornali e vi lavoravano personaggi di spicco, tra cui Vincenzo Monti. Nel 1808 Manzoni sposò Enrichetta Blondel secondo il rito calvinista (lei professava questa dottrina). Il confronto tra calvinismo e cattolicesimo causò nell’autore una riflessione sulla religione, a cui si avvicinò definitivamente – si dice – a seguito di un episodio particolare: pare che Manzoni colse l’ispirazione per la propria conversione in una chiesa in cui trovò rifugio in un momento di forte panico (il cosiddetto Miracolo di San Rocco). Nel 1810, quindi, i due decisero di sposarsi nuovamente con il rito cattolico, fatto che portò anche la donna ad abiurare il calvinismo. Manzoni era vicino, in particolare, al Giansenismo (dottrina che prevedeva una vita rigorosissima per evitare i peccati che si compiono nella vita), anche perché aveva una concezione della vita molto negativa. Tutta la sua letteratura si sviluppò prima del ’40, perché successivamente si dedicò alla composizione di scritti minori. Dopo il 1840 Manzoni decise di non scrivere più romanzi storici perché gli altri autori, pur imitandolo, restavano lontani dal Vero. Tuttavia, secondo l’autore, le finalità dell’arte sono l’utile, il vero e l’interessante; quando uno scrittore dà vita all’opera, questa deve essere utile (civilmente e moralmente) non si deve allontanare dal vero e dev’essere anche allettante per il pubblico (utilizzando la verosimiglianza nell’invenzione poetica). Manzoni, in tutta la sua produzione, inseguì il concetto di Vero (verosimiglianza dei fatti), ed è per questo che non accettava gli eccessi del Romanticismo, come ad esempio il ricorso alla mitologia.Il Romanticismo è un fenomeno proveniente dal nord Europa, e il suo precursore era lo “sturm und drang” tedesco, sbocciato grazie alla rivista “Athenaeum”. Con il Romanticismo si inizia a parlare di poesia soggettiva, sentimentale, che si contrappone al fallimento della ragione del ‘700 (Illuminismo). Questo fenomeno occupa la prima metà dell’800, mentre nella seconda metà si parla di Simbolismo, una sfumatura del Romanticismo che ha come maestro Baudelaire. I poeti simbolisti erano considerati maledetti perché si riunivano nella riva sinistra della Senna a Parigi e avevano una vita sregolata, all’insegna della ricerca dell’alterazione della psiche. A partire dall’’800 si diffonde la cultura di massa: il popolo (borghesia) richiede agli artisti opere confacenti ai propri gusti, creando un sentimento di disagio in essi che li porta a manifestare una frattura tra il lavoro interiore ed il mondo esterno. Baudelaire pubblicò nel 1853 l’opera “I fiori del male”, e nella poesia “Albatros” scrisse quello che può essere preso come esempio del tipo di sentimenti che un poeta romantico nutriva verso la società del suo tempo. L’albatros è un possente uccello marino, con ali molto grandi e zampe piccole e goffe; questo animale vola al di sopra delle tempeste, è ben visibile ai marinai durante la navigazione, ma quando si posa è oggetto di derisione perché trascina le ali sproporzionate rispetto alle zampe e al resto del corpo. Questa è la metafora della vita dell’artista: un titano capace di volare sopra le tempeste della vita, ma incompreso e deriso. I poeti romantici erano accomunati dalla tendenza verso l’Assoluto o Infinito, che può essere tale in senso cristiano (come in Manzoni) o laico (come in Leopardi). In Italia, negli stessi anni in cui Manzoni era a Milano, venne pubblicata nella rivista “La Biblioteca Italiana” la lettera di Madame De Staël intitolata “Utilità delle traduzioni” (1813), in cui invitava gli scrittori italiani ad abbandonare lo stampo classicista nella letteratura e ad aprirsi alle istanze romantiche. Questa lettera segna l’inizio del Romanticismo in Italia, ed è risaputo che Manzoni stesso la lesse. Quando venne pubblicata la lettera di Madame De Staël, vi fu una spaccatura tra classicisti (conservatori, come Pietro Giordani, mentore di Leopardi), che ritenevano importante il passato, e romantici, (favorevoli alle nuove idee, tra cui Berchet). Per gli intellettuali del primo Ottocento era difficile dare vita ad una vera poesia soggettiva, poiché essi non si sentivano ancora “albatros”: nella società italiana aveva molta importanza la classe borghese (Rivoluzione Industriale) e, mentre nel nord Europa il poeta era escluso, in Italia gli intellettuali erano ancora impegnati politicamente (si stava preparando il Risorgimento). Quando, nel 1861, l’Italia si unì e gli stranieri emigrarono, gli intellettuali italiani si trovarono a non avere più un ruolo; infatti, in quel periodo, nacque a Milano il movimento della “Scapigliatura milanese”, simile alla Bohème.
Tra le opere di Alessandro Manzoni ricordiamo:
- Gli Inni Sacri.
- Le Odi: Marzo 1821, che fa riferimento ai moti rivoluzionari del 1821 dei Lombardi, che volevano uno statuto, e Il Cinque Maggio, dedicata a Napoleone.
- Le Tragedie: Il conte di Carmagnola e Adelchi, nel quale si fa un riferimento a Carlo Magno e alla dominazione longobarda il Italia.
- I Promessi Sposi: pubblicato inizialmente nel ‘23 con il nome di “Fermo e Lucia”, poi nel ’27 come “Renzo e Lucia” e infine nel ’40 nella versione definitiva. L’ultima edizione dei Promessi Sposi (1840), venne rivista linguisticamente, sostituendo i termini lombardi con quelli fiorentini (risciacquatura in Arno), dando vita all’italiano moderno. I Promessi Sposi sono un romanzo storico (base storica, ma trama inventata), che parla di due innamorati che tentano in tutti i modi di sposarsi, riuscendoci solo alla fine. L’ambientazione è popolare (prima di lui il popolo non aveva mai avuto modo di essere considerato nella letteratura). Quando si parla dei personaggi ecclesiastici, si hanno sia esempi negativi (Don Abbondio) sia positivi (frate Cristoforo).
Le tragedie manzoniane: Adelchi
Manzoni scrisse due tragedie: “Il Conte di Carmagnola” e “Adelchi”. Mentre le scriveva, la sua preoccupazione era la considerazione del vero, infatti hanno entrambe una base storica (tragedie storiche). Il teatro manzoniano è diverso da quello alfieriano: Manzoni non rispetta le tre unità aristoteliche, perché altrimenti si altererebbe il tessuto del vero.L’Adelchi parla di un momento della storia medioevale d’Italia, ossia di quando la parte settentrionale venne invasa dalle popolazioni germaniche, in particolare dai Longobardi, con a capo il re Desiderio, che aveva due figli, Adelchi ed Ermengarda (che fu data in sposa al re dei Franchi Carlo Magno). I Longobardi, dopo aver conquistato il settentrione della penisola, volevano espandere i loro confini verso lo Stato Pontificio, dove il Papa, vistosi in pericolo, chiamò in aiuto Carlo Magno. Così i Franchi scesero in Italia per sconfiggere i Longobardi. Adelchi, più volte, cercò la tregua, ma Desiderio decise comunque di combattere contro i Franchi, aiutati anche da baroni longobardi traditori. Morirono sia Ermengarda che Adelchi, che lottò fino alla fine. Carlo Magno, in nome della ragione di stato, ripudiò la moglie. La storia, però, non parla dei sentimenti di Adelchi e di Ermengarda, e così Manzoni decise di raccontarla, ricavando nella storia (precisamente in due cori) uno spazio poetico personale (il “cantuccio”) dove poter dare vita alla sua invenzione. Questo spazio è presente nel coro dell’atto terzo e in quello dell’atto quarto. Nel coro dell’atto terzo (11 strofe in dodecasillabo) si parla dei sentimenti del popolo latino. Il popolo latino è importante perché quando i Longobardi arrivarono sottomisero i Latini, ossia le popolazioni che già abitavano quelle terre (si fa un riferimento agli Austriaci in chiave letteraria) e questi, quando vennero a sapere dell’arrivo dei Franchi per cacciare la dominazione precedente, esultarono; Manzoni fa un monito al popolo latino (e quindi anche a quello italiano): a un vecchio signore se ne sostituisce uno nuovo, quindi non è possibile che a un dominatore cattivo se ne sostituisca uno buono. Il testo è ricco di figure retoriche, soprattutto latinismi, per rafforzare la natura epica; la descrizione procede per parallelismi o antitesi. Nel coro dell’atto quarto, invece, viene descritta Ermengarda che, dopo essere stata rifiutata, si rifugiò nel convento di suore dove la sorella era la badessa; in questo convento ella si strusse di dolore per l’abbandono da parte del marito, fino alla morte. Tuttavia la sua morte non fu inutile, perché quella sofferenza la rese degna di salire al cielo. Ermengarda passa quindi dalla categoria dei signori/vincitori a quella degli umili/vinti (da questo fatto emerge che Manzoni è un poeta romantico). Nonostante l’ambientazione aristocratica, l’autore comincia a dare sempre più importanza agli umili.
Nella tragedia manzoniana emerge il concetto di provvida sventura (ossimoro): la sventura, il male e il dolore che caratterizzano la vita non sono inutili, infatti queste pene rendono degna Ermengarda di salire in paradiso. Questo concetto è presente sia nell’Ode a Napoleone (dove egli immagina Napoleone, relegato a Sant’Elena, gravemente malato, a vivere i suoi ultimi anni di vita, durante i quali si convertì al Cristianesimo), sia nei Promessi Sposi.
Per ulteriori approfondimenti sulle tragedie manzoniane vedi anche qua
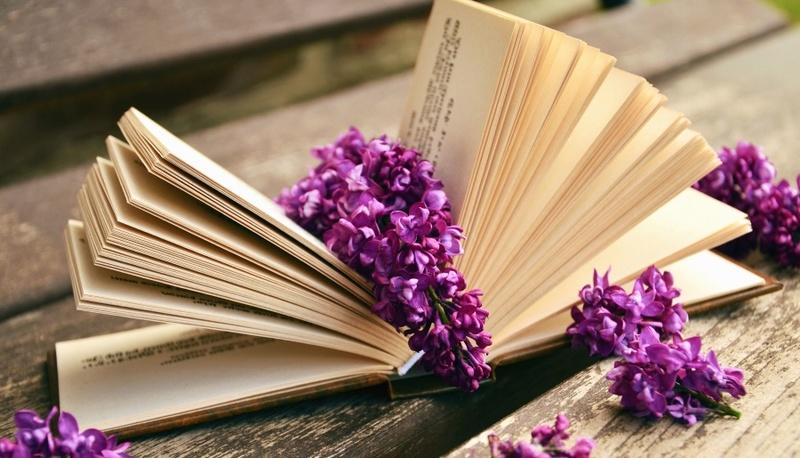
I Promessi Sposi e l’Addio ai monti
La prima versione del romanzo (“Fermo e Lucia”) venne pubblicata nel 1823. Il romanzo storico era già stato scritto dallo scozzese Walter Scott nell’opera Ivanhoe; tuttavia, anche se la base era storica, vi erano parti romanzate. Manzoni aveva dubbi che il suo romanzo non fosse un vero e proprio romanzo storico, e pensava che non combaciasse con il vero, e quindi vi rimise mano e pubblicò il “Renzo e Lucia” nel 1827, con un differente contenuto (la versione precedente aveva un intreccio più simile a un giallo), assumendo la forma definitiva (nella quale vennero anche cambiati dei nomi). A quel punto Manzoni fece un lavoro di revisione linguistica (“risciacquatura in Arno”), pubblicando nuovamente l’opera nel 1840. Manzoni aveva anche incaricato un illustratore milanese di accompagnare la storia con immagini, e venne infine aggiunta un’appendice.La storia è narrata in terza persona e, grazie all’espediente del manoscritto ritrovato, il narratore è onnisciente, così da poter intervenire nel tessuto storico (e commentare i fatti storici); inoltre, la narrazione non è di tipo oggettivo. Egli aveva già accennato di voler dare opera agli umili in alcuni suoi trattati teorici, e nei Promessi Sposi egli compie finalmente il suo volere. Renzo Tramaglino è un filatore di seta che, in seguito, diventa un piccolo imprenditore, mentre Lucia Mondella è una ragazza del popolo. La dominazione spagnola del ‘600 è un riferimento alla dominazione austriaca dell’’800. Don Abbondio è un curato che viene intercettato dai Bravi, i quali gli intimano di non celebrare le nozze dei due protagonisti, perché Don Rodrigo, il signorotto del luogo, si è invaghito di Lucia. Il prete è un personaggio pirandelliano, perché è una figura apparentemente comica, ma in realtà drammatica, infatti è detta umoristica (come Pirandello chiamava questo genere di personaggi). Quando una persona è il contrario di quello che dovrebbe essere, è comica ma, riflettendo sul suo vero compito, questa diventa drammatica. Pirandello faceva un esempio per far capire meglio questo termine: immaginando una vecchia signora che si concia come una ragazza giovane, si tinge i capelli, si veste tutta colorata, alla vista risulta il contrario di quello che dovrebbe essere, e questo è comico; tuttavia, riflettendo sulle motivazioni che l’hanno spinta a vestirsi così (per esempio, per tenersi il marito giovane), da comico il personaggio diventa drammatico, passando all’umorismo. Un personaggio umoristico è un personaggio grottesco. Sempre per quanto riguarda i personaggi, è importante ricordare che nella seconda metà dell’800 si sviluppò il Verismo, e Verga scrisse “I Malavoglia”, in cui il popolo viene descritto in maniera negativa, al contrario della visione precedente, in cui il popolo era depositario di valori morali. Nel romanzo, il sistema dei personaggi è composto da: positivi e negativi (don Abbondio, fra Cristoforo, cardinale Borromeo, monaca di Monza), dinamici (Renzo) e statici (Lucia).
L’Addio ai monti è uno dei più celebri brani del romanzo. Fa parte dell’ottavo capitolo, ed è una descrizione di grande impatto sia del paesaggio del lago di Como, sia dei sentimenti di Lucia. Renzo e Lucia, non riuscendo ad estorcere il matrimonio a Don Abbondio, sono costretti ad abbandonare il paese. Manzoni scrive i pensieri di Lucia che, su di una barca che attraversa il lago di Como, saluta per l’ultima volta i monti dove è cresciuta. Questo testo è una poesia lirica, con un primo periodo dalla struttura circolare, che un popolano non avrebbe mai potuto pronunciare; il linguaggio a lei attribuito, infatti, è molto più elevato di quanto avrebbe potuto essere realisticamente: sebbene i pensieri espressi siano veicolati dal personaggio di Lucia, è in realtà l’autore stesso a riflettere sulla difficoltà e la tristezza di lasciarsi alle spalle una casa, tuffandosi nell’ignoto.
Per ulteriori approfondimenti sul capitolo VIII dei Promessi Sposi vedi anche qua
Domande da interrogazione
- Qual è il contesto storico e biografico di Alessandro Manzoni?
- Quali sono le caratteristiche principali delle tragedie manzoniane?
- Come si sviluppa il tema del Romanticismo nei Promessi Sposi?
- Qual è il significato del concetto di "provvida sventura" nelle opere di Manzoni?
- In che modo Manzoni ha influenzato la lingua italiana con i Promessi Sposi?
Alessandro Manzoni, nato a Milano nel 1785 e morto nel 1873, è un esponente del Romanticismo italiano. Ha ricevuto un'educazione religiosa e ha vissuto in un periodo di fervore culturale a Milano. La sua conversione al cattolicesimo è legata a un episodio noto come il Miracolo di San Rocco.
Le tragedie di Manzoni, come "Il Conte di Carmagnola" e "Adelchi", sono basate su eventi storici e si concentrano sul concetto di "vero". Manzoni non segue le tre unità aristoteliche per mantenere l'autenticità storica.
Nei "Promessi Sposi", Manzoni esplora il Romanticismo attraverso la rappresentazione degli umili e l'uso di un linguaggio elevato per esprimere sentimenti profondi, come nell'"Addio ai monti", dove Lucia riflette sulla sua partenza dal paese natale.
Il concetto di "provvida sventura" rappresenta l'idea che il dolore e la sofferenza non siano inutili, ma possano portare a una redenzione spirituale, come illustrato nei personaggi di Ermengarda in "Adelchi" e nei "Promessi Sposi".
Manzoni ha contribuito alla formazione dell'italiano moderno attraverso la revisione linguistica dei "Promessi Sposi", sostituendo i termini lombardi con quelli fiorentini, un processo noto come "risciacquatura in Arno".








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo