Concetti Chiave
- Sallustio, nato nell'86 a.C., fu un homo novus nella politica romana e, dopo accuse di corruzione, si ritirò per dedicarsi alla storiografia.
- La "Congiura di Catilina" analizza il tentativo di Catilina di impadronirsi del potere, con una critica alla degenerazione politica romana e un ritratto di figure come Cesare e Catone.
- Nel "Bellum Iugurthinum", Sallustio esplora la corruzione della nobiltà romana durante la guerra contro Giugurta e l'ascesa di figure come Mario.
- Le "Historiae", rimaste incomplete, coprono eventi dal 78 al 67 a.C. e riflettono il pessimismo di Sallustio dopo la morte di Cesare.
- Sallustio è noto per uno stile storiografico influenzato da Tucidide e Catone, caratterizzato da linguaggio arcaico e brevitas.
Vita di Sallustio
Sallustio nacque nell'86 a.C. ad Amiterno (l'Aquila) da famiglia benestante che però non aveva mai dato magistrati allo stato, era perciò un homo novus; a Roma compì gli studi e si interessò alla vita politica: nel 55 o nel 54 fu questore, nel 52 tribuno della plebe e condusse una violenta campagna contro Milone, uccisore di Clodio, e contro Cicerone suo difensore, venne espulso dal senato con l’accusa di immoralità. Nella guerra civile, nel 49, si schierò a favore di Cesare, così fu riammesso in senato, divenne pretore e dopo la battaglia di Tapso divenne governatore dell'Africa Nova. Sallustio fu un governatore corrotto, accusato di malversazione per evitare una seconda espulsione si ritirò dalla politica dedicandosi alla storiografia in una lussuosa dimora: gli Horti Sallustiani. Morì tra il 35 e il 34 a.C.Compose due monografie: la Congiura di Catilina e il Bellum Iugurthinum, tra il 43 e il 40; e un'opera storica: le Historiae. Nelle due monografie (narrazione di un singolo avvenimento) ci sono due lunghi proemi, scritti per giustificare il passaggio dal negotium (attività politica) all'otium (attività letteraria), poichè per lui fare la storia è più importante che scriverne; il suo modello fu Tucidide che narrò la guerra del Peloponneso, a sua volta, Sallustio sarà il modello di Tacito.

La Congiura di Catilina
La prima monografia di Sallustio è dedicata al tentativo eversivo di Catilina di impadronirsi del potere (63-62 a.C).All'inizio dedica un ampio excursus ('archeologia') che traccia una storia dall'ascesa alla decadenza di Roma, il punto di svolta è la distruzione di Cartagine, con cui cessò il metus hostilis (timore verso i nemici); un secondo excursus denuncia la degenerazione della vita politica dalla dominazione di Silla alla guerra civile.
Sallustio riponeva tutte le sue aspettative sull'attuazione di un regime autoritario che ponesse fine alla crisi dello stato in Cesare, di questo personaggio è significativo il discorso che pronuncia per sconsigliare la condanna dei catilinari preoccupato per l'ordine e la legalità; subito dopo Cesare parla Catone. Lo storico delinea un ritratto di entrambi: Cesare si sofferma su liberalità, munificentia, misericordia e sulla sua brama di gloria; Catone, invece, si sofferma su integritas, severitas e innocentia. Pur descrivendo due ritratti diversi, quindi due pareri opposti, Sallustio afferma che entrambi erano complementari e positivi per lo stato romano. La figura di Cicerone subisce un ridimensionamento, poichè, per Sallustio, non è il politico che domina gli eventi, ma un magistrato che pur non essendo un eroe supera inquietudini e debolezze. La grandezza invece, anche se è una grandezza malefica, viene attribuita alla figura di Catilina.
Il Bellum Iugurthinum
La seconda monografia di Sallustio, la Guerra contro Giugurta (111-105 a.C.), affronta l'incapacità della nobiltà di difendere lo stato. Giugurta re di Numidia, aveva corrotto i romani inviati in Africa per combatterlo, sancendo una pace. Metello, inviato in Africa, ottenne successi significativi, ma Mario, il suo luogotenente, dopo essere stato eletto console nel 107 portò a termine la guerra. Giugurta tradito da Bocco, re di Mauritania, viene consegnato ai Romani. Anche in questa monografia c'è un excursus che indica nel mos partium et factionum (contesa tra le fazioni in lotta, 'aristocrazia e populares') la causa della lacerazione e della rovina della res publica e si fa più evidente l'ostilità verso la nobilitas corrotta. I discorsi da ricordare sono: quello del tribuno Memmio che per protestare contro la politica inconcludente del senato, invita il popolo alla riscossa contro i pauci (oligarchia dominante) e enumera i mali dell'aristocrazia: tradimento degli interessi della res publica, dilapidazione del denaro pubblico, monopolizzazione delle ricchezze e delle cariche; e il discorso di Mario che convince la plebe ad arruolarsi in massa, il motivo è la nascita della virtus (nuova aristocrazia) che si fonda sui talenti naturali di ciascuno e non sul diritto di nascita. Sallustio per quest'ultimo ha molta ammirazione, poichè seppe opporsi ai nobili, ma è limitata dalla consapevolezza delle sue responsabilità future, infatti già l'arruolamento dei nullatenenti è disapprovato, visto che vede gli eserciti professionali fedeli al generale ma non alla repubblica. Quanto al ritratto di Giugurta, la personalità del re barbaro è rappresentata in evoluzione: non è corrotto fin dall'inizio, è solo un piccolo tiranno perfido, ambizioso e privo di scrupoli.

Le Historiae
Quest'opera storica rimasta incompiuta a causa della sua morte, segna il ritorno all'annalistica. Trattava gli avvenimenti dal 78 al 67, ci sono giunti alcuni frammenti, quattro discorsi e un paio di lettere. A causa della morte di Cesare, l’opera è pervasa da grande pessimismo, poichè lo storico non aveva più una parte dalla quale schierarsi e vedeva affacciarsi sulla scena politica solo avventurieri, demagoghi e aristocratici corrotti.Sallustio fissa lo stile della storiografia, grazie ai modelli di Tucidide e Catone il Censore, fondato sull'inconcinnitas (asimmetria), sulla variatio di costrutto; il linguaggio è arcaizzante; usa molte figure retoriche e si astiene dagli effetti drammatici, che suscitano emozioni, il risultato è la brevitas: la coincisione.
Domande da interrogazione
- Qual è l'importanza delle monografie di Sallustio nella sua carriera?
- Come viene rappresentato Catilina nella "Congiura di Catilina"?
- Quali sono le critiche di Sallustio alla nobiltà romana nel "Bellum Iugurthinum"?
- Qual è il ruolo di Cesare e Catone nella "Congiura di Catilina"?
- Quali sono le caratteristiche stilistiche delle "Historiae" di Sallustio?
Le monografie di Sallustio, "La Congiura di Catilina" e "Il Bellum Iugurthinum", sono fondamentali nella sua carriera poiché segnano il suo passaggio dalla politica alla storiografia, giustificato nei proemi delle opere. Queste monografie analizzano eventi specifici e criticano la degenerazione politica di Roma.
Nella "Congiura di Catilina", Sallustio attribuisce a Catilina una grandezza malefica, descrivendolo come una figura centrale e potente, nonostante la sua natura eversiva. La sua rappresentazione è complessa e centrale nella narrazione dell'opera.
Nel "Bellum Iugurthinum", Sallustio critica la nobiltà romana per la sua incapacità di difendere lo stato e per la corruzione dilagante. Denuncia la contesa tra fazioni e l'aristocrazia corrotta, evidenziando il tradimento degli interessi pubblici e la dilapidazione delle risorse.
Nella "Congiura di Catilina", Cesare e Catone rappresentano due visioni opposte ma complementari per lo stato romano. Cesare è descritto per la sua liberalità e misericordia, mentre Catone è caratterizzato da integrità e severità. Entrambi sono visti come figure positive per Roma.
Le "Historiae" di Sallustio sono caratterizzate da uno stile annalistico, influenzato da Tucidide e Catone il Censore. Utilizza l'inconcinnitas e la variatio di costrutto, con un linguaggio arcaizzante e molte figure retoriche, evitando effetti drammatici per ottenere brevitas e concisione.

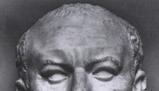






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo