Concetti Chiave
- Sallustio, attraverso le sue opere, mostra un pensiero politico democratico e filocesariano, pur criticando la nobilitas e sostenendo le classi più basse.
- Nel "De Coniuratione Catilinae", Sallustio evidenzia la crisi morale di Roma e ritrae Catilina come un personaggio complesso, alternando condanna e simpatia.
- Il "Bellum Iughurtinum" affronta la corruzione della nobilitas e celebra Gaio Mario come esempio di integrità e rinnovamento politico.
- Le "Historiae" segnano un ritorno al genere analistico per Sallustio, con un'analisi più ampia delle cause della crisi romana, inclusa la dominatio di Silla.
- Sallustio utilizza la storiografia come strumento per esplorare le degenerazioni morali e politiche, mantenendo un approccio critico e riflessivo.
Tra il 50 e il 46 a.C. Sallustio scrive le Epistulae ad Cesarem. Non è sicuro che queste siano autentiche, in realtà potrebbero essere l’esercitazione di un retore dell’età imperiale.
Ma comunque noi ce ne serviamo per definire meglio il pensiero politico di Sallustio. Quest’ultimo è orientato in senso democratico e filocesariano. Democratico non in senso moderno (potere al popolo) ma piuttosto con un’idea moderata della democrazia; così come Cesare.
Cesare nel suo modo di fare era contrario sia alla nobiltà sia a ogni forma di sovvertimento sociale; quindi a favore dei boni cives (borghesia). Nella guerra civile egli si oppone infatti sia alla nobilità senatoriale che a sovvertimenti sociali. Appoggia così solamente il ceto medio.
Sallustio d’altro canto tende ad appoggiare i ceti più bassi, perché egli stesso di origine plebea.
A differenza di Cesare vuole un capovolgimento sociale. Questo lo porta ad avere ora un atteggiamento di condanna ora di simpatia nei confronti di Catilina.
Sallustio aveva aderito al programma di Cesare e in queste Epistulae gli esprime il suo pensiero:
1)Aspira alla fine dei conflitti attraverso la pacificazione sociale con l’uso della clementia
2)Auspica delle riforme per risolvere la sperequazione che a suo giudizio è la causa della crisi del suo tempo
3) Auspica una moralizzazione della vita pubblica attorno ai valori del mos maiorum
4)Infine vuole rimuovere l’accusa rivolta a Cesare di aspirare al regnum (potere assoluto) perché in realtà pensa che chi applica le leggi dello Stato a beneficio di molti non è un dittatore. Anzi a proposito di Cesare si può parlare di dominatio più che di dittatura.
Per la stesura dell’opera, Sallustio predilige il genere monografico a quello analistico (cioè quello che offriva molto a chi voleva riallacciare rapporti con il passato). La motivazione della scelta del genere monografico deve essere ricercata negli obiettivi che Sallustio si era proposto di raggiungere raccontando storiograficamente episodi a lui contemporanei.
Considerando la storiografia come strumento d’indagine, vuole andare a rintraciare tutti quei fatti che avevano contribuito alla caduta dello Stato.
Tra questi fatti egli sceglie il più significativo: la congiura di Catilina.
Comincia col dire, nella parte introduttiva, di voler raccontare la verità, perché il pericolo corso dallo Stato era stato davvero molto serio.
L’opera vera e propria comincia con il ritratto di Catilina che risulta quasi poetico. Ccomincia poi, ad analizzare tutte le vicende della Storia di Roma, mettendo in luce un lento declino fino alla crisi del suo tempo, che è una crisi morale. E’ normale che in una simile società corrotta Catilina abbia trovato dei seguaci, non solo plebei ma anche nobili.
Nel Cap. 17 fa una lista di chi aveva aderito. Poi descrive attraverso un flashback una precedente congiura che lo stesso Catilina aveva ordito nel 66 a.C.
Dopo questo flashback analizza tutti i fatti che vanno dal 64 (insuccesso politico di Catilina) al 62 (sconfitta di Catilina). In seguito vi è il racconto del processo nel quale discorsero Cesare e Catone l’Uticense.
Cesare viene presentato come simbolo della clementia, mentre Catone come simbolo dell’integrità morale. Secondo Sallustio l’unione delle due caratteristiche potrebbe portare lo Stato alla gloria.
La congiura si conclude con lo scontro dei congiurati a Pistoia. La parte finale dell’opera si conclude con la rappresentazione del coraggio di questi uomini.
Ma perché allora Sallustio è così ambiguo? Parla prima male di questi ultimi e poi li elogia? In fondo Sallustio ha simpatia per Catilina, che nonostante nobile e corrotto vuol difendere la plebe.
Catilina è una persona eccezionale, che si distingue dalla massa.
Gli obiettivi fondamentali di quest’opera sono ovviamente di natura politica:
1)smascherare la corruzione dei giovani Romani che sono sempre pronti a sobillare la plebe per trarne dei vantaggi
2)scagionare Cesare dall’accusa di essere stato l’ispiratore della congiura
3)mettere in ombra il ruolo giocato da Cicerone (pater patriae)
Ultimo dilemma: Sallustio è obiettivo o meno?
Se per obiettività intendiamo il racconto fedele e dettagliato dei fatti allora non lo è. Se per obiettività invece riteniamo lo sforzo sincero di raccontare questi fatti senza rinunciare a dare la propria interpretazione allora è più sincero di altri storiografi.
Rispetto alle opere successive quest’opera non è perfetta ma presenta dei limita: la figura di Catilina predomina su tutto il resto; ci sono inesattezze ed anacronismi; ci sono parti come il proemio e il ritratto di Catilina un po’ scollate dal resto dell’opera.
La seconda monografia di Sallustio è il Bellum Iughurtinum. In quest’opera Sallustio vuole dimostrare come la disgregazione morale della nobilitas ha determinato la crisi della Repubblica. Allora la guerra Giugurtina gli sembra significativa perché in quell’occasione si erano presentati i primi segnali della degenerazione morale. Sallustio scrive l’opera nel 41. Apre l’opera con un proemio introduttivo di carattere moralistico una serie di riflessioni sulla natura umana. Comincia il racconto descrivendo la situazione del regno di Numidia alla morte del re Micipio. 3 personaggi si contendevano il regno: i figli del re Aderbale e Iempsale e il nipote Giugurta. Giugurta viene descritto come un personaggio politicamente abile e intelligente che prima elimina Iempsale e rimasto solo con Aderbale, che chiese l’aiuto di Roma, convince i Romani che la cosa migliore da fare è dividere il regno di Numidia in modo da renderlo più governabile.
Ma Giugurta si prende gioco di loro ed uccide Aderbale. Si scatena così la guerra che sarebbe durata 6 anni.
La guerra viene descritta dettagliatamente per dimostrare che tutti i militari impegnati in quella battaglia erano incapaci e appartenenti alla nobilitas.
Furono sconfitti fino all’arrivo di Gaio Mario, homo novus non appartenente alla nobilitas con valori sani e non appartenenti alla corruzione di quest’ultima.
Ad aiutare Giugurta giunse il Re della Mauritania.
Obiettivo di Sallustio è contrapporre alla nobilitas l’homo novus.
Tutto ciò si ricava dal ritratto solenne e celebrativo che Sallustio lascia di Mario. In quest’opera Sallustio è molto più sensibile nell’analisi politica e storiografica. Infatti non si limita a descrivere la sola guerra Giugurtina ma arriva fino ai moti dei Gracchi dove vede i primi sintomi del cedimento morale che nel corso degli anni avrebbe determinato la crisi della Repubblica. Si deve precisare che quando S. analizza i Gracchi è molto ponderato ed equilibrato e si allontana da posizioni estremiste che i capi democratici avevano assunto in passato.
Perciò dobbiamo considerare quest’opera come un’opera molto più matura della precedente:
1)non ci sono squilibri strutturali
2)l’impianto narrativo è più saldo
3)la concezione della storia è più profonda
Il moralismo esorbitante della prima opera cede il passo ad un’indagine storiografica che pur privilegiando le motivazioni morali prende però in esame altri elementi come ad esempio problemi economici e contrapposizioni politiche.
Qui inoltre i ritratti non prevaricano più sul resto della trattazione ma si fondono armonicamente con il resto dell’opera.
Di conseguenza, i personaggi sono più vivi perché non osservati esclusivamente dal punto di vista morale ma in relazione alla classe sociale di appartenenza e dell’ambiente.
L’ultima opera di Sallustio è le Historiae, alla quale si dedicò fino alla sua morte che avvenne nel 35 a.C.
Le Historiae sono un’opera di genere analistico.
C’è da domandarsi quindi perché questo passaggio?
Magari voleva continuare le storie di Cornelio Sisunna?
Probabilmente voleva tentare un discorso più ampio e articolato che non cogliesse solo alcuni aspetti della crisi ma tutte le cause di quest’ultima a partire dalla morte di Silla. (L’opera di Sisunna si conclude con la morte di Silla).
La genesi è contenuta nel capitolo 95 del Bellum Iughurtinum quando Sallustio si lamenta dicendo che non ha più tempo di ritornare su Silla. Anche perché rimprovera a Sisunna di aver parlato di Silla in maniera parziale.
E’ spinto dall’esigenza di dire cose sulla dominatio di Silla in modo più obiettivo senza farsi influenzare dal pensiero filo aristocratico. Ma comunque anche se l’opera è analista non vi si presenta un Sallustio diverso poiché vi sono sempre gli stessi caratteri:
1)prevalere delle grandi personalità
2)polemica antiaristocratica
3)propensione per la riflessione morale
Infine fra le altre opere vi è da citare l’Empedoclea.
Domande da interrogazione
- Qual è l'orientamento politico di Sallustio nelle Epistulae ad Cesarem?
- Qual è l'obiettivo principale del De Coniuratione Catilinae di Sallustio?
- Come viene presentato Catilina nell'opera di Sallustio?
- Quali sono le differenze tra il Bellum Iughurtinum e il De Coniuratione Catilinae?
- Qual è l'approccio di Sallustio nelle Historiae rispetto alle sue opere precedenti?
Sallustio ha un orientamento politico democratico e filocesariano, ma non nel senso moderno di democrazia. Egli aspira a una democrazia moderata e sostiene riforme sociali e la moralizzazione della vita pubblica.
L'obiettivo principale è smascherare la corruzione dei giovani Romani, scagionare Cesare dall'accusa di essere l'ispiratore della congiura e mettere in ombra il ruolo di Cicerone.
Catilina è descritto come una figura eccezionale e poetica, che nonostante la sua nobiltà e corruzione, cerca di difendere la plebe. Sallustio mostra un atteggiamento ambiguo nei suoi confronti, alternando condanna e simpatia.
Il Bellum Iughurtinum è considerato un'opera più matura, con un impianto narrativo più saldo e una concezione della storia più profonda. A differenza del De Coniuratione Catilinae, non presenta squilibri strutturali e i ritratti dei personaggi si fondono armonicamente con il resto dell'opera.
Nelle Historiae, Sallustio adotta un approccio analistico, cercando di affrontare tutte le cause della crisi della Repubblica. Mantiene comunque la sua polemica antiaristocratica e la propensione per la riflessione morale, senza farsi influenzare dal pensiero filo aristocratico.


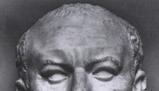






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo