Concetti Chiave
- Kierkegaard's life was marked by significant personal events, including a controversial newspaper attack and a broken engagement, which influenced his philosophical outlook.
- His philosophical work emphasizes the concept of existence as a realm of possibilities, highlighting the anxiety and paralysis that arise from the inability to commit to a single choice.
- Kierkegaard critiqued Hegel's idealism, advocating for the importance of individual existence and subjective truth over universal reason.
- He delineated three stages of life—esthetic, ethical, and religious—each representing different approaches to living, with the religious stage offering a leap of faith beyond ethical living.
- Key themes in Kierkegaard's thought include the interplay between anxiety and despair and their connection to human freedom, with faith positioned as the resolution to existential despair.
Infanzia e formazione
Nacque a Copenaghen in Danimarca, educato da un padre anziano si iscrisse alla facoltà di teologia. Dopo dieci anni di università si laureò, ma non intraprese la carriera di pastore alla quale la laurea lo abilitava.
Episodi significativi della vita
Nella sua vita ci furono degli episodi strani (apparentemente insignificanti che però colpirono duramente Kierkegaard), che lui stesso narra o cita nel Diario, come l'attacco da parte di un giornale del tempo contro la sua persona del quale si dolse come se fosse una persecuzione, la polemica contro l'ambiente protestante del suo paese, considerato troppo chiuso e conformista, ma soprattutto l'inspiegabile rottura del suo fidanzamento ufficiale che ormai durava da un anno (cosa che era considerata molto grave).
La scheggia e il distacco
Lui stesso non da delle spiegazioni per quanto riguarda questi avvenimenti, però parla di una "scheggia nelle carni" che egli era destinato a portare, vista come una minaccia oscura e sicuramente come qualcosa di paralizzante. Ed è proprio questa scheggia probabilmente che lo portò ad interrompere il fidanzamento e a non intraprendere la carriera di pastore, né nessun'altra. Viveva in un rapporto di distaccato con la realtà circostante, distacco che è sottolineato, ad esempio, dal fatto che pubblicò i suoi libri sotto pseudonimi diversi, forse perché non voleva identificarsi in una persona sola (credeva nell'impossibilità di essere una persona sola). 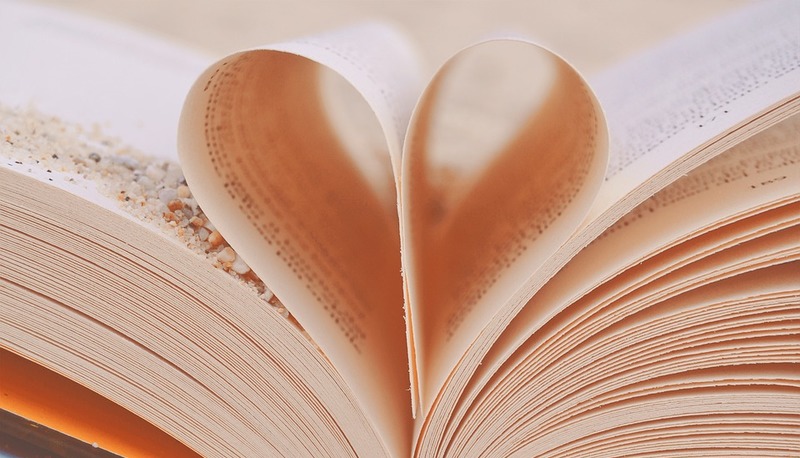
Opere principali
Gli scritti più importanti:
1. Aut-Aut, di cui fa parte il Diario di un seduttore
2. Timore e Tremore
3. Il concetto dell'angoscia
4. La malattia mortale
1.
Concetto di possibilità
Il primo concetto in Kierkegaard è l'esistenza dell'uomo che si identifica con la categoria della possibilità. Di essa ne identifica il carattere negativo, perché la possibilità è al tempo stesso possibilità di e possibilità di non, questo implica una scelta e probabilmente la non realizzazione di ciò che è possibile, quindi la minaccia del nulla. Egli vive continuamente sotto questa minaccia, infatti tutti gli avvenimenti della sua vita gli appaiono carichi di alternative terribili, che finiscono con il paralizzarlo. Egli parla di uno zero che è l'indecisione permanente, l'equilibrio instabile tra le opposte alternative. E forse è proprio questa la scheggia della quale parla nel suo Diario, cioè l'impossibilità di scegliere tra le opposte alternative, di riconoscersi e attuarsi in un'unica possibilità.
2.
Identificazione delle possibilità
Una seconda caratteristica è quella di cercare in continuazione di identificare le possibilità fondamentali, che sono le scelte che un uomo è spinto a fare per decidere della propria esistenza. Ed è proprio per non scegliere tra le innumerevoli possibilità che egli utilizzò pseudonimi differenti, per creare un distacco tra se stesso e le forme di vita tra le quali avrebbe dovuto scegliere.
3.
Il tema della fede
La terza caratteristica importantissima nel suo pensiero è il tema della fede. Soltanto il cristianesimo è visto come un'ancora di salvezza, in quanto è in grado di sottrarre l'uomo dall'angoscia e dalla disperazione.
Singolarità e universalità
La singolarità come categoria propria dell'esistenza umana: I temi fondamentali della sua ricerca sono la difesa della singolarità dell'uomo, l'esistenza, la libertà come possibilità e lo scontro contro l'universalità della ragione, tutti temi che costituiscono una radicale contrapposizione all'idealismo romantico, rappresentato dal pensiero di Hegel che allora era dominante.
Critica all'idealismo
Kierkegaard fu molto polemico nei confronti dell'idealismo di Hegel che dissolveva il singolo, cioè l'uomo concreto, nella ragione universale. Egli riteneva che "la verità è una verità solo quando è una verità per me", la verità non è l'oggetto della ragione, ma è il processo tramite il quale l'uomo la fa sua; alla riflessione oggettiva di Hegel, si contrappone la riflessione soggettiva ed esistenziale di Kierkegaard. Hegel aveva fatto dell'uomo un genere animale, perché negli animali il genere è superiore al singolo, mentre per Kierkegaard è l'opposto: l'uomo appartiene al genere umano proprio perché nel genere umano il singolo è superiore al genere, secondo Kierkegaard questo era l'insegnamento fondamentale del cristianesimo.
Kierkegaard considera suo compito inserire la persona singola e tutte le sue esigenze nella ricerca filosofica e combatté tutta la vita contro il panteismo idealistico, che identifica uomo e Dio, affermando invece l'esistenza di un abisso incolmabile tra i due.
Stadi dell'esistenza
Gli stadi dell'esistenza: il primo libro di Kierkegaard è Aut-Aut, una raccolta di scritti pubblicati sotto diversi pseudonimi che presentano i due differenti stadi dell'esistenza tra i quali l'uomo può scegliere. Già il titolo dell'opera sottolinea la possibilità di fare una scelta. L'uomo può scegliere fra le due differenti vite, quella estetica e quella etica, che hanno vita a sé, che sono divise da un abisso e che si escludono a vicenda.
a) VITA ESTETICA
Vita estetica
La vita estetica è propria del seduttore, colui che vive l'attimo, che vive poeticamente e che si abbandona ai piaceri, anche se non si lascia andare alla ricerca sfrenata del godimento, ma si basa sulla limitazione e sull'intensità dell'appagamento. Chi vive la vita estetica non si accontenta di tutto ciò che può essere banale o insignificante, non accetta la ripetizione che implica monotonia, ma cerca sempre il nuovo. Kierkegaard parla della vita estetica nel Diario del seduttore, il cui protagonista è Giovanni. La vita estetica però ad un certo punto sfocia nella noia, che è il lasciarsi andare agli eventi, e a sua volta la noia diventa disperazione, che è la scelta di sottrarsi a se stesso. La noia è l'ansia di colui che cerca sempre una vita diversa che si presenta come un'altra alternativa possibile. Per raggiungere l'altra alternativa bisogna attaccarsi alla disperazione, scegliere cioè di dare tutto se stesso per andare oltre la semplice esteticità e vivere la vita etica.
b) VITA ETICA
Vita etica
La vita etica al contrario di quella estetica implica continuità. Mentre nella vita estetica l'uomo è immediatamente ciò che è, nella vita etica l'uomo è ciò che diviene. Cioè l'uomo si adegua ad una forma, si adegua all'universale e rinuncia ad essere l'eccezione. La vita etica è propria del marito, il matrimonio infatti è definito da Kierkegaard il culmine della vita etica. Inoltre la persona etica è dedita al lavoro, che è anche la sua vocazione e quindi si applica ad essa con piacere e il lavoro è anche il mezzo tramite il quale l'uomo si mette in relazione con le altre persone.
La scelta che l'uomo etico deve fare corrisponde "alla scelta della scelta" di ciò che egli vuole fare di se stesso e della propria vita. Ma alla fine si accorge che l'impegno che mette nella famiglia, nel lavoro e nei confronti degli amici lo spingono ad allontanarsi sempre di più dalla sua persona, ed è per questo che si pente e nel riconoscere la propria colpevolezza si apre a Dio e tende a raggiungere la vita religiosa.
c) VITA RELIGIOSA
Vita religiosa
Tra vita etica e vita religiosa c'è un abisso ancora più profondo di quello che separa vita etica da vita estetica. Kierkegaard parla della vita religiosa in Timore e Tremore, il cui protagonista è Abramo.
Abramo vissuto per 70 anni nel rispetto della legge morale, riceve da Dio l'ordine di uccidere il figlio Isacco. Questo comando non è legato alla legge morale per la quale Abramo è sempre vissuto, ma ad un puro comando divino. Le due possibilità non possono essere conciliate, visto che il principio religioso sospende la legge morale. Ma allora c'è una regola precisa per scegliere quale legge seguire? L'uomo che ha fede, come Abramo, sceglierà il principio divino, anche se questo va contro la legge morale e gli stessi affetti umani. Ma la fede in realtà è basata sul rapporto tra uomo e Dio, un rapporto di solitudine, visto che il solo il singolo uomo si relaziona con Dio, non è in compagnia, e nel loro rapporto non ci sono regole. E' da qui che deriva il carattere incerto e rischioso della religione. Come fa l'uomo a sapere che è lui l'eletto al quale Dio ha affidato un compito così eccezionale da giustificare la sospensione della legge morale?! Nella religione l'incertezza è la sola certezza possibile. Kierkegaard parla della religione come un paradosso, uno scandalo e Cristo è l'esempio più significativo delle contraddizioni della fede, visto che soffre e muore come un uomo, mentre parla e agisce come un Dio ed è colui che si deve riconoscere come un Dio, mentre soffre e muore come un semplice uomo.
L'uomo deve quindi scegliere se credere o non credere. Da un lato sta a lui la scelta, ma allo stesso tempo ogni sua iniziativa è esclusa visto che tutto deriva da Dio, anche la fede.
Secondo Kierkegaard i fattori fondamentali del cristianesimo sono proprio paradosso, scandalo, contraddizione, necessità e allo stesso tempo impossibilità di decidere, dubbio e angoscia. Ma il cristianesimo di cui parla Kierkegaard è assai lontano da quello delle religioni ufficiali, soprattutto da quello del suo paese contro il quale egli fu molto spesso polemico. Inoltre sappiamo per certo che egli conobbe il Nuovo Testamento, che non era conosciuto in Danimarca, e leggendolo rimase molto scosso.
L'angoscia
L'angoscia: Kierkegaard si è dapprima soffermato a delineare i diversi stadi della vita, ora approfondisce il tema centrale del suo pensiero, ossia il concetto di esistenza come possibilità che viene trattato nel Concetto dell'angoscia e La malattia mortale. Il primo chiarisce la situazione del rapporto dell'uomo con il mondo, mentre nel secondo parla dell'uomo in relazione con se stesso. In questi scritti egli tratta il tema del dubbio, della possibilità, spiegando che le infinite possibilità tra le quali scegliere portano l'uomo all'angoscia. Egli infatti parla dell' "angosciante possibilità di potere", che significa che l'uomo è libero di decidere fra le infinite possibilità, ma la scelta di una esclude tutte le altre e così porta all'incertezza continua e all'angoscia. Essa, a differenza del timore o di altri stati analoghi, non si riferisce a nulla di preciso ed è interiore, mentre ad esempio la paura della morte o di una malattia si riferiscono a qualcosa di esteriore. Inoltre Kierkegaard connette strettamente l'angoscia, la possibilità e l'avvenire. "Per la libertà, il possibile è l'avvenire, per il tempo l'avvenire è il possibile" e entrambi corrispondo all'angoscia. Ad esempio il passato crea angoscia perché si può ripresentare in futuro, oppure una colpa passata crea angoscia se non è veramente passata. L'angoscia è legata a ciò che non è, ma può essere. Un'altra caratteristica dell'angoscia è che è tipica dell'uomo, se questo fosse angelo o bestia non la conoscerebbe.
Disperazione e fede
Disperazione e fede: l'angoscia è generata dalle possibilità che si presentano all'uomo nel suo vivere in rapporto con il mondo, mentre la disperazione è generata dalle possibilità che l'uomo ha nel rapporto con se stesso. L'angoscia e disperazione sono strettamente legate, ma non identiche.
La disperazione è strettamente legata alla natura dell'io. L'io può volere, come può non volere, essere se stesso. Se vuole, poiché è finito, quindi insufficiente a se stesso, non giungerà mai all'equilibrio e al riposo. Se non vuole e cerca di rompere il rapporto con se stesso, anche qui giunge ad un'impossibilità fondamentale. La disperazione è definita da Kierkegaard "la malattia mortale", che è anche il titolo della sua opera, non perché conduca alla morte, ma perché corrisponde al vivere la morte, perché è il tentativo impossibile di negare la possibilità.
La disperazione è il peccato e l'opposto del peccato per Kierkegaard è la fede, non la virtù. La fede è vista come l'antidoto per eliminare la disperazione. L'uomo attraverso la fede pur riconoscendo se stesso e volendo essere se stesso, non si illude della propria autosufficienza, ma al contrario capisce la sua dipendenza da Dio. La fede è speranza e fiducia in Dio, ma come già affermato prima nella vita religiosa, essa porta l'uomo al di là della ragione e della comprensione quindi è anche assurdità, scandalo e paradosso. I paradossi principali della religione sono ad esempio la trascendenza di Dio, oppure è impensabile che un Dio si faccia carne e poi muoia per noi. Eppure la fede crede a questi paradossi. Secondo Kierkegaard la religione consiste nel paradossale capovolgimento dell'esistenza, visto che l'instabilità dell'esistenza si basa sul possibile, mentre la fede si basa sulla stabilità del principio di ogni possibilità, ossia a Dio-cui tutto è possibile.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli episodi significativi nella vita di Kierkegaard che hanno influenzato il suo pensiero?
- Qual è il concetto centrale del pensiero di Kierkegaard riguardo all'esistenza umana?
- Come Kierkegaard distingue tra vita estetica, etica e religiosa?
- In che modo Kierkegaard vede la fede come soluzione alla disperazione?
- Qual è la critica di Kierkegaard all'idealismo di Hegel?
Kierkegaard fu colpito da episodi come l'attacco di un giornale, la polemica contro l'ambiente protestante e la rottura del fidanzamento, che egli descrive come una "scheggia nelle carni", simbolo di una minaccia paralizzante.
Kierkegaard identifica l'esistenza umana con la categoria della possibilità, caratterizzata dalla scelta tra alternative opposte, che porta alla minaccia del nulla e all'indecisione permanente.
La vita estetica è caratterizzata dal piacere e dalla ricerca del nuovo, la vita etica dalla continuità e dall'impegno, mentre la vita religiosa implica un rapporto solitario e paradossale con Dio, al di là della legge morale.
La fede è vista come l'antidoto alla disperazione, poiché permette all'uomo di riconoscere la propria dipendenza da Dio, superando l'illusione dell'autosufficienza e accettando i paradossi della religione.
Kierkegaard critica l'idealismo di Hegel per dissolvere il singolo nella ragione universale, sostenendo invece che la verità è soggettiva e che l'uomo concreto è superiore al genere, in linea con l'insegnamento cristiano.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo