Concetti Chiave
- Il pensiero di Sant'Agostino si basa sulla relazione tra l'uomo e Dio, con la verità che risiede nell'anima e viene illuminata da Dio stesso.
- Agostino risolve il problema del male vedendolo come mancanza di bene, attribuendo la responsabilità del male morale alla libera volontà umana.
- La dottrina dell'illuminazione di Agostino lega strettamente fede e ragione, sostenendo che la verità si rivela solo se la mente è illuminata da Dio.
- La concezione del tempo di Agostino lo vede come una dimensione psicologica, non un'entità metafisica, e lo distingue dall'eternità di Dio.
- Agostino introduce una filosofia della storia lineare, incentrata sulla redenzione umana e influenzata dalla Provvidenza divina, diversamente dalla visione ciclica greca.
In questo appunto di filosofia viene descritto il pensiero filosofico di Sant'Agostino. Inoltre per filosofia cristiana intendiamo l’insieme delle dottrine contenuta in quella vastissima produzione di opere che va dal II secolo dopo Cristo alla fine del VII secolo. Scopo di questa filosofia è interpretare il messaggio cristiano del Vangelo alla luce dei concetti filosofici greci. In questo senso c’è chi ha parlato di “ellenizzazione del cristianesimo”.
Indice
- Espansione del Cristianesimo
- Ellenizzazione del Cristianesimo
- Vita e conversione di Sant'Agostino
- Le Confessioni e la ricerca della verità
- Fede e ragione secondo Sant'Agostino
- Dio e la creazione secondo Sant'Agostino
- Il tempo e la sua natura
- Il problema del male
- Libero arbitrio e grazia divina
- Filosofia della storia cristiana
Espansione del Cristianesimo
All’origine la comunità cristiana era una ristretta comunità di fedeli formatasi all’interno della cultura ebraica.  Rispetto alla religione ebraica tradizionale si distingueva per la fede in Gesù Cristo come Messia, o Salvatore, fede basata soprattutto nella resurrezione dalla morte di Gesù Cristo dopo la crocifissione, e quindi nella credenza che l’avvento annunciato del Regno di Dio fosse un evento spirituale e non primariamente politico.
Rispetto alla religione ebraica tradizionale si distingueva per la fede in Gesù Cristo come Messia, o Salvatore, fede basata soprattutto nella resurrezione dalla morte di Gesù Cristo dopo la crocifissione, e quindi nella credenza che l’avvento annunciato del Regno di Dio fosse un evento spirituale e non primariamente politico.
Nel corso del primo e del secondo secolo però il Cristianesimo incominciò a espandersi rispetto ai ristretti confini della cultura ebraica, arrivando in tutte le regioni del Mediterraneo, ossia in tutto l’Impero Romano. Tra i maggiori promotori di questa espansione si distinse sicuramente Paolo di Tarso (San Paolo), che attraverso i suoi viaggi e le sue lettere contribuì a trasformare il messaggio cristiano in una dottrina complessa, che si confrontava con il pensiero colto della comunità intellettuale greca. Paolo tendeva a sottolineare l’assoluta novità del Cristianesimo rispetto alla cultura greca, che egli anzi definisce polemicamente come un vero e proprio scandalo se confrontato con l’approccio razionale alla verità. La sapientia christiana non ha nulla a che fare con la filosofia, e la fede in Dio è in aperta contraddizione con i principi della filosofia greca.
Con Paolo il messaggio cristiano si trasforma però in una dottrina. Elementi essenziali di questa originaria dottrina cristiana sono la fede in un Dio onnipotente e provvidente, un Dio pensato come fonte di amore e di salvezza, più che come Legge; l’idea che il mondo sia opera di Dio; il mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo, considerato figlio di Dio; la credenza nella risurrezione di Cristo e la fede nella risurrezione dei morti; la speranza nella salvezza attraverso il Cristo, unita all’idea che Dio ha un progetto di salvezza per tutti gli uomini; l'idea che tutti gli uomini sono figli di Dio da cui deriva un'etica di uguaglianza, giustizia, fratellanza; l'idea del peccato originale e la visione dell'uomo naturale come peccatore, che solo la fede in Dio può salvare. Paolo cerca quindi di rispondere alle accuse dei dotti greci, mantenendo una posizione di distanza dall’originaria cultura di appartenenza.
Ellenizzazione del Cristianesimo
Nel momento in cui si espande in tutta l’area del Mediterraneo, il Cristianesimo si confronta in modo sempre più complesso con la cultura ellenistica dominante nell’Impero Romano e progressivamente la assimila. Con l’opera paziente dei Padri della Chiesa il Cristianesimo, presentato inizialmente come messaggio irriducibile alla sapientia greca, viene ellenizzato. L’ellenizzazione del cristianesimo consiste essenzialmente nell’interpretare il messaggio di salvezza cristiano alla luce delle categorie filosofie greche: nasce così la vera e propria filosofia cristiana. I concetti di Essere, divenire, logos, causa, principio, forma, materia, corpo, anima, mente, idee, essenza, accidenti, atto, potenza, eterno, temporale, diventano i concetti chiave per interpretare il cristianesimo. Nascono così i concetti di Dio come Lógos, ragione universale, e mente, Dio come Essere, Essere primo, e creatore, causa di tutto ciò che esiste, il problema dell’unità e della trinità di Dio; il problema della natura umana e divina del Cristo; il concetto del mondo come opera di Dio, e l’idea del mondo come essere derivato, o “creato”; l’idea dell’uomo essere spirituale, intelligente e libero, immagine di Dio; l’idea dell’uomo come immagine di Dio e essere peccatore, che ha peccato liberamente; il concetto di incarnazione di Dio in Cristo; l’idea della la storia umana come storia della redenzione dell’uomo ad opera di Dio provvidenza.
Vita e conversione di Sant'Agostino
Nato nel 354 a Tagaste, nell'Africa romana, da padre pagano e madre cristiana, Sant'Agostino ebbe una formazione classica. Attraverso la lettura dell'Ortensio di Cicerone, scoprì l'interesse per la filosofia.
Da giovane aderì al manicheismo, una dottrina gnostica che affermava l'esistenza di due principi opposti, uno buono, l'altro cattivo, che spiegano la realtà nei suoi aspetti di lotta e di contrasto. Tuttavia questa concezione non si conciliava affatto con l'idea di un Dio onnipotente che egli aveva ereditato dalla dottrina cristiana e dalla filosofia classica.
Impregnato di cultura classica, insegnò retorica a Cartagine sino all'età di 29 anni. Poi si trasferì in Italia, dove avvenne un processo di conversione al Cristianesimo, che culminò negli anni 386-387, dove si convinse soprattutto per influenza del vescovo di Milano Ambrogio, da cui ricevette il battesimo il 25 aprile 387.
Da quel momento Sant'Agostino iniziò a scrivere opere di filosofia religiosa, di dottrina cristiana, di educazione e iniziò un'energica attività ecclesiastica che lo portò a diventare vescovo di Ippona, in Africa, carica che esercitò dal sino alla morte, sopravvenuta nel 430.
Le Confessioni e la ricerca della verità
Tra le sue opere le più famose sono certamente le Confessioni (401), un'opera autobiografica, dove, narrando in prima persona, racconta l'itinerario spirituale che lo ha condotto alla conversione al Cristianesimo. Sant'Agostino si rivolge direttamente a Dio, a cui dà del tu. L'opera è un'opera filosofica, perché, il racconto viene intersecato continuamente dall'analisi dei problemi filosofici che hanno travagliato la sua vita. In quest'opera troviamo l'analisi del problema della verità, con la tesi che la verità è illuminazione, la dottrina della creazione, l'analisi del tempo, l'analisi del problema del male, l'analisi dell'anima umana e del processo di conoscenza, l'analisi della memoria.
Il punto di partenza e il centro della riflessione di Sant'Agostino è la relazione tra uomo e Dio. La conversione al Cristianesimo, avvenuta in età adulta, porta Agostino a riflettere continuamente sul modo di pensare e di agire dell'uomo cristiano al confronto con il modo di pensare e di agire dell'uomo pagano.
Sant'Agostino considera negativamente il suo passato pagano, i suoi interessi, i suoi amori, la sua vita, che dopo la conversione, egli giudica dissoluta. Da questo atteggiamento deriva anche un'opera di disprezzo della cultura "classica" nella quale si è formato da giovane e che costituisce, anche da cristiano, una base di partenza ineliminabile.
Sant'Agostino indagando se stesso nelle Confessioni, si scopre come essere umano assolutamente volubile, instabile, temprale, privo perciò dei requisiti di stabilità che competono alla Verità. La Verità è stabile, identica a se stessa immutabile, eterna, proprio come aveva sostenuto Platone, sulle orme di Parmenide. La verità quindi non deriva dall'uomo. Eppure l'uomo può trovare la verità solo attraverso la sua mente, cioè nell'anima. Veritas habitat in interiore homine: la verità abita all'interno dell'uomo, ma è Dio che illumina la mente umana. L'uomo per scoprire la verità non deve indagare il mondo esterno attraverso i sensi, che rivelano solo le apparenze delle cose; deve invece indagare dentro di sé, nella sua anima. L'uomo vede con l'intelligenza la verità dentro di sé, ma questa verità non viene da sé, non è generata dall'uomo, ma solo dalla stessa verità, cioè dall'Essere vero. Questo Essere Vero, identico a se stesso, che vive fuori dal tempo, eterno, è solo Dio. Solo Dio è la Verità e la comunica all'uomo attraverso l'Illuminazione. L'illuminazione è l'intuizione della verità che avviene per opera della Verità stessa che si rivela alla mente umana. L'uomo perciò non può autonomamente, con la sola ragione, cercare la Verità, se già la Verità non gli si rivela in qualche modo. Non può trovare la Verità se la Verità non illumina la sua mente in modo che questa la intuisca pienamente. L'uomo non può salvarsi da solo se Dio non lo salva. Per ricercare la verità e la salvezza, occorre quindi la fede. Fede e ragione non possono essere distinti e separati, ma sono strettamente connessi reciprocamente. La fede non può sussistere senza l'intelligenza di ciò a cui si crede, e l'intelligenza necessita della fede in Dio come Verità eterna. La fede sarebbe cieca e insensata senza la ragione, e la ragione si perderebbe senza la fede: Credo ut intelligam et intelligo ut credam; credo per comprendere e comprendo per credere.
Fede e ragione secondo Sant'Agostino
Contro coloro che avevano sostenuto la piena autonomia della ragione, come i filosofi greci, Agostino nota che la ragione stessa, abbandonata a se stessa porta allo scetticismo, cioè alla sfiducia nella proprie autonome capacità: contro coloro che avevano posto la base della religione in una fede anche contraria alla ragione, (Credo quia absurdum, cioè Credo perché assurdo, come aveva affermato Tertulliano), Sant'Agostino sostiene che la fede non può essere priva di intelligenza e di intima razionalità. Dio, la Verità, non è irrazionale pertanto per comprenderne il messaggio e l'opera dobbiamo servirci di tutte le nostre capacità intellettive e razionali. La Verità stessa presuppone un atteggiamento di ricerca della Verità che è già un atto di fede, perché è apertura alla Verità eterna che è Dio stesso. La vera filosofia corrisponde alla vera religione.
Questa posizione implica un'altra tesi: la sapientia christiana non si deve alimentare di qualsiasi nozione scientifica, ma deve concentrarsi sul messaggio di Dio e sulla ricerca del bene morale, che rende l'uomo degno di salvezza. Perciò la ricerca cristiana si concentra su Dio e sull'anima.
Dio e la creazione secondo Sant'Agostino
Dio è concepito quindi come l'Essere primo, il vero Essere, l'Essere che è e non può non essere, l'Essere Assoluto, e perciò Infinito, perfetto, onnipotente. Egli è il creatore unico e onnipotente di tutto ciò che è: senza Dio, l'essere del mondo sarebbe nulla, perché è venuto all'essere per la creazione di Dio. L'essere del mondo è un essere creaturale, è "prope nihil", quasi un nulla.
La natura, in quanto mondo creato, non è più come per i filosofi greci antichi, l'Essere che è e non può non essere, ingenerato, indistruttibile, eterno. Queste caratteristiche dell'Essere vengono da Sant'Agostino attribuite a Dio. Mentre la natura è un essere derivato, generato, temporale. Il creato ha un suo ordine, che non è altro che l'ordine del Lógos divino, che concepisce le Idee su cui il mondo creato è modellato. Le idee platoniche sono quindi interpretate da Sant'Agostino come idee dell'Intelligenza divina, con cui l'Intelligenza divina crea l'universo. Nell'illuminazione l'uomo scopre la verità conoscendo le idee, cioè le verità eterne intelligibili, che si identificano con i pensieri di Dio che hanno dato l'ordine al creato. Dalle idee divine derivano le ragioni seminali, i principi da cui ogni essere assume la sua propria forma d'essere e che conferisce ad ogni essere una sua natura e sua autonomia dal Creatore: autonomia che però non è mai indipendenza, perché nulla si è creato da solo e nulla sarebbe senza la creazione di Dio. Questa interpretazione del mondo come creatum, essere derivato si unisce ad un disinteresse di Agostino per le scienze della natura, considerate scienze di causae secundae, subordinate perciò alla indagine sull'Essere primo, Dio. L'indagine sul mondo si traduce in Agostino in un discorso essenzialmente teologico, volto a indagare le relazioni tra Dio e il mondo.
Il tempo e la sua natura
In tal senso Sant'Agostino esamina il problema del tempo. Il mondo, come essere creato, ha avuto un inizio, e così avrà anche una fine. Il mondo è sottoposto al movimento e quindi al tempo, che, come aveva detto Aristotele, è la misura del movimento. Il tempo è quindi la dimensione del creato, in contrapposizione all'eternità di Dio e delle sue idee, oggetto del suo intelletto. Ma che cosa è il tempo? Con un'analisi raffinata, simile a quella dei filosofi greci, Agostino dimostra che il tempo non è una realtà metafisica: il tempo non è essere. Il passato non è più, quindi non "è", il presente ha un essere instabile in quanto fugge continuamente (nel momento in cui intuisco il presente, esso è già svanito, è diventato passato) il futuro ancora non è: Come è possibile dunque pensare al tempo, parlare del tempo, se il tempo non è un vero essere, ma è un continuo sfuggire? E' l'anima umana che è in grado di cogliere il tempo e di misurarlo. L'anima è in grado di misurare il tempo distendendosi. In quanto memoria, l'anima ricorda il passato, in quanto intuizione, coglie il presente, in quanto attesa e speranza, si rappresenta un futuro che ancora non c'è. Attraverso questa distensione dell'anima (extensio animae) il tempo ha una sua realtà. La realtà del tempo è essenzialmente una dimensione psicologica.
Questa analisi del tempo come non essere reale e dimensione psicologica ha avuto grande fortuna ed è andata a sovrapporsi e talora a sostituirsi con la concezione cosmologica e fisica del tempo come misura del movimento e del divenire, formulata da Platone e Aristotele. In particolare la concezione agostiniana ebbe una fortuna enorme nelle correnti spiritualistiche, anche moderne.
Il problema del male
Nell'esaminare il rapporto tra Dio e il mondo, Sant'Agostino esamina un altro problema dibattuto dalla filosofia cristiana: il problema del male. Se Dio è il vero essere, perfezione assoluta, onnipotenza, e se tutto è stato creato da Dio, come è possibile il male? Si Deus est, unde malum? (Se Dio esiste, da dove deriva il male?).
Sant'Agostino affronta il problema tenendo presente la soluzione neoplatonica del problema del male: il male come mancanza di bene e di essere. Come i Neoplatonici, Agostino parte dalla premessa che l'essere e il bene coincidono. Tutto ciò che è, è buono, in quanto creato da Dio, che è infinitamente buono e onnipotente. Ma ogni essere creato, essendo creato, è un bene relativo e perciò limitato, finito. Perciò ogni essere ha un limite, limite che noi consideriamo erroneamente come un difetto intrinseco, ma che tale non deve essere considerato. Nel creato esiste una gerarchia di esseri, che corrisponde ad una gerarchia di beni, che non devono essere considerati un male, ma solo beni relativi. Dal punto di vista metafisico, perciò il male non esiste, ciò che noi chiamiamo male non è altro che la mancanza di bene relativa ad ogni essere creato.
Dal punto di vista fisico, il male corrisponde con la sofferenza e il dolore: questi possono essere considerati una male solo dal punto di vista sensibile, ma, considerati nella prospettiva universale, il dolore non è altro che la conseguenza del peccato originale: quando l'uomo si è allontanato volontariamente dal bene stabilito ab aeterno da Dio, Dio lo ha punito rendendolo passibile di dolore e morte. Dunque nemmeno il male fisico, cioè il dolore, la malattia e la morte non sono un male, ma la giusta pena per il peccato originale, che è stato compiuto liberamente dall'uomo, che noi chiamiamo anche male morale. L'unico vero male è il male morale, che consiste nel peccato, cioè nella disobbedienza alla volontà di Dio. Questo male deriva unicamente dalla libera volontà dell'uomo. L'uomo è stato creato da Dio buono, ma anche libero di scegliere. Ma in che cosa consiste propriamente il male morale? Il male morale dipende dalla cattiva volontà dell'uomo, cioè dalla libera adesione della volontà umana ad un bene terreno (relativo), anziché al Bene eterno (assoluto). Dunque il male morale consiste nel preferire i beni terreni, che sono in sé beni, ma inferiori, ai beni eterni, cioè a Dio. La corruzione della volontà è quindi una defectio voluntatis, un difetto della volontà umana, che non rimane aderente al Bene supremo e massimo, Dio, e si volge liberamente alla ricerca di beni inferiori, considerandoli come beni assoluti. In ciò consiste propriamente il male morale, in un difetto della volontà. Il male non ha una causa positiva, ma semplicemente negativa: sta nell'assenza di una volontà stabile dell'uomo, che non aderisce perfettamente a Dio, ma si volge ai beni relativi. Questa mancanza della volontà è il risultato di una scelta libera dell'uomo, non è voluta da Dio, ma è solo la conseguenza del dono della libertà propria di un essere intelligente. Dio ha dato all'uomo l'intelligenza e la volontà per scegliere come agire nel mondo, e l'uomo può orientare la sua volontà volgendo ai beni eterni o ai beni terreni.
Sant'Agostino giustifica quindi Dio dall'accusa di essere causa del male: il male metafisico non esiste, consiste solo nella perfezione relativa degli esseri creati, il male fisico non è creato da Dio ma è la conseguenza del peccato originale, e l'unico vero male è il male morale, che dipende unicamente dalla libera volontà dell'uomo, che ha la possibilità di non aderire perfettamente a Dio.
Libero arbitrio e grazia divina
L'uomo è concepito platonicamente come anima: l'anima, la mente è il vero essere dell'uomo, capace di cogliere, come si è detto, il vero essere, cioè le idee universali. L'anima è caratterizzata dalla memoria, dalla conoscenza e dalla volontà, rispecchiando così la Trinità divina.
La mente umana è concepita come "Io", cioè soggetto cosciente e autocosciente capace, non solo di conoscere la realtà esterna a sé, ma anche di comprendere se stessa e di dialogare con sé. Tanto che in tutta l'opera Le Confessioni, Sant'Agostino parla di sé in prima persona, dialogando con se stesso e con Dio, cui dà del tu.
In questo Agostino è uno degli scopritori più acuti di ogni tempo dell'individualità. In un certo senso egli esprime bene la solitudine dell'individuo nella crisi delle istituzioni sociali imperiali, ma da un altro punto di vista, anticipa la scoperta dell'individualità che sarà propria dell'Europa moderna, a partire da Descartes.
La scoperta dell'individualità autocosciente dell'anima rivela anche la libertà: l'uomo, in quanto essere intelligente, è in grado di agire in base al suo volere, scegliendo continuamente tra due o più possibilità. In ciò consiste la libertà come capacità autonoma di scelta, intesa cioè come "libero arbitrio" o arbitrium indifferentiae. Nell'opera De libero arbitrio Agostino sostiene la tesi della libertà dell'uomo, considerata un segno della sua superiorità rispetto agli altri esseri.
Tuttavia l'affermazione della libertà dell'uomo comporta una tesi, sviluppata in seno alla Chiesa dal monaco inglese Pelagio, che risulta per Sant'Agostino incompatibile con il messaggio di salvezza cristiano: la possibilità per l'uomo di salvarsi seguendo la propria ragione.
Pelagio aveva infatti sostenuto che ogni uomo, se usa correttamente la propria ragione, dotata fin dalla nascita delle idee universali con cui può ben orientarsi, può comportarsi bene e conseguire per proprio merito la salvezza. Questa tesi appare ad Agostino in contrasto con la verità cristiana, che annuncia la venuta di Cristo salvatore e la sua crocefissione. Se gli uomini fossero in grado di salvarsi da soli, come sostiene Pelagio, perché si sarebbe incarnato Cristo? Perché sarebbe stato crocefisso e sarebbe morto in croce e poi risorto?
Occorre quindi correggere la tesi pelagiana: è vero che l'uomo è stato creato perfettamente libero, ma avendo peccato con Adamo, ha perduto la sua primitiva libertà di agire bene, e la sua volontà si è corrotta. L'uomo quindi ha perduto la capacità di fare il bene autonomamente, e può agire bene solo se la grazia di Dio gli ridà questa possibilità originaria e oramai perduta. L'uomo quindi, per salvarsi, deve aderire al Bene, alla verità eterna, ma non è in grado di volere il Bene, e quindi di salvarsi da solo, se la Grazia di Dio non lo salva: è Dio che sceglie l'uomo e si rivela a lui, l'uomo illuminato dalla Grazia, non fa altro che rispondere alla chiamata di Dio. Dunque la Grazia di Dio è condizione primaria di salvezza, perché senza la Grazia la libertà umana non varrebbe a nulla. Se Dio non si rivelasse, l'uomo non potrebbe concepire la verità, e non potrebbe scegliere il bene. Come la Verità è Illuminazione, così la salvezza è opera della Grazia divina, che richiede l'azione di Dio e la libera adesione dell'uomo: ma la libera azione umana, se fosse completamente autonoma, non potrebbe mai di per sé conseguire la salvezza, se non ci fosse la Grazia.
Questa teoria venne ripresa e radicalizzata nel XVI secolo da Lutero, che, accentuando ulteriormente il ruolo attivo della Grazia e la passività dell'uomo, attribuì la causa della salvezza alla sola fede, intesa come risposta alla chiamata di Dio (dottrina della giustificazione per sola fede).
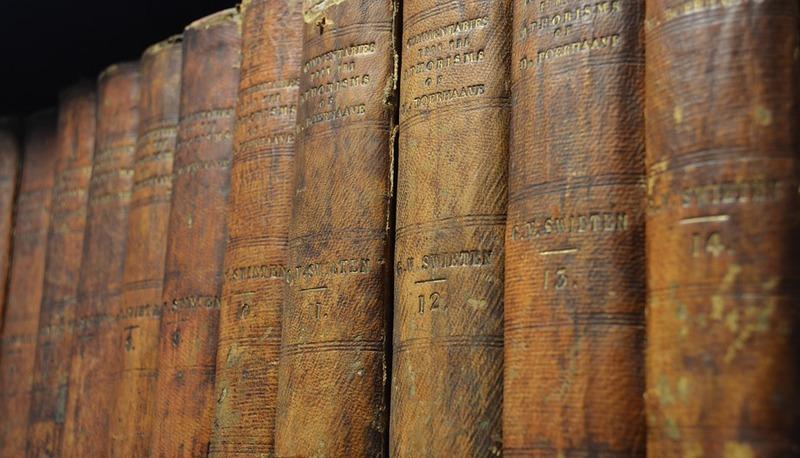
Filosofia della storia cristiana
Con il pensiero cristiano nasce in Occidente una vera e propria filosofia della storia. Il pensiero greco non aveva elaborato una vera filosofia della storia, non perché non avesse prodotto una riflessione sulla storia, quanto perché non riteneva che la storia umana avesse uno sviluppo organico, una direzione. La storia dell'uomo era considerata all'interno della vita della natura che aveva un carattere ciclico. Fatti ed eventi della storia, caratterizzati da determinate forme comuni, ricorrevano in diversi periodi, spesso in modo contingente, e quando si poteva individuare un'evoluzione di certe forme culturali, sociali, economiche o politiche, questo stesso sviluppo delle istituzioni portava ad una regressione al punto di partenza.
Nella prospettiva del Cristianesimo la storia viene invece pensata in senso lineare, come storia della redenzione umana, storia della salvezza, al cui centro sta l'incarnazione del Cristo. All'origine c'è il peccato originale, al centro c'è l'incarnazione di Cristo, al termine c'è la salvezza. La storia quindi acquista un termine finale, ha una direzione di sviluppo che permette una lettura unitaria di tutti i fatti in funzione del senso globale della storia.
Il più grande tentativo di dare alla storia un significato globale alla luce della salvezza cristiana viene intrapreso da Sant'Agostino nell'opera De Civitate Dei (la città di Dio). In quest'opera Sant'Agostino risponde alle accuse dei pagani che sostenevano che l'Impero romano era stato forte sin quando era stato pagano, mentre la decadenza di Roma era in relazione con l'affermarsi del Cristianesimo. Sant'Agostino replica all'accusa facendo una analisi spietata dell'Impero romano e delle sue origini, considerandolo sin dal principio opera della malvagità umana, dell'egoismo, della sete di potere. In questa prospettiva Agostino traccia una differenza tra due grandi forme ideali di istituzioni umane che caratterizzano la storia: la Città dell'uomo e la Città di Dio. La prima si fonda sulla volontà di dominio, l'egoismo, il desiderio dei beni terreni e porta alla violenza reciproca. Per Sant'Agostino quindi le istituzioni giuridiche e politiche non hanno un valore morale in sé, ma nascono dall'uso della forza e dalla volontà di offendere gli altri, di detenere il potere.
Ma la città dell'uomo non domina da sola nella storia. Ad essa si affianca la Città di Dio, che è rappresentata storicamente dalla Chiesa. La Città di Dio si fonda sull'amore di Dio, della Verità eterna, sul disprezzo dell'uomo e dei valori terreni, sulla charitas (amore del prossimo). Queste due città si intrecciano nella storia umana, talora si oppongono talora entrano in relazione. La città di Dio si insinua nella città dell'uomo: la Provvidenza divina conferisce alla storia umana un significato metastorico e escatologico: la storia umana è storia della salvezza. La storia umana quindi non è fatta soltanto dagli uomini: Dio interviene nella storia e per indirizzarla verso la salvezza che si compirà alla fine del tempo. La storia deve essere interpretata come escatologia.
Domande da interrogazione
- Qual è lo scopo della filosofia cristiana secondo il testo?
- Come Sant'Agostino concepisce la relazione tra fede e ragione?
- Qual è la concezione di Sant'Agostino riguardo al tempo?
- Come Sant'Agostino affronta il problema del male?
- Qual è la visione di Sant'Agostino sulla storia?
Lo scopo della filosofia cristiana è interpretare il messaggio cristiano del Vangelo alla luce dei concetti filosofici greci, un processo definito come "ellenizzazione del cristianesimo".
Sant'Agostino sostiene che fede e ragione sono strettamente connesse; la fede non può esistere senza l'intelligenza e la ragione necessita della fede in Dio come Verità eterna.
Sant'Agostino considera il tempo non come una realtà metafisica, ma come una dimensione psicologica, misurata dall'anima umana attraverso la memoria, l'intuizione e l'attesa.
Sant'Agostino vede il male come una mancanza di bene e di essere, non creato da Dio, ma derivante dalla libera volontà dell'uomo che si allontana dal Bene eterno.
Sant'Agostino concepisce la storia come lineare, una storia della redenzione umana con un significato globale alla luce della salvezza cristiana, culminante nell'opera "De Civitate Dei".






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo