Concetti Chiave
- Il darwinismo ha influenzato diverse concezioni biologiche e filosofiche, spesso distorcendo il pensiero originale di Darwin e applicandolo a campi estranei alla biologia.
- Il "darwinismo neurale" di Gerald Endelman descrive come la selezione naturale avvenga nel cervello durante lo sviluppo fetale e infantile.
- L'ultradarwinismo riduce la teoria dell'evoluzione a concetti base, sostenendo che lo scopo della vita è la riproduzione dei geni, considerati come unità fondamentali.
- Le critiche all'ultradarwinismo evidenziano che la selezione naturale non è l'unico fattore evolutivo e che esistono vincoli strutturali e ambientali che influenzano le variazioni genetiche.
- Gli organismi viventi non sono passivi nella selezione naturale, ma contribuiscono attivamente a modificare il proprio ambiente, concetto esplorato da Popper e anticipato da Teilhard de Chardin.
Concezioni ispirate al darwinismo
In questo appunto di filosofia vengono descritte in particolare modo quelle che sono le concezioni che si ispirano al darwinismo, tra cui vi è per esempio il cosiddetto darwinismo sociale. Inoltre si prende come esempio anche il pensiero del grande immunologo Gerald Endelman, il quale ha vinto anche il premio Nobel per la biologia. Tra le altre concezioni prese in esame vi è ad esempio anche il cosiddetto ultradarwinismo che è una di quelle teorie che si è ispirata alle teorie di Darwin. Si prende anche in considerazione se si possa obiettare contro l'ultradarwinismo.
Oltre al darwinismo sociale, le idee di Darwin sono state usate per fondare numerose concezioni biologiche e filosofiche che talvolta arricchiscono la teoria dell'evoluzione, ma spesso la stravolgono e falsano il pensiero di Darwin o lo applicano a campi di ricerca estranei alla biologia. Il filosofo della scienza Karl Popper (1902-1994) ha elaborato una interessante teoria evoluzionistica della conoscenza, che studieremo il prossimo anno.
Darwinismo neurale e critiche
L'immunologo Gerald Endelman, grande scienziato e premio Nobel per la biologia, ha sostenuto il "darwinismo neurale" (1987) riferendosi al fatto che, nello sviluppo del cervello nel feto e nel neonato, i neuroni si formano non nel luogo in cui si collocheranno nel cervello, ma nel tubo neurale; poiché si formano molti più neuroni di quelli, pur numerosissimi (pari a 10 alla 11) che formano il nostro cervello, durante lo spostamento vi è una selezione e i neuroni che non raggiungono la loro posizione non sopravvivono. 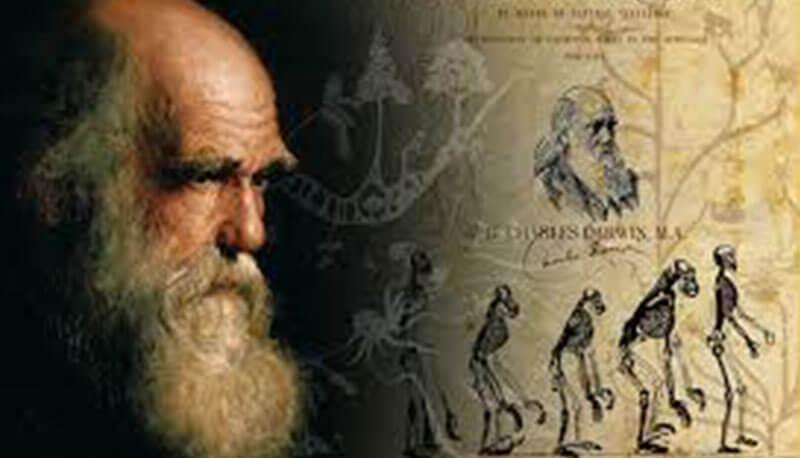
Si sono anche formate una psicologia darwinistica, una medicina darwinistica, una economia darwinistica, e così via... Teniamo però presente che per Darwin la selezione era un fatto puramente biologico.
Ultradarwinismo e suoi esponenti
Sotto questa voce possiamo raggruppare quelle teorie che si ispirano a Darwin, ma cercando di ridurre a pochi concetti base la concezione dell'evoluzione, spiegano la realtà in modo "ideologico", distorcendola in qualche modo. Tra gli esponenti dell'ultradarwinismo, oltre al filosofo contemporaneo Daniel Dennett, possiamo ricordare il sociobiologo Edward Wilson, e il biologo contemporaneo, Richard Dawkins, che è anche etologo e divulgatore scientifico, autore del famoso Il gene egoista (1976).
La convinzione di fondo degli ultradarwinisti è che lo scopo della vita sia la riproduzione dei geni, rispetto alla quale gli organismi degli esseri viventi sono meri strumenti. In particolare essi sostengono che la forma minima è il singolo gene. Il funzionamento dei geni può essere modificato da mutazioni casuali, ma l'esperienza di vita dei corpi in cui i geni abitano non influenza per nulla "l'informazione genetica" che trasmetteranno agli eredi. Il DNA è visto come informazione che passa alla proteine prodotte e poi alle cellule, ma in modo irreversibile (una volta che l'informazione contenuta nel DNA è passata alle proteine "non può più uscirne"). Inoltre sostengono che ogni aspetto del fenotipo (del corpo del vivente che percepiamo) come forma, struttura, funzionamento è conseguenza solo del processo di adattamento, in quanto tutte le mutazioni non funzionali all'adattamento sono eliminate dalla selezione naturale.

Critiche all'ultradarwinismo
Il singolo gene non è il solo livello al quale si attua la selezione. Vi è per esempio anche una selezione tra le cellule o tra le popolazioni. Inoltre la semplice mutazione genetica non si trasmette quasi mai immediatamente in una variazione corrispondente del fenotipo. Vi sono vincoli strutturali della crescita dell'organismo e vincoli di cooperazione tra le cellule che non consentono a tutte le variazioni genetiche di manifestarsi nell'organismo. Stephen Gould e Niles Eldrege hanno elaborato la teoria degli equilibri punteggiati (1977) che rafforza questo tipo di critica all'ultradarwinismo.
La selezione naturale non è la sola causa del cambiamento evolutivo. Vi sono possono essere caratteri del fenotipo dovuti al caso, oppure conseguenza di altri vincoli. Per esempio, il fenicottero ha le zampe rosa e si potrebbe pensare che il colore sia stato selezionato perché volando al tramonto sia meno distinguibile e quindi esso sfugga meglio ai predatori. Invece le zampe dei fenicotteri sono sottili e si intravedono le vene, e le vene sono rosse perché il sangue contiene emoglobina che serve a trasportare l'ossigeno. Il colore rosso dell'emoglobina è casuale rispetto alla sua funzione.
Vincoli strutturali e morfogenesi
Non tutte le variazioni genetiche possono realizzarsi nel fenotipo, poiché vi sono dei vincoli dovuti alla morfogenesi, come ad esempio il rapporto tra peso e volume di un animale o di un organo o di una cellula. Il volume aumenta in proporzione al cubo del raggio, la superficie al quadrato. Tutti gli organismi devono avere scambi con l'esterno attraverso la superficie: per esempio quando il volume della cellula aumenta, è sempre più difficile espellere i rifiuti all'esterno. Per un organismo unicellulare la dimensione massima è prestabilita dalle leggi chimiche e fisiche. Vi sono altri limiti dovuti ai tassi allometrici (esempio rapporti tra massa corporea e frequenza cardiaca, tra velocità di circolazione del sangue e crescita embrionale, ecc.). Il primo ha scoprire e sottolineare l'importanza di questi vincoli formali è stato Conrad Waddington (1968).
Darwinismo attivo e ruolo degli organismi
Gli organismi viventi non si limitano a subire passivamente la selezione naturale determinata dalle condizioni ambientali, ma hanno un ruolo attivo nel proprio destino e possono modificare parzialmente l'ambiente. Per esempio un organismo unicellulare si allontana nuotando da una zona scarsa di nutrimento alla ricerca di cibo. Popper parla di darwinismo attivo. Alcune idee di questo tipo furono anticipate dal filosofo Teilhard de Chardin (1881-1955).
Domande da interrogazione
- Quali sono le concezioni ispirate al darwinismo menzionate nel testo?
- Cosa sostiene l'ultradarwinismo riguardo alla riproduzione dei geni?
- Quali critiche vengono mosse contro l'ultradarwinismo?
- Qual è la teoria degli equilibri punteggiati e chi l'ha elaborata?
- Come gli organismi viventi possono influenzare il loro ambiente secondo il testo?
Il testo menziona il darwinismo sociale, il darwinismo neurale di Gerald Endelman, e altre applicazioni come la psicologia darwinistica, la medicina darwinistica e l'economia darwinistica.
L'ultradarwinismo sostiene che lo scopo della vita sia la riproduzione dei geni, con gli organismi viventi visti come strumenti per questo fine, e che il DNA trasmette informazioni in modo irreversibile.
Le critiche includono l'idea che la selezione avvenga anche a livelli diversi dal gene, che non tutte le variazioni genetiche si manifestano nel fenotipo, e che la selezione naturale non è l'unica causa del cambiamento evolutivo.
La teoria degli equilibri punteggiati, elaborata da Stephen Gould e Niles Eldrege, sostiene che l'evoluzione avviene attraverso periodi di stabilità interrotti da rapidi cambiamenti, criticando l'ultradarwinismo.
Gli organismi viventi possono avere un ruolo attivo nel loro destino, modificando parzialmente l'ambiente, come un organismo unicellulare che si sposta per cercare cibo, un concetto legato al darwinismo attivo di Popper.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo