Concetti Chiave
- Nel periodo post-Alessandro Magno, la filosofia ad Atene si evolve in una ricerca di saggezza come "farmaco dell'anima" per alleviare le malattie spirituali.
- Stoicismo, epicureismo e scetticismo offrono pratiche di condotta per raggiungere una felicità duratura, indipendente dalle circostanze esterne.
- Lo stoicismo, fondato da Zenone, vede la ragione come essenza umana, promuovendo il vivere secondo la natura e l'accettazione attiva del destino.
- L'epicureismo identifica la felicità con il piacere stabile e l'assenza di dolore, eliminando paure e desideri infondati grazie a una comprensione atomistica del mondo.
- Gli scettici perseguono l'imperturbabilità e la sospensione del giudizio, cercando la libertà interiore attraverso il distacco dalla realtà.
Atene e la filosofia post-Alessandro
Nel secolo seguente, dopo la morte di Alessandro Magno, Atene, benché politicamente decaduta, restò la capitale della filosofia. Ma i nuovi pensatori non furono più arditi riformatori politici, impegnati appassionatamente nella vita della città. Alla filosofia essi domandavano ormai solo il conforto della saggezza, e la concepivano come un “farmaco dell'anima”, capace di liberare quest'ultima dalle sue malattie: questo spirito è comune a tutti i filosofi della nuova età, greci di lingua, ma spesso di origine lontana, fenicia, siriaca o babilonese. Tale impostazione del senso dell'indagine filosofica ebbe conseguenze vastissime: le parole “stoico”, “epicureo”, “scettico” sono passate nella lingua corrente e designano, ormai senza riferimento alcuno alla loro origine storica e con implicazioni immediatamente chiare per tutti, determinati modi di atteggiarsi di fronte alla vita. La stessa parola “filosofo”, nella sua accezione più popolare, contiene un'allusione precisa al distacco, alla sopportazione e al disimpegno, che sono tratti comuni della saggezza propagandata dallo stoicismo, dall'epicureismo e dallo scetticismo. Le scuole ispirate a tali movimenti erano certo meno esclusive dell'Accademia di Platone o del Liceo di Aristotele, poiché non pretendevano di educare solo un'aristocrazia intellettuale, e si disseminarono perciò rapidamente in tutta l'area del mondo greco prima, e poi di quello romano. Stoicismo, epicureismo e scetticismo costituivano agli inizi della nostra era vere e proprie comunità filosofiche, alle cui dottrine gli aderenti chiedevano in definitiva solo la prescrizione di regole pratiche di condotta, capaci di assicurare una felicità stabile e duratura, non coinvolta nelle vicende della fortuna, della salute e dell'assetto politico degli Stati.
Stoicismo e la saggezza universale
Per lo stoicismo, fondato da Zenone di Cizio, l'essenza dell'uomo è la ragione, che lo connette alla totalità del reale. Il mondo è infatti un essere divino, un grande corpo animato dal soffio vitale dell'anima, che è sostanza ignea immanente in tutte le cose. Il ritmo della vita del mondo procede secondo l'alternanza costante di un processo evolutivo e di un successivo ritorno all'unità originaria del fuoco eterno e ogni nuovo ciclo ripete esattamente i momenti di quello precedente (eterno ritorno). 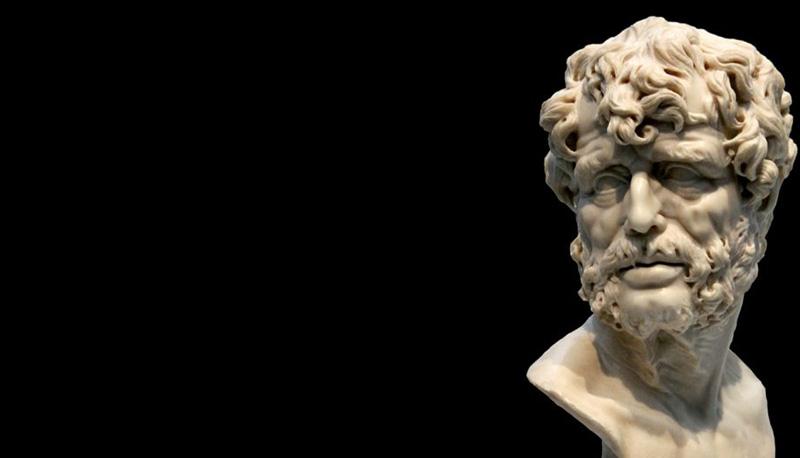
Epicureismo e il piacere stabile
Muovendo da premesse del tutto diverse, gli epicurei dettero una soluzione analoga del problema, anch'essa incentrata sulla conquista di un controllo razionale del disordine delle passioni. La felicità consiste per l'uomo nel piacere, ma in un piacere “stabile”, cioè senza variazioni e turbamenti, e perciò identificabile senz'altro con l'assenza di dolore. La maggior parte delle preoccupazioni che turbano l'uomo è frutto di false rappresentazioni: così noi temiamo l'al di là, presunto luogo di pene future, popoliamo l'universo di entità divine e demoniache che esigono da noi sacrifici, temiamo le meteore e le eclissi come annunci di imminenti sventure. Ora tutte queste superstizioni, che avvelenano la vita umana, nascono da un'erronea concezione del mondo fisico. L'unica spiegazione razionale di esso è quella atomistica, per la quale tutti gli esistenti, anime umane comprese, sono aggregati casuali e provvisori di atomi, destinati a dissolversi per dar luogo a nuove formazioni. Se la vita è l'aggregarsi degli atomi (secondo la teoria del clinamen: deviazioni) e la morte la loro disgregazione, finché noi saremo non ci sarà la morte, e quando questa verrà non saremo più noi: il timore della morte si riferisce a una esperienza impossibile. Parimenti infondati sono il timore dell'al di là e quello degli dei, i quali ultimi sono anch'essi aggregati provvisori di atomi, del tutto indifferenti alle nostre vicende. A questo punto ciò che si frappone ancora fra l'uomo e la felicità sono i desideri che non possono essere soddisfatti e le sofferenze delle malattie. La prudenza ci aiuta a liberarci dai primi, insegnandoci che la felicità è assenza di pena e che la pena si elimina sopprimendo il desiderio; quanto alle seconde, si può sempre compensare il dolore presente col ricordo delle gioie passate.
Scetticismo e la libertà interiore
Anche per gli scettici, che rifiutano qualunque scelta e sospendono programmaticamente il giudizio, la saggezza consiste nell'imperturbabilità (atarassia) epicurea, integrata dalla rinuncia perfino all'uso della parola (afasia), in un mondo popolato da vani fantasmi. Collocato in un universo a lui estraneo, ma non ostile fino al punto da rendere impossibile la salvezza del singolo, l'uomo si redime conquistando la libertà interiore e coltivando la saggezza come faticosa arte del disimpegno dalla realtà e dalla storia.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della filosofia dopo la morte di Alessandro Magno?
- Come si differenziano le scuole filosofiche di stoicismo, epicureismo e scetticismo?
- Qual è la concezione del mondo secondo lo stoicismo?
- In che modo gli epicurei affrontano il timore della morte e degli dei?
- Qual è l'obiettivo finale della saggezza per gli scettici?
Dopo la morte di Alessandro Magno, la filosofia ad Atene si concentra sul conforto della saggezza come "farmaco dell'anima", piuttosto che sull'impegno politico.
Lo stoicismo si basa sulla ragione e l'accettazione del destino, l'epicureismo sulla ricerca del piacere stabile e l'assenza di dolore, mentre lo scetticismo promuove l'imperturbabilità e la sospensione del giudizio.
Lo stoicismo vede il mondo come un essere divino animato da un'anima ignea, con un ordine razionale predeterminato, dove la saggezza consiste nel seguire la natura e accettare il destino.
Gli epicurei considerano la morte un'esperienza impossibile da temere e vedono gli dei come entità indifferenti, eliminando così le superstizioni che avvelenano la vita umana.
Per gli scettici, l'obiettivo finale della saggezza è l'imperturbabilità e la libertà interiore, ottenute attraverso la sospensione del giudizio e il disimpegno dalla realtà e dalla storia.

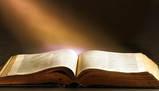





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo