Concetti Chiave
- La poesia "Novembre" di Giovanni Pascoli evoca un paesaggio autunnale che inizialmente appare primaverile, ma rivela la sua vera natura come simbolo di disillusione e morte.
- Strutturalmente, la poesia è composta da tre strofe saffiche con rime alternate, utilizzando un linguaggio semplice ma ricco di simbolismo e figure retoriche come sinestesie e ossimori.
- Il simbolismo nella poesia si concentra sull'illusione della primavera e la realtà autunnale, rappresentando la precarietà della vita e la sua inevitabile fine.
- Pascoli utilizza un linguaggio impressionistico e allusivo per evocare sensazioni attraverso i sensi, con una particolare attenzione alla musicalità e ai suoni delle parole.
- La poesia conclude con l'immagine di un'estate fredda dei morti, unendo la bellezza ingannevole della natura con la realtà della morte e della solitudine.
Novembre è una poesia tratta dalla celebre raccolta poetica Myricae e la cui edizione originale è del 1891. Si tratta di un componimento poetico ambientata a Novembre, precisamente l'11 novembre, data denominata "l'estate di San Martino". In questo mese tutto è secco, nell'aria c'è il colore tipico dell'autunno che fa da sfondo alle persone che non ci sono più. Dal punto di vista stilistico la poesia è suddivisa in strofe saffiche, i cui versi sono degli endecasillabi e un quinario che presenta una rima di tipo alternato (ABAb). Il simbolismo, nella seguente lirica del Pascoli, è evidente soprattutto nella scelta del tema che viene trattato, ovvero l'estate di San Martino. La poesia del Pascoli presenta inoltre, nell'ambito della forma sintattica, della congiunzione coordinante "e".
Gemmea l'aria, il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l'odorino amaro
senti nel cuore...
Ma secco è il pruno e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.
Silenzio, intorno; solo, alle ventate
odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cadere fragile.  E' l'estate,
E' l'estate,
fredda, dei morti.
Indice
- Struttura e simbolismo della poesia
- Parafrasi e commento della poesia
- Analisi delle strofe e figure retoriche
- Temi principali della poesia
- Analisi dettagliata delle strofe
- Contrasti e simbolismo nella poesia
- Illusione e realtà nella poesia
- Disillusione e morte nella poesia
- Conclusione e significato della poesia
Struttura e simbolismo della poesia
Novembre di Pascoli, riassunto: “Novembre” di Pascoli è una poesia scritta dal poeta e composta da tre strofe composte a loro volta da endecasillabi saffici (tre endecasillabi e un quinario; questa struttura vuole dare un senso di lentezza) e dodici versi. La rima è alternata e il senso è discendente (si parte da una situazione positiva, disillusione, disincanto; si parte dal bello per arrivare alla tristezza).
La struttura di Novembre di Pascoli è paratattica, essenziale, veloce.
• La prima strofa: pur essendo in novembre, l’illusione della primavera.
• Seconda strofa: disillusione.
• Terza strofa: la presa di coscienza che si è in autunno.
Il linguaggio di Novembre di Pascoli è semplice e quotidiano, ma simbolico, le parole sono ricche di simboli. Il linguaggio è allusivo e impressionistico, che deve evocare le impressioni che hai attraversi i sensi.
Le figure stilistiche, retoriche sono molte. Sono presenti molti enjambement (quattro).
• “Odorino amaro” è una sinestesia (figura stilistica che, in questo caso, mette insieme un senso olfattivo con un senso gustativo. Si ha una sinestesia quando vengono unite due sensazioni diverse. Ritrovo la sinestesia quando ho un linguaggio impressionistico).
• “Estate fredda” è un ossimoro (contrapposizione di due parole; nome e aggettivo in contrasto. Anche l’ossimoro è usato per ottenere un linguaggio impressionistico).
• “Gemmea l’aria” è un chiasmo (aggettivo e nome, sensazione fonico – visiva, sensazione sensoriale).
Nella poesia Novembre di Pascoli si ha uno scardinamento della struttura metrica classica.
Lo spazio e il tempo sono simbolici: il tempo è novembre, mentre lo spazio è di campagna, agreste (Pascoli pensa sempre alla campagna romagnola). Il poeta non ci vuole rappresentare la realtà; apparentemente ce la sta descrivendo, ma tutto rappresenta un’altra cosa.
Il titolo, “Novembre”, rappresenta tutte le cose che sono destinate a morire, a non esserci più. In tutta la poesia è presente il senso della morte. Via via c’è il senso di tristezza, malinconia, lentezza. Pascoli ci sta parlano della vita, che poi porterà della morte. La poesia è ricca di musicalità in positivo per ottenere un linguaggio impressionistico. Le consonanti R e L accentuano gli effetti sonori.
Nella poesia Pascoli unisce diversi campi semantici, sensoriali: olfattivo – uditivo, visivo, fonico. Apparentemente parla di sensazioni, ma parla dei suoi stati d’animo.
Parafrasi e commento della poesia
Parafrasi Novembre Pascoli: L’aria è limpida e fredda, la luce del sole è così chiara che tu cerchi con lo sguardo gli albicocchi fioriti, l’odore amaro del biancospino dentro il tuo cuore…
Ma, in realtà, il pruno è secco, e le piante stecchite tramano il cielo con i loro rami spogli e scuri, il cielo è privo di nuvole, e sotto il piede il terreno sembra duro e cavo.
Tutto intorno v’è silenzio: solo con le folate di vento senti da lontano, dai giardini e dagli orti, un rumore leggero delle foglie che cadono. E’ l’estate fredda e veloce dell’inizio di novembre.
Novembre Pascoli, commento: La poesia “Novembre” di Pascoli fu elaborata nel 1890 e pubblicata su “La Vita Nuova” nel febbraio 1891; infine fu conclusa nella prima edizione di Myricae nel 1891. E’ composta da tre quartine a rima alternata. La prima impressione è quella di avere davanti un paesaggio primaverile, ma questa è solo un’illusione: infatti la poesia è ambientata in novembre e i vari odori e colori sono percepiti non con i sensi ma con l’immaginazione.
Analisi delle strofe e figure retoriche
Nella prima quartina, viene descritto un paesaggio tipicamente primaverile, e persistono immagini di vita, di luce e di colore; nella seconda, invece, viene descritto il paesaggio autunnale e allude alla morte, e nell’ultima quartina Pascoli affianca l’immagine della “finta” estate alla morte, quindi sono presenti .
L’elemento che bipartisce i due quadri naturali è “ma”, poiché ribalta tutto ciò che è stato detto un attimo prima. Inoltre la seconda quartina è piena di parole come “secco e stecchite” che cambiano immediatamente l’immagine della primavera. Sono presenti alcune sinestesie, come “odorino amaro”, “cader fragile”, e un ossimoro: “estate fredda”.
La poesia “novembre”, di Giovanni Pascoli, è composta da tre strofe, di cui tre versi sono endecasillabi, mentre l’ultimo è quinario, e dodici versi.
Le rime sono alternate.
La struttura della poesia è semplice e lineare. Il linguaggio non è ricercato, ma è ricco di significati e di simboli. Esso evoca spesso impressioni.
Sono presenti numerose figure retoriche.
Innanzitutto si possono incontrare molti enjambement che forniscono scorrevolezza alla poesia altrimenti scandita da una rigida metrica.
“Odorino amaro” è una sinestesia, che accosta una sensazione percepibile con il senso olfattivo e una con il senso gustativo.
Inoltre, “estate fredda” è un ossimoro, che relaziona due parole in netto contrasto fra di loro.
Temi principali della poesia
Commento: “Novembre” affronta diverse tematiche. Apparentemente la poesia descrive l’arrivo dell’autunno, ma questa descrizione è simbolica.
Nella prima strofa si affronta una situazione positiva: si vedono e si ricordano gli odori e le belle sensazioni della primavera.
Nella seconda strofa si ha una netta contrapposizione. Tutto ciò che si è provato è un inganno. La primavera, così come la vita è condannata alla dissolutezza; all’autunno, e infine all’inverno.
La terza strofa rappresenta la drastica conclusione. La solitudine, il silenzio.
Questa è la rappresentazione simbolica della vita umana: tutto è destinato alla vecchiaia e infine alla morte.
È predominante il senso di malinconia e di glaciale tristezza. La staticità e il silenzio rappresentano la fine, il ricordo di ciò che è stato e che più non sarà.
Il titolo di questa poesia non ci fa comprendere alla prima lettura gli aspetti che si vogliono esaltare, poiché si comprende subito che il titolo si riferisce ad una collocazione nel tempo, mentre significa anche il mese nel quale si ricordano i propri cari che sono venuti a mancare.
Come la maggior parte dei componimenti che fanno parte della raccolta Myricae, anche questo, più che a descrivere la natura in un suo particolare momento (il due novembre, che nella tradizione si ricorda per essere l’estate dei morti viventi), è rivolto a penetrare nel senso segreto delle cose, e a scoprirne un messaggio di morte, un senso di fragilità e di vuoto.
Una serena giornata di novembre può per un attimo suggerire un'illusione di primavera e riportare quasi il profumo degli albicocchi in fiore. Ma si tratta di un'illusione che presto scompare, e alle iniziali impressioni subentra l’inverno che non solo indica solo la stagione, ma è metafora della precarietà dell’esistenza.
In questa poesia, come spesso accade in Pascoli, il paesaggio mostra un duplice aspetto. Sotto un'apparenza di armonia e di positività possono nascondersi la presenza e la minaccia della morte. Quindi una giornata mite e serena può trasmettere per un attimo la sensazione di primavera, mentre in realtà è novembre.
In questo, si può riscontrare un’analogia con Leopardi, il quale afferma che un piacere è figlio d’affanno, perché destinato a durare poco, in quanto è solo una pausa tra due angosce.
In questo mese cade la cosiddetta "estate di San Martino", termine con il quale Pascoli ha voluto fondere particolarità del mese: la presenza frequente di giornate calde, quasi estive, e la ricorrenza dei morti che cade agli inizi di novembre.
Nella prima strofa vi è inizialmente un'immagine primaverile (“Gemmea l'aria,il sole è così chiaro”), l'immagine di una giornata soleggiata nel mese di novembre. Il poeta infatti ci presenta una sensazione di luce e di vita, sottolineata dalla prevalenza di vocali aperte e dal paesaggio primaverile. La prima parola con cui si apre la poesia (“Gemmea”) racchiude l’idea di luminosità, di purezza e di vita. È presente anche la sinestesia “odorino amaro” al rigo tre. Il verso si chiude con “senti nel cuore”, parole dolci e calme che esprimono tranquillità, che viene spezzata però dal “Ma” del 5 rigo che capovolge la situazione e il poeta ci rappresenta il risvolto della medaglia, spiegandoci la breve illusione della felicità (“piacer figlio d’affanno” [Leopardi]).
Nella bella giornata autunnale, la luce del sole e l'aria limpida danno per un istante l'illusione che sia primavera, ma subito ci si rende conto che le piante sono secche e spoglie (“ma secco è il pruno, e le stecchite piante”), quindi, inutilmente si cerca di scoprire gli alberi, ritornando alla realtà con la congiunzione avversativa e le parole "secco – stecchite – nere – vuoto – cavo", danno la sensazione di vuoto, di silenzio.
Nella terza strofa viene confermata la realtà di morte, infatti, la poesia si apre con “silenzio”, che crea un’atmosfera funebre, accentuando la presenza della morte, (sottolineata anche con la sinestesia “cader fragile” che rafforza l’idea della precarietà e della morte, riferendosi alla vita umana) e la conclude con l’ossimoro “è l’estate fredda dei morti”. L’aggettivo fredda ci riporta a “gemmea” (al primo rigo) per sottolineare, appunto, il contrasto tra la vita e la morte. Il poeta, in questa ultima strofa, inserisce aggettivi che contengono un significato di vuoto e di solitudine: “silenzio – solo – lontano – fragile - fredda”.
È uno dei testi più antichi di Pascoli, già presente nella prima edizione di Myricae. Il paesaggio è una realtà a doppio fondo: sotto un’apparenza di armonia e di positività possono nascondersi la presenza e la minaccia della morte.
A novembre cade sia la famosa Estate di san Martino, in cui si possono avere alcune giornate quasi estive, sia la ricorrenza dei morti. Il poeta vuole quindi fondere i due aspetti nella conclusione, definendo il clima quale "estate dei morti".
Il testo è diviso in tre strofe saffiche.
Analisi dettagliata delle strofe
PRIMA STROFA: clima primaverile.
Questa atmosfera di rinascita è sottolineata dalle parole:
- Gemmea, che indica sia la rinascita della vita, sia il germoglio degli alberi;
- Albicocchi in fiore, che danno l’idea della luce;
- Prunalbo con l’odorino amaro, che fa quasi sentire il profumo della vita.
SECONDA STROFA: osservazione realistica
Il discorso è opposto al precedente sul piano:
- sintattico: mentre la prima strofa è giocata sulla consecutività, la seconda è paratattica, secca;
- Lessicale: a gemmea e a sole si contrappongono secco, stecchite, nere trame, vuoto ciel, cavo terreno;
- Ritmico: mentre la prima strofa è costituita dal climax ascendente, la seconda ha un ritmo molto più lento.
Nella seconda strofa domina l’allitterazione della S.
Pascoli deriva questo artificio dalla Divina Commedia, in cui è presente il sigmatismo, la quale è la preponderanza della lettera S (sigma greco) dura e non sibilante che allude alla pesantezza della morte. Dante usa il sigmatismo nel XIII canto dell’Inferno che ha come tema principale quello del suicidio. Le parole della seconda strofa appartengono al campo semantico dell’aridità e la disillusione è sottolineata dal fatto che gli aggettivi precedono il nome (stecchite piante, nere trame).
TERZA STROFA: ha carattere sentenzioso
Pascoli sposta l’attenzione da un dato naturalistico a un dato simbolico. Il silenzio dal punto di vista naturalistico è l’autunno, ma simbolicamente rappresenta la morte. Il cader fragile rappresenta denotativamente le foglie che cadono dagli alberi in autunno. La sentenza finale è espressa dall’ultimo verso: è l’estate fredda dei morti.
Gli ultimi versi sono separati dalla virgola e spezzati dall’enjambement per indicare che la morte (trattata in questi versi) frantuma la vita dell’uomo. La frantumazione rende meno solenne il verso. PierVincenzo Mengaldo parla, a questo proposito, di dissolvimento dell’endecasillabo.
Si parla inoltre di circolarità del testo: la gemma che apre la poesia è fredda, come è fredda l’estate dei morti che la chiude. Importanti sono:
- l’allitterazione della lettera F che indica la caducità che si sposta dalla natura all’uomo;
- Il legame tra due ossimori (estate fredda, estate dei morti);
- La sinestesia (gemmea l’aria, odore amaro, cader fragile);
- Il chiasmo (gemmea l’aria, sole chiaro);
- Il linguaggio post-grammacale (albicocchi, prunalbo, pruno).
C’è una realtà ambigua fondata sull’inquietudine, sottolineata da una serie di antitesi (albicocchi in fiori- stecchite piante) e soprattutto dalla contrapposizione apparenza-realtà.
Contrasti e simbolismo nella poesia
Nella poesia sono presenti il tema della natura e della morte. Ognuna delle tre strofe annuncia, nel primo emistichio, un tema (per un totale di tre).
PRIMA STROFA: Il tema dell’illusione.
Illusione e realtà nella poesia
Viene presentata un’immagine primaverile della natura. Il poeta si trova in un’atmosfera limpida e fredda come una gemma, mentre il sole è così caldo che si può cercare l’albicocco in fiore e il profumo del prunalbo (biancospino).
Disillusione e morte nella poesia
SECONDA STROFA: Il tema della disillusione che viene seguito da parole dure (secco pruno, stecchite piante). . Il paesaggio precedente sembrava illusoriamente primaverile, ma ci troviamo, in realtà, in autunno: il terreno è gelato, l’aria è fredda e il cielo senza uccelli.
TERZA STROFA: Il tema della morte.
Conclusione e significato della poesia
Tutto è silenzio, si percepisce solo il rumore delle foglie che cadono dagli alberi. Siamo nei primi giorni di novembre, in cui le giornate si scaldano nell’estate di San Martino, ma vengono anche ricordati i defunti il 2 novembre.
La nomenclatura botanica così accurata (“albicocco”, “prunalbo”) sembra stridere con il carattere illusorio della poesia di Pascoli: Novembre, come l’intera raccolta Myricae, propone un quadro apparentemente oggettivo che attraverso la suggestione sfuma nell’immaginario. In realtà, la precisione terminologica è strumento per penetrare l’apparenza delle cose, poiché, secondo Pascoli, i termini generici non ne trasportano la reale essenza.
Se, però, la prima strofa sembra illustrare un quadro effettivamente concreto, le successive ne rivelano il significato: lo scenario primaverile contrasta con quello autunnale, in cui profumi, colori e luci si convertono nei tratti della natura morente. Le “stecchite piante di nere trame”, il “vuoto” del cielo, il “cader fragile” delle foglie e il “Silenzio, intorno” sono analogie della morte, la trama sotterranea della poesia.
Pascoli si avvale di espressioni linguistiche suggestive per evocare il significato più profondo del componimento e attraverso la sinestesia associa alcuni termini a sfere sensoriali distinte: la realtà apparente ma illusoria e la realtà subliminale (il “cader fragile” delle foglie). Sul piano strutturale si nota la tipica dissoluzione della sintassi logica e l’uso ricorrente dello stile nominale, per cui sostantivi e aggettivi esprimono la massima carica suggestiva. Il discorso è fatto di lampi intuitivi, di illuminazioni momentanee e frammentarie, collegate tutt’al più da segrete analogie e corrispondenze. A ciò contribuiscono le continue interruzioni che rompono i versi e l’unità ritmica della poesia (“Silenzio, // intorno; // solo, // alle ventate”). Nel verso finale l’aggettivo “fredde” indica l’ambigua presenza della morte dietro la vita ed è separato dall’espressione “dei morti” per rivelare, nella pausa, la conflittualità tormentata che si cela al fondo dell’animo pascoliano.
Autori che hanno contribuito al presente documento: kli, snake, Smarty4, yya, SteDV.
Domande da interrogazione
- Qual è il tema principale della poesia "Novembre" di Giovanni Pascoli?
- Come è strutturata la poesia "Novembre"?
- Quali figure retoriche sono presenti nella poesia?
- Qual è il significato simbolico del mese di novembre nella poesia?
- In che modo Pascoli utilizza il paesaggio per esprimere i suoi stati d'animo?
Il tema principale della poesia "Novembre" è la transitorietà della vita e la presenza costante della morte, simboleggiata dall'autunno e dall'illusione di una primavera che si rivela effimera.
La poesia è composta da tre strofe saffiche, ognuna con tre endecasillabi e un quinario, e presenta una rima alternata. La struttura è paratattica e simbolica, con un linguaggio semplice ma ricco di significati.
La poesia contiene diverse figure retoriche, tra cui sinestesie come "odorino amaro", ossimori come "estate fredda", e chiasmi come "gemmea l'aria". Queste figure contribuiscono a creare un linguaggio impressionistico.
Novembre simboleggia la morte e la fine delle cose, rappresentando un periodo di riflessione sulla transitorietà della vita e la memoria dei defunti, in coincidenza con l'estate di San Martino.
Pascoli utilizza il paesaggio autunnale per riflettere i suoi stati d'animo di malinconia e disillusione, mostrando come un'apparente armonia nasconda la presenza della morte e la fragilità dell'esistenza.



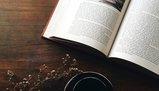





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo