Concetti Chiave
- Il protagonista del dramma di Pirandello riconosce di non essere più pazzo, ma si rende conto di aver perso la possibilità di vivere una vita normale.
- Il tema centrale è la finzione sociale, dove tutti indossano maschere, e il protagonista sceglie di vivere consapevolmente questa finzione.
- Il dramma esplora l'autonomia della finzione, portando il protagonista a un delitto che lo costringe a continuare a fingere per evitare la punizione.
- Pirandello utilizza elementi del teatro tradizionale, come il colpo di scena e il finale melodrammatico, inserendoli in un contesto di finzione esplicita.
- La consapevolezza della finzione scenica porta gli spettatori a un maggiore distacco razionale, riducendo l'adesione emotiva alla storia.
Indice
La Confessione Finale
Nelle battute finali del dramma il protagonista confessa agli astanti di non essere più pazzo, ma al tempo stesso lamenta l'impossibilità di tornare a una vita normale. Passati tanti anni, egli si accorge che ormai il banchetto è già bell'e sparecchiato (r. 27), cioè, fuor di metafora, che la vita è stata goduta da altri, mentre lui era recluso nel carcere mentale e fisico della sua pazzia. Ora è rinsavito, ma per lui rimangono solo avanzi (r. 37), una magra o molle pietà (rr. 37-38) o, al massimo, un po' di rimorso (r. 38) da parte degli altri.
La Maschera della Realtà
L'unica soluzione che gli appare possibile, dunque, è quella di vivere la propria condizione con la più lucida coscienza (r. 42), vale a dire con piena consapevolezza, per scelta e non per accidente. D'altra parte afferma Enrico la finzione accomuna tutti, pazzi e sani di mente, essendo una generale consuetudine sociale: i panni regali che egli ha vestito per tanti anni, e che continua anche ora a indossare, sono soltanto la caricatura, evidente e volontaria, di quest'altra mascherata, continua, d'ogni minuto, di cui siamo i pagliacci involontarii (rr. 65-66), vale a dire il simbolo esasperato dell'abitudine a fingere, ad assumere maschere e ruoli rigidi, che tutti noi manteniamo nei rapporti interpersonali di tutti i giorni. Ma a differenza di Enrico, che ha scelto di fare della maschera la propria realtà, gli altri non sono in grado di vedere che l'abito, la maschera che portano su di sé, corrisponde ormai alla loro stessa persona (r. 69).
La Finzione e il Delitto
La finzione può però assumere una vita autonoma, inconsapevole, anche in chi, come Enrico, normalmente sia cosciente del carattere "teatrale" del nostro agire e del nostro atteggiarci: è proprio quella vita che in un momento lo ha forzato al delitto (rr. 150-151). A questo punto solo la prosecuzione della sua recita potrà evitargli la punizione per il delitto compiuto.
Il Dramma di Pirandello
Perciò non gli resta che continuare a fingere: Ora si... per forza... r. 151). Dopo avere rivelato di essere guarito dalla follia, adesso, avendo ucciso Belcredi, Enrico si è condannato a portare per sempre la maschera e a rimanere ancorato a un destino di solitudine assoluta. Nello strutturare il suo dramma, Pirandello riprende alcuni topoi del teatro tradizionale, come il colpo di scena nel momento in cui culmina la vicenda (qui la rivelazione che il protagonista non è pazzo, ma ha soltanto finto di esserlo) e il finale melodrammatico (in questo caso la punizione del colpevole). Tuttavia, tali elementi sono inseriti in un contesto la cui finzione viene esplicitamente esibita: un castello falso, personaggi mascherati con costumi medievali da operetta, un protagonista che simula di essere pazzo, una storia apertamente inverosimile. In tal modo il pubblico viene di continuo avvertito che il dramma non è reale e neppure realistico, ma che si tratta, appunto, di un'invenzione fantasiosa. Ciò determina come conseguenza un raffreddamento dell'adesione emotiva dello spettatore alle vicende rappresentate, a favore di un maggior distacco razionale.
Domande da interrogazione
- Qual è la confessione finale del protagonista nel dramma?
- Cosa rappresenta la "maschera della realtà" nel dramma?
- Come la finzione si collega al delitto nel dramma?
- Qual è il destino del protagonista dopo aver ucciso Belcredi?
- Come Pirandello struttura il dramma per evidenziare la finzione?
Nelle battute finali, il protagonista confessa di non essere più pazzo, ma lamenta l'impossibilità di tornare a una vita normale, poiché la vita è stata goduta da altri mentre lui era recluso nella sua pazzia.
La "maschera della realtà" rappresenta la consapevolezza che tutti, pazzi e sani di mente, vivono in una finzione sociale, indossando maschere e ruoli rigidi nei rapporti interpersonali.
La finzione assume una vita autonoma e inconsapevole, forzando Enrico al delitto. Solo continuando a fingere potrà evitare la punizione per il delitto compiuto.
Dopo aver ucciso Belcredi, il protagonista è condannato a portare per sempre la maschera e a rimanere ancorato a un destino di solitudine assoluta.
Pirandello inserisce elementi tradizionali come il colpo di scena e il finale melodrammatico in un contesto di finzione esplicita, con un castello falso e personaggi mascherati, per creare un distacco razionale nello spettatore.

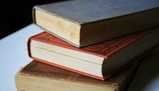





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo