vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
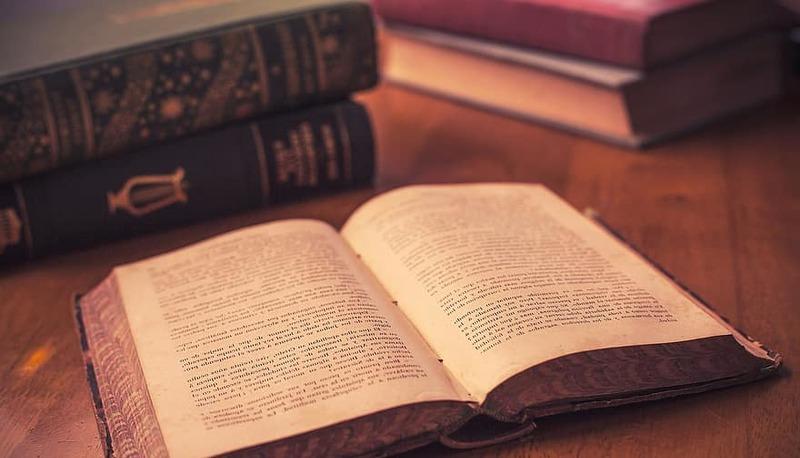
Il contesto storico del Quattordicesimo secolo
Il Quattordicesimo secolo è stata un’epoca contraddistinta dal tramonto del mondo medievale. Infatti, le struttura di questa epoca vengono messe in crisi dallo scisma di Occidente, con il quale la sede del papa viene spostata nuovamente e in modo definitivo a Roma.
Si tratta di un’epoca contraddistinta da una grave crisi economica e sociale, nello specifico, si verificarono:
- Carestie, tra il 1315 e il 1347, che comportarono un impoverimento generale;
- Diminuzione della produttività nelle principali città italiane;
- Crollo della crescita demografica;
- Rivolte contadine;
- Peste.
Il Trecento è stato un periodo di frattura, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista culturale. Gli autori che hanno avvertito questa frattura e che costituiscono i principali esponenti della letteratura del Quattordicesimo secolo sono: Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca. Di seguito viene trattata una Mappa concettuale poesia di questi autori.
Per approfondimenti sul contesto storico del Quattordicesimo secolo vedi anche qua
La vita e le opere di Giovanni Boccaccio
Giovanni Boccaccio è stato uno scrittore vissuto durante il Quattordicesimo secolo. Sebbene lo scrittore raccontasse di essere nato a Parigi da una relazione segreta tra il padre e la figlia del re di Francia, in realtà, Giovanni Boccaccio nacque a Certaldo, in Toscana, nel 1313, ed è figlio illegittimo di un mercante. Ha compiuto i primi studi a Firenze, per poi trasferirsi con il padre a Napoli. Il trasferimento in questa città è stato determinante per la formazione di Giovanni Boccaccio. In questo periodo, lo scrittore affiancava il padre nelle attività mercantili e questa esperienza è stata fondamentale: infatti, Giovanni Boccaccio è entrato in contatto con un’eterogeneità di persone, di differenti classi sociali. Un incontro determinante è stato con una ragazza, Fiammetta, che ha svolto un ruolo centrale per la sua produzione letteraria. Inoltre, in questo periodo, Giovanni Boccaccio ha avuto modo di frequentare la corte di Roberto D’Angiò, un vivace centro culturale e mondano. In questo contesto, Giovanni Boccaccio si appassiona alle Lettere e scrive le sue prime opere: il “Filocolo” e il “Filostrato”.
Il 1348 è stato un anno molto importante per la produzione letteraria di Giovanni Boccaccio: il padre muore e scoppia l’epidemia di peste. Questi eventi hanno ispirato la scrittura del suo capolavoro, il “Decameron”. L’opera è stata scritta tra il 1349 e il 1353 e racconta di 10 ragazzi (3 ragazzi e 7 ragazze) che per 10 giorni si rifugiano in campagna per sfuggire all’epidemia di peste e trascorrono il tempo raccontandosi delle novelle. In particolare, il libro contiene 100 novelle, attraverso le quali Giovanni Boccaccio descrive una grande eterogeneità di personaggi, affrontando tematiche e registri differenti (ad esempio: denuncia sociale, comicità, tragedia, e così via).
Negli anni successivi alla scrittura del Decameron, Giovanni Boccaccio si dedica all’approfondimento dello studio dei classici e alla diffusione dell’opera di Dante Alighieri.
Muore nel 1375.
Per approfondimenti sulla vita e le opere di Giovanni Boccaccio vedi anche qua
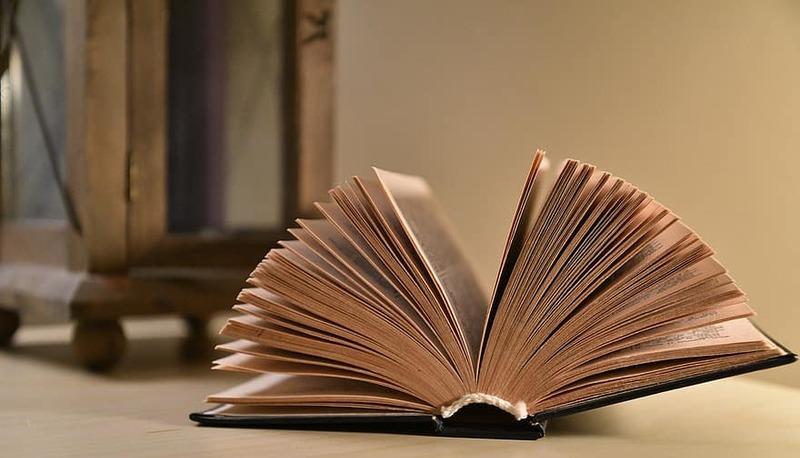
La vita e le opere di Francesco Petrarca
Francesco Petrarca è nato ad Arezzo nel 1304 in una famiglia agiata di origine fiorentina. Nel 1312 si trasferì con la famiglia ad Avignone, che in quel periodo era una delle città più prestigiose. Dopo aver studiato per un periodo all’Università di Bonn in Germania, Francesco Petrarca si trasferì a Bologna per frequentare gli studi giuridici. Tuttavia, in questo contesto nacque la sua passione per la letteratura e compose le prime poesie. Nel 1326, anno di morte del padre, Francesco Petrarca fece ritorno ad Avignone, dove si inserì nella società aristocratica del tempo e iniziò a dedicarsi allo studio dei classici.
La cultura di Francesco Petrarca ha due influenze prevalenti, che l’autore ha sempre cercato di conciliare: da un lato, la cultura classica, in particolare le opere di Cicerone e Virgilio, dall’altro lato, la spiritualità cristiana, con la grande influenza dell’opera “Le confessioni di Sant’Agostino. In effetti, le opere di Francesco Petrarca comprendono sia opere in latino, sia opere in volgare. Nello specifico, tra le opere scritte in latino, che costituiscono la maggior parte della produzione letteraria dell’autore, ricordiamo:
- ”Africa”, un poemetto epico sulla seconda guerra punica;
- Il ”Secretum”, un dialogo immaginario tra l’autore e Sant’Agostino;
- Le ”Epistole”, una serie di lettere rivolte a familiari, amici e personaggi storici della cultura classica.
Tra le opere scritte in volgare, spicca il ”Canzoniere” (o meglio “Rerum volgarium fragmenta”). Si tratta di una raccolta di 366 poesie, che riflettono il mondo interiore del poeta, affrontando una pluralità di temi, tra i quali è fondamentale il tema amoroso e l’amore non corrisposto di Laura. La figura di Laura, a differenza della donna-angelo dantesca, è una donna concreta e umaniz-zata. L’amore provato dal poeta è motivo di sensi di colpa in quanto vissuto nella sua forma terrena e considerato come un sentimento che allontanerebbe dalla beatitudine divina.
Un’importante peculiarità del Canzoniere è la sua concezione antropocentrica, che mette l’uomo al centro, differenziandosi quindi dalle opere che mettono al centro Dio.
Per approfondimenti sulla vita e le opere di Francesco Petrarca vedi anche qua








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









