Concetti Chiave
- Leopardi è un precursore della poesia del novecento, rompendo con la tradizione e incitando gli uomini a vivere senza essere vittime di se stessi.
- La vita di Leopardi è caratterizzata da un'intensa attività intellettuale e letteraria, con importanti esperienze a Recanati, Roma, Firenze, Pisa e Napoli.
- Il pensiero leopardiano è centrato su un pessimismo in evoluzione: personale, storico e cosmico, con la natura vista come un meccanismo cieco e indifferente.
- Le opere di Leopardi utilizzano l'immaginazione come rimedio all'infelicità, creando un infinito irraggiungibile che si contrappone ai piaceri finiti della realtà.
- La poesia "L'infinito" è un esempio di come l'immaginazione possa evocare un infinito spaziale e temporale, attraverso sensazioni visive e uditive.
Indice
Leopardi e il romanticismo
Leopardi ha saputo cogliere in maniera intensa i sentimenti, la natura, l’angoscia dell’individuo, la solitudine, la noia, il piacere, l’infelicità. Leopardi pur appartenendo a pieno al Romanticismo, anticipa ed è il precursore della poesia del novecento: esce dagli schemi rigidi della tradizione e della canzone petrarchesca. Le sue opere sono in endecasillabi e settenari. Dal momento che è l’anima che parla non ho bisogno di schemi rigidi (“La poesia è la voce dell’anima”). Leopardi incita gli uomini a vivere, a non essere vittime di se stesse. Assistiamo a varie fasi: pessimismo personale, pessimismo storico e pessimismo cosmico.
Infanzia e formazione
Nasce a Recanati il 29 giugno 1798 dal conte Monaldo e Adelaide Antici. Il padre era un uomo colto infatti nel suo palazzo aveva messo insieme una notevole biblioteca dove Leopardi affrontò quelli che lui definisce i “sette anni di studio matto e disperatissimo”. Imparò in breve tempo il latino, il greco e l’ebraico: tradusse le Odi di Orazio, il I libro dell’Odissea, il II libro dell’Eneide. Sul piano politico segue gli orientamenti reazionari del padre (esempio nell’orazione “Agli italiani per la liberazione del Piceno” in cui esalta il vecchio dispotismo illuminato).
Tra il 1815 e il 1816 abbiamo la conversione “dall’erudizione al bello”: si entusiasma per i grandi poeti (Omero, Virgilio, Dante) e comincia a leggere Rousseau, la vita di Alfieri, Il Werther.
Amicizie e influenze
Riesce a ritrovare quella confidenza affettuosa che gli manca nell’ambiente familiare grazie all’amicizia con Pietro Giordani, di orientamento classicistico ma con idee democratiche e laiche.
Nell’estate del 1819 tenta la fuga dalla casa paterna ma il tentativo viene scoperto e sventato. La crisi dovuta la fallimento segna il passaggio dal “bello” al “vero”, dalla poesia d’immaginazione alla filosofia e una poesia nutrita di pensiero.
Viaggi e opere
Nel 1822 riesce ad uscire da Recanati e si reca a Roma: gli ambienti letterari gli appaiono vuoti e meschini quindi decide di tornare a Recanati. Qui si dedica alla composizione delle Operette Morali. Nel 1825 riceve un incarico di collaborazione dall’editore milanese Stella. Tra il 1825 e il 1827 a Bologna stringe amicizia con la contessa Teresa Carniani-Malvezzi. Nel 1827 si reca a Firenze entra in rapporto con gli intellettuali de l’Antologia, stringe amicizia con Antonio Ranieri e conosce Fanny Targioni Tozzetti. Tra il 1827 e il 1828 si trasferisce a Pisa dove compone “grandi idilli”. Nel 1833 si trasferisce a Napoli in cui nasce “La ginestra”. Muore il 14 giugno 1837.
Relazioni familiari
• Pietro Giordani: trova in Giordani un ideale sostituto della figura paterna, un confidente a cui confessare i propri tormenti interiori.
• Fratello Carlo: a cui ama raccontare le proprie esperienze;
• Sorella Paolina: un’anima solidale per sensibilità e interessi, a cui confidare le proprie vicende più intime;
• Padre: rivelano la difficoltà del rapporto.
Progetto di romanzo
Nel 1819 Leopardi aveva concepito il disegno di un romanzo autobiografico, sul modello del Werther di Goethe e dell’Ortis di Foscolo. Voleva intitolarlo “Storia di un’anima” o “Vita di Silvio Sarno” Accumula vari appunti in cui annota ricordi di esperienze passate, sensazioni, immaginazioni.
Pessimismo leopardiano
Al centro della riflessione di Leopardi si pone subito un motivo pessimistico, l’infelicità dell’uomo (infelicità vicina all’illuminismo). Identifica la felicità con il piacere, sensibile e materiale: l’uomo non desidera un piacere, bensì il piacere che sia infinito per estensione e per durata. Pertanto, siccome nessuno dei piaceri particolari goduti dall’uomo può soddisfare questa esigenza nasce un senso di insoddisfazione perpetua, un vuoto incolmabile dell’anima. Da qui nasce l’infelicità dell’uomo, il senso della nullità di tutte le cose (sottolineando ciò che va inteso in senso puramente materiale). L’uomo è infelice per la sua stessa costituzione ma la natura ha voluto sin dalle origini offrire un rimedio all’uomo: l’immaginazione e le illusioni (per questo gli uomini primitivi che erano più vicini alla natura erano più felici)
Fasi del pessimismo
I fase (pessimismo individuale): Leopardi è l’unico che soffre , l’unico infelice.
II fase (Pessimismo storico): costruita sull’antitesi tra natura e ragione, tra antichi e moderni. Critica società contemporanea: il progresso della civiltà ha reso i moderni incapaci di azioni eroiche. Ne deriva un atteggiamento titanico: il poeta si erge solitario a sfidare il fato maligno.
III fase (Pessimismo cosmico): tutte le creature sono infelici e per liberarci da ciò è necessaria l’atarassia = il distacco imperturbabile dalla vita (chiudersi in se stessi)
Concezione della natura
La natura malvagia
Il male non è un semplice accidente ma rientra nel piano stesso della natura. Propone una concezione dualistica, natura benigna contro fato maligno per cercare di uscire da queste contraddizioni. Ma arriva alla soluzione delle contraddizioni rovesciando la sua concezione di natura. Leopardi concepisce la natura come meccanismo cieco, indifferente alla sorte delle sue creature. E’ una concezione non più finalistica ma meccanicistica e materialistica. La colpa dell’infelicità non è più dell’uomo stesso ma della natura (le vengono attribuite le caratteristiche che prima erano del fato)
L'infinito e l'immaginazione
Leopardi sostiene che particolari sensazioni visive e uditive inducono l’uomo a crearsi con l’immaginazione quell’infinito a cui aspira che è irraggiungibile perché la realtà offre solo piaceri finiti. L’infinito è la rappresentazione di uno dei momenti privilegiati in cui l’immaginazione strappa la mente dal reale (brutto) e la immerge nell’infinito. Nella poesia possiamo distinguere due momenti:
• Primo momento: sensazione visiva con l’impossibilità della visione data dalla siepe che impedisce allo sguardo di spingersi fino all’estremo orizzonte. Questo impedimento fa subentrare il fantastico. Il pensiero si costruisce l’idea di un infinito spaziale (sovraumani silenzi, profondissima quiete)
• Secondo momento: sensazione uditiva con lo stormire del vento tra le piante. La voce del vento viene paragonata al silenzio creato dall’immaginazione. Abbiamo l’idea di un infinito temporale in contrasto con epoche passate.
Tra i due momenti abbiamo l’io lirico che prova un senso di sgomento di fronte alle immagini interiori dell’infinito spaziale e che poi annega, si annulla totalmente sino a perdere la sua identità. Questa sensazione è piacevole. L’infinito è soggettivo, creato solo dall’immaginazione dell’uomo ed è evocato da sensazioni fisiche, con questo non si può escludere una componente mistica della poesia. I due momenti occupano entrambi sette versi e mezzo e il passaggio tra i due avviene all’ottavo verso . All’interno queste due sensazioni si suddividono ancora ciascuna in due parti simmetriche: nella prima abbiamo il punto di partenza dell’immaginazione dal dato reale; nella seconda l’allontanamento della realtà verso l’infinito. Su 15 versi abbiamo 10 enjambements.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fasi del pessimismo leopardiano?
- Come si sviluppa il pensiero di Leopardi riguardo alla natura?
- Qual è il ruolo dell'immaginazione secondo Leopardi?
- Quali sono le caratteristiche principali della poesia "L'infinito"?
- Quali relazioni personali influenzano Leopardi nella sua vita e opere?
Leopardi attraversa tre fasi di pessimismo: personale, storico e cosmico. Inizia con il pessimismo individuale, dove si sente l'unico infelice; passa al pessimismo storico, criticando la società moderna e il progresso; infine, arriva al pessimismo cosmico, dove tutte le creature sono infelici e la natura è vista come un meccanismo indifferente.
Leopardi inizialmente vede la natura come benigna, ma poi la concepisce come un meccanismo cieco e indifferente, responsabile dell'infelicità umana. La natura non è più finalistica ma meccanicistica e materialistica.
L'immaginazione è vista come un rimedio all'infelicità umana. Leopardi crede che l'immaginazione e le illusioni possano offrire un sollievo temporaneo, permettendo all'uomo di creare un infinito irraggiungibile che la realtà non può offrire.
"L'infinito" si divide in due momenti: uno visivo, dove l'ostacolo della siepe stimola l'immaginazione verso l'infinito spaziale, e uno uditivo, dove il vento evoca un infinito temporale. Entrambi i momenti sono caratterizzati da un senso di sgomento e piacere, con una forte componente soggettiva e mistica.
Leopardi trova un confidente in Pietro Giordani, un ideale sostituto paterno. Ha un rapporto affettuoso con il fratello Carlo e la sorella Paolina, mentre il rapporto con il padre è difficile. Queste relazioni influenzano profondamente la sua vita e le sue opere.

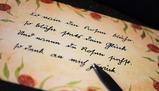





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo