Concetti Chiave
- Leopardi, in "L'infinito", esplora il contrasto tra finito e infinito, utilizzando una siepe come metafora di limite e opportunità per l'immaginazione.
- L'immaginazione del poeta supera il limite visivo, creando spazi infiniti e silenzi sovrumani, offrendo un rifugio dalla realtà sofferente.
- La struttura della poesia è caratterizzata da endecasillabi sciolti e un uso significativo di figure retoriche come enjambements, anastrofe, e chiasmo, che conferiscono musicalità.
- Le figure retoriche di significato, come la metafora e l'ossimoro, evidenziano lo smarrimento e la dolcezza dell'immersione nell'infinito.
- Leopardi afferma che l'ostacolo visivo stimola l'immaginazione, che si rifugia nell'infinito per alleviare le sofferenze della realtà.
Indice
Il Pensiero di Leopardi
È così che Leopardi esprime il suo pensiero nel noto componimento poetico intitolato “L’infinito”, scritto a Recanati nel 1918. Il testo mette a confronto le cose finite con ciò che di definito non ha nulla. Appunto l’infinito.
La Siepe e l'Immaginazione
La lirica nasce da una situazione concreta: l’autore si trova dietro a una siepe che costituisce un ostacolo un, limite, di guardare oltre e di arrivare col suo sguardo fino all’orizzonte. Ma contemporaneamente la siepe costituisce anche una opportunità per Leopardi. Egli riesce a passare da una visione diretta a una indiretta, e ciò che prima non riusciva a vedere, è in grado ora di immaginarlo. La sua immaginazione crea nella sua mente spazi infiniti, vaghi e indeterminati, dominati da un silenzio che oltrepassa i limiti umani. Ed egli prova una certa dolcezza nel naufragare in questa immensità, perché allevia la sua realtà sofferente.
Il Ritorno alla Realtà
Dopo i primi versi di introduzione in cui viene presentato un luogo familiare e definito, limitato dalla siepe (vv.1-2), il poeta sprofonda nel silenzio e nella vastità dell’infinito provando un certo sbigottimento (vv.5-8 ). Successivamente ritorna nella realtà a causa del rumore del vento che interrompe il silenzio (vv.8-9). Nella parte finale (vv.11-13) questo suono richiama l’idea dello scorrere del tempo e dell’eternità.
Linguaggio e Struttura Poetica
Leopardi utilizza solo una volta il passato remoto quando, nel primo verso, egli presenta il contesto reale che lo circonda: “Sempre caro mi fu quest’ermo colle”. Egli fa utilizzo del presente per parlare di cose eterne e universali, e quindi vicine a ogni uomo. Anche il ricorso ai dimostrativi “questo” e “quello” assume particolare rilievo. Il poeta utilizza questo quando vuole ricollegarsi a una realtà che sente vicina, quello quando vuole alludere a una dimensione surreale. L’utilizzo finale di questo riferito all’infinito evidenzia come il poeta abbia fatto ormai propria l’esperienza dell’assoluto.
La lirica è costituita da 15 endecasillabi sciolti, cioè versi privi di rima di 15 sillabe ciascuno, legati da numerosi enjambements. Quest’ultimi, insieme all’alternarsi di parole brevi ad altre più lunghe, donano musicalità e ritmo al testo.
Figure Retoriche e Significato
Sul piano lessicale Leopardi alterna termini arcaici, ermo (solidale), interminato (infinito), sovrumano (al di là del limite umano), ad altri di uso più quotidiano. Numerose sono le figure di ordine come l’anastrofe. Leopardi ne fa utilizzo in “interminati/spazi, sovrumani silenzi e profondissima quiete” per mettere in evidenzia gli aggettivi interminati, sovrumani e profondissima che rimandano a idee vaste e indefinite. Tra le altre figure di ordine riconosciamo l’iperbato nei vv.4-7, dove il verbo “fingo” è messo alla fine. Il poeta fa ricorso anche al chiasmo nei versi finali realizzato posizionando all’estremità contrapposte dei vv.14-15 le parole immensità e mare che appartengono al campo semantico dell’infinito. Infine, nel componimento si è fatto utilizzo anche del polisindeto nei vv.11-13, dove la congiunzione e viene ripetuta più volte.
Parlando invece delle figure retoriche di significato, riconosciamo la metafora presente ai vv.13-14, “tra questa immensità s’annega il pensier mio”, che comunica come il pensiero dell’autore si perde in questa vastità, oppure l’ossimoro del v.15, “il naufragar m’è dolce”. In quest’ultimo caso il verbo naufragar, appartenente alla sfera della morte, viene accostato ad un aggettivo totalmente contrapposto, dolce.
Concetto di Immaginazione
Leopardi in questa lirica ribadisce un concetto che spiega nello Zibaldone per cui l’anima immagina quello che non vede perché il suo sguardo viene ostacolato, ma se la sua vista si estendesse da per tutto ciò non potrebbe accadere, perché il reale escluderebbe l’immaginario. Io non sono d’accordo con il pensiero leopardiano. Sostengo, infatti, che l’anima non immagina perché vuole estendere il suo controllo oltre ciò la ostacola, ma piuttosto perché vuole evadere da qualcosa che la turba, la stressa o le crea frustrazione. L’atto dell’immaginazione ha come scopo quello di alleviare le sofferenze, le paure, o anche di evitare i problemi reali facendoci rifugiare in qualche cosa a noi familiare. Quindi immaginare non significa tanto guardare oltre ciò che ci sta davanti, ma piuttosto dimenticare ciò che in qualche modo ci rende infelici.
Domande da interrogazione
- Qual è il tema centrale del componimento "L'infinito" di Leopardi?
- Come viene utilizzata la siepe nel componimento di Leopardi?
- In che modo Leopardi utilizza il linguaggio e la struttura poetica per esprimere il suo pensiero?
- Quali figure retoriche di significato sono presenti nel componimento?
- Qual è il concetto di immaginazione secondo Leopardi?
Il tema centrale è il confronto tra le cose finite e l'infinito, esplorato attraverso l'immaginazione che supera i limiti fisici rappresentati dalla siepe.
La siepe rappresenta un ostacolo fisico che stimola l'immaginazione di Leopardi, permettendogli di concepire spazi infiniti e silenzi sovrumani.
Leopardi utilizza il presente per parlare di concetti eterni e universali, e impiega figure retoriche come l'anastrofe e il chiasmo per enfatizzare l'immensità e l'infinito.
Sono presenti la metafora, come in "tra questa immensità s’annega il pensier mio", e l'ossimoro, come in "il naufragar m’è dolce", che esprimono la complessità dei sentimenti del poeta.
Leopardi sostiene che l'immaginazione nasce dall'ostacolo alla vista fisica, permettendo all'anima di concepire ciò che non può vedere, come un modo per alleviare le sofferenze e le frustrazioni della realtà.

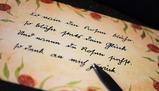






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo