Concetti Chiave
- Il Decameron di Boccaccio è una raccolta di cento novelle ambientate durante la peste del 1348, narrate da dieci giovani rifugiatisi in campagna per sfuggire al contagio.
- Boccaccio utilizza un linguaggio ricco e variegato, combinando influenze del fiorentino illustre, latinismi e francesismi per adattarsi ai diversi contesti sociali dei personaggi.
- La fortuna è vista come una forza capricciosa e imprevedibile che può influenzare la vita umana, mentre l'industria rappresenta la capacità dell'uomo di dominare la realtà.
- L'amore è un tema centrale e viene esplorato in modo laico e naturale, spesso con un approccio erotico che riflette la varietà delle classi sociali rappresentate nelle novelle.
- Boccaccio esalta l'iniziativa individuale e celebra la classe media mercantile, pur esprimendo nostalgia per i valori cavallereschi della cortesia.
Il Decameron è una raccolta di cento novelle che hanno una struttura unitaria. Fu scritto probabilmente tra il 1348 e il 1353. L’autore racconta che, durante la peste che devastò Firenze nel 1348, una brigata di sette fanciulle e tre giovani di elevata condizione sociale, per cercare scampo dal contagio si ritira nella campagna. Lì i giovani passano il tempo tra canti, balli e giochi. Ogni giorno viene eletto un re che si occupa di scegliere un tema per la composizione delle novelle che ognuno deve raccontare. A Dioneo viene concesso di non rispettare un tema generale, mentre la prima e la nona giornata hanno un tema libero.
Indice
Struttura e Temi del Decameron
Tra le diverse novelle ci sono i commenti degli uditori e ogni giornata è chiusa da una conclusione in cui è inserita una ballata. I personaggi non hanno un carattere ben definito (tranne Dioneo che è malizioso e irriverente). I nomi dei personaggi sono ispirati dalle precedenti composizioni di Boccaccio (Filostrato, Panfilo e Fiammetta), da personaggi letterari (Laura di Petrarca, Elissa cioè la Didone virginiana) o dalla mitologia (Dioneo che allude alla dea Venere). Il titolo viene dal greco e vuol dire “novelle di 10 giorni”.
L’elenco degli argomenti è detto Rubriche perché nei manoscritti medievali era in uso scrivere i titoli dei capitoli in rosso (rubrum, “rosso” dal latino).
Pubblico e Stile del Decameron
Il libro si apre con il Proemio. Dal Proemio si può intuire che il pubblico a cui è rivolta l’opera è le donne, più precisamente le donne che amano. Il pubblico non è composto da letterati in quanto le donne avevano un livello d’istruzione più basso degli uomini, anche se lo stile era raffinato ed elegante.
Boccaccio sosteneva che le donne hanno una facoltà minore rispetto agli uomini di distrarsi dalle pene d’amore, in quanto sono precluse dalla caccia, dal commerciare e da tutte le attività che possono occupare l’esistenza dell’uomo. Grazie alla lettura le donne possono trovare diletto e utili suggerimenti.
Amore e Fortuna nel Decameron
Un tema ricorrente nel Decameron è il motivo amoroso. Si delinea dunque uno stile laico e mondano lontano dai testi medievali quali anche sono la Commedia e il Decameron.
L’introduzione alla prima giornata si apre con una lunga descrizione della peste. Il contesto storico aiuta a far comprende ai lettori che anche se l’uomo viene sfidato dalla natura, esso riuscirà sempre a trovare un ordine umano alla realtà grazie all’intelligenza.
Alla realistica azione del concreto si affianca un bisogno di idealizzazione.
Boccaccio è attento alle basi materiali ed economiche della realtà. Non ci sono più tracce della condanna dell’avidità, ma anzi individua l’“industria” come valore. L’industria è quella volontà dell’uomo di andare contro la Fortuna. È quella qualità grazie a cui l’uomo può dominazione la realtà oggettiva e piegarla ai propri fini. Boccaccio esalta l’iniziativa dell’individuo, celebrando così la classe media borghese mercantile.
Boccaccio sente la nostalgia per il mondo cavalleresco, ispirato al valore della cortesia. Il poeta vorrebbe anzi una fusione tra i due ordini di valori, tra la “cortesia” e l’“industria”.
Il borghese si fa da sé, dunque sale nella scala sociale grazie alla sua intelligenza e alle sue abilità. Una volta che il mercante borghese ha raggiunto un livello ormai aristocratico, chiude ogni possibilità di processo dinamico. Dunque il processo dinamico della borghesia cittadina ha dei limiti.
La fortuna è l’idea che la realtà sia dominata da una forza capricciosa e imprevedibile. Essa è un complesso accidentale di forze, non regolato da una forza superiore. Questa è ormai una visione laica che però non esclude l’esistenza di Dio. Essa può manifestarsi attraverso dei fenomeni naturali oppure può essere la conseguenza di azioni umane. La fortuna può essere avversa o favorevole ed è l’antagonista dell’“industria”.
Il tema centrale di molte novelle di Boccaccio è l’amore visto da un punto di vista più laico e naturale. Boccaccio pensa che è assurdo e vano cercare di reprimere l’amore. L’amore riesce ad elevare individui rozzi a livello più alti. Il tema erotico è molto presente nelle novelle di Boccaccio, infatti è stato per secoli considerato osceno. La sessualità è sempre stata contemplata da Boccaccio come qualcosa di priva di malizia in quanto è naturale.
Personaggi e Ambientazioni
Boccaccio nelle sue novelle include persone di tutte le caste sociali (re, grandi feudatari, alto e baso clero) ma la presenza più folta riguarda i ceti della moderna civiltà urbana (mercanti, banchieri, borghesi,ecc…). Vengono elencati anche tutti i luoghi, ma quello prediletto è il mare che rappresenta la Fortuna in quanto è capriccioso e imprevedibile. Un altro luogo spesso ricorrente è la città, che spesso è rappresentata da Firenze. La città è un luogo aperto e disponibile a tutte le esperienze.
Struttura Narrativa e Stile
Boccaccio pensa un ordine architettonico ben preciso per le sue novelle, non le dispone casualmente. Come ad esempio il rapporto che lega la prima novella del libro, dedicata al peggior uomo mai vissuto, e l’ultima dedicata alla sovraumana virtù.
Boccaccio non ha il gusto per una minuta analisi psicologica, non si concentra in ampie introspezioni psicologiche dei personaggi, solo di Dioneo possiamo comprendere il carattere malizioso.
La novella è un genere che ha per fine l’intrattenimento, l’evasione e il piacere che nasce dalla lettura. Il pubblico non è formato da letterati. La novella è uno strumento espressivo più duttile. La novella può essere avventurosa e può avere un impianto molto scenico (scene vivide, animate dal dialogo), a volte il dialogo è fatto da battute rapide e lo scambio di battute presenta una raffinata eloquenza. Possono alternarsi delle narrazioni di tipo riassuntivo in qui il tempo del discorso è minore di quello della storia (TD
Il discorso “autoriale” è il discorso dell’autore e dei narratori ed ha uno stile alto e sostenuto. I periodi sono molto lunghi e vi sono presenti inversioni, collocamenti del verbo al fondo del periodo, costruzioni del verbo alla latina (all’infinito), chiasmi, anafore e dittologie. Insieme al gusto per il modello della prosa latina, Boccaccio ama anche realizzare delle clausole ritmiche (parti finali del periodo disposte in modo da susseguirsi di sillabe lunghe e brevi in modo da creare un ritmo armonioso). Anche dal punto di vista lessicale il Decameron è ricco di influenze del fiorentino illustre e letterario, si possono trovare latinismi, francesismi, termini tecnici e anche popolareschi. Ciò accade perché la lingua si adatta alle diverse situazioni sociali dei personaggi.
Domande da interrogazione
- Qual è la struttura del Decameron e come si sviluppano le giornate?
- A quale pubblico è rivolto il Decameron e quale stile adotta Boccaccio?
- Quali sono i temi principali trattati nel Decameron?
- Come sono rappresentati i personaggi e le ambientazioni nel Decameron?
- Qual è lo stile narrativo adottato da Boccaccio nel Decameron?
Il Decameron è composto da cento novelle raccontate in dieci giorni da una brigata di sette fanciulle e tre giovani. Ogni giorno viene eletto un re che sceglie il tema delle novelle, tranne Dioneo che può raccontare liberamente. La prima e la nona giornata hanno un tema libero.
Il Decameron è rivolto principalmente alle donne, considerate meno distratte dalle pene d'amore rispetto agli uomini. Lo stile è raffinato ed elegante, nonostante il pubblico non sia composto da letterati.
I temi principali includono l'amore e la fortuna. L'amore è visto in modo laico e naturale, mentre la fortuna è una forza capricciosa e imprevedibile che si contrappone all'industria umana.
I personaggi provengono da tutte le classi sociali, con una forte presenza della borghesia urbana. Le ambientazioni includono il mare, simbolo della fortuna, e la città, spesso Firenze, aperta a tutte le esperienze.
Boccaccio adotta uno stile narrativo architettonico e non casuale, con un gusto per la prosa latina e un linguaggio che si adatta alle diverse situazioni sociali. Le novelle sono avventurose e animate da dialoghi vivaci e raffinati.


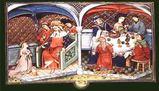
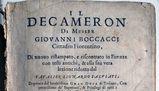





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo