Concetti Chiave
- Il periodo politico della Destra storica (1861-1871) si concentrò sull'unificazione territoriale, affrontando questioni come l'annessione di Venezia e Roma, con interventi di figure come Garibaldi e accordi internazionali.
- Durante le vicissitudini legate alla Guerra di Indipendenza (1871-1876), l'Italia si alleò con la Prussia contro l'Austria, ottenendo il Veneto ma non il Trentino, mentre il governo italiano tentò di ridurre l'influenza della Chiesa.
- L'economia italiana dell'epoca era prevalentemente agricola, con un focus sull'unificazione legislativa e lo sviluppo di infrastrutture come il sistema ferroviario per consolidare il mercato interno.
- La fase della Sinistra Storica (1876-1900) introdusse riforme come la riforma elettorale e l'istruzione obbligatoria, ma con risultati limitati, mentre il trasformismo politico caratterizzò il periodo, con divisioni e compromessi interni.
- Con l'ascesa del Partito Socialista Italiano nel 1892 e il cambiamento delle organizzazioni operaie, la politica italiana vide un'evoluzione verso il socialismo, influenzata dallo sviluppo industriale e da eventi come lo scandalo della Banca Romana.
Questo appunto di Storia Moderna riguarda una descrizione del processo di unificazione italiano e le sue conseguenze, considerando anche le trasformazioni e i cambiamenti politici.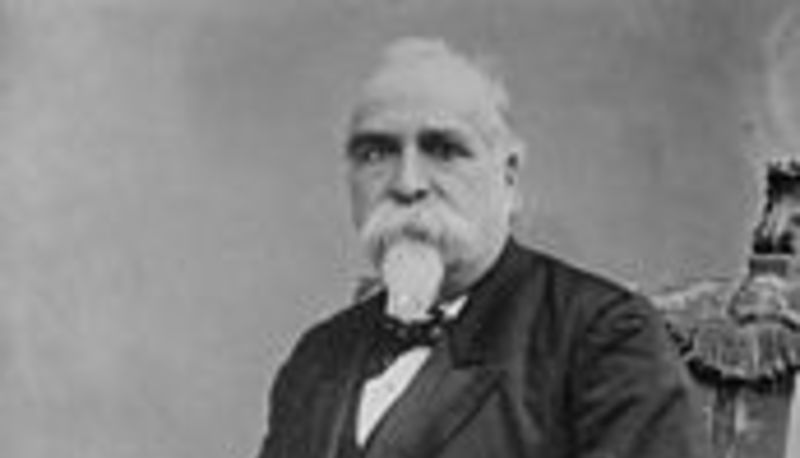
Indice
1861 – 1871: il periodo politico della Destra storica
Il giovane Regno d’Italia appena nato, si trovò davanti a questioni risorgimentali molto importanti, tra le quali primeggiava il compimento dell’unità territoriale totale. Il Regno italiano non poteva ancora contare su:- Venezia, repubblica indipendente
- Roma, che sottostava al potere del Papato
1871 – 1876: le vicissitudini legate alla Guerra di Indipendenza
Allo scoppio della guerra fra Prussia ed Austria, l’Italia si trovò al fianco della Prussia. L’annessione di Veneto e Trentino fu comunque possibile solo grazie alle vittorie dei nostri alleati, in quanto il nostro esercito subì gravi sconfitte a Custoza e Lissa, mentre i nostri alleati prevalsero a Sadowa. Con la pace di Vienna il Veneto passò all’Italia, mentre il Trentino rimase sotto il controllo austriaco. Il governo italiano cercò adesso di strappare parte del potere della Chiesa con due manovre:- legge delle garanzie, legge che riorganizzava la vita della Chiesa dopo la fine del suo potere,
- non expedit, impedì ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica.
Si cercò di creare un mercato interno stabile attraverso un nuovo sistema ferroviario che raggiunse i 2000 chilometri, concentrati però quasi tutti tra Piemonte e Lombardia.
L’Italia si trovò quindi ad imboccare tre strade per procurarsi il denaro necessario, ovvero l’aumento dell’imposizione fiscale, l’alienazione del patrimonio pubblico ed il ricorso al prestito. Il secondo grave problema del Regno d’Italia fu quello del Mezzogiorno: questo si presentava non fertile, arretrato economicamente, gravato da antichi rancori, da violenti e mai risolti contrasti sociali. All’indomani della caduta dei Borbone, si era diffuso il fenomeno del brigantaggio, capeggiato da elementi sbandati del vecchio esercito napoletano. Il governo attuò manovre strettamente militari; nel 1863, una legge affidò ai tribunali militari il giudizio dei briganti. Politicamente, il Regno italiano ereditava del Piemonte anche un sistema elettorale sul modello di quello francese di Orleans (1830), modello fortemente censitario; avevano diritto al voto tutti i cittadini di almeno 25 anni che sapevano leggere e scrivere. Per opporsi ad un governo in stile sabaudo in tutto il Regno, Farini e Minghetti proposero le autonomie locali, che tendeva a riconoscere un’ampia autonomia amministrativa a Comuni e Province. Si preferì estendere in maniera definitiva a tutto il regno l’ordinamento amministrativo piemontese.
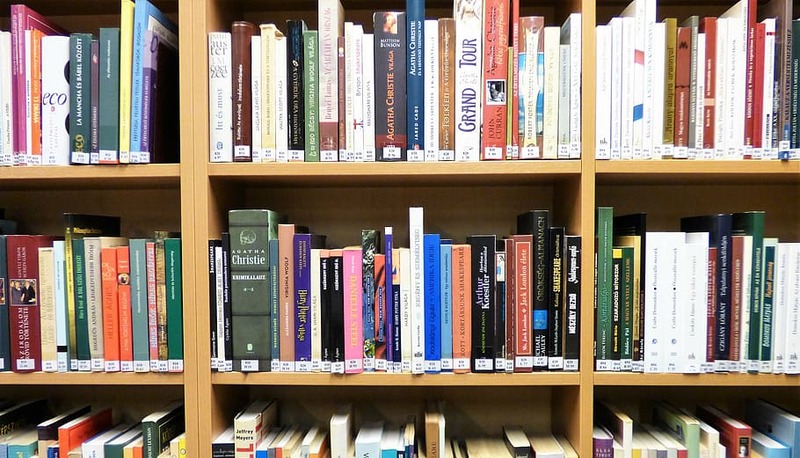
1876 – 1900: la fase della Sinistra Storica
Nel 1876 il ministero Minghetti, l’ultimo governo della Destra, venne sostituito dal ministero Depretis della Sinistra storica. La Sinistra iniziò con un programma di significative riforme, come:- la riforma elettorale,
- il decentramento amministrativo,
- l’abolizione della tassa sul macinato,
- l’istruzione elementare obbligatoria.
Fin dai primi governi Depretis , si era venuta formando un’aggregazione governativa , all’interno della quale si creavano divisioni e ricomposizioni per contrasti di fazione : questa caratteristica della vita politica italiana portò al termine di trasformismo .
Dopo un breve periodo di governo di Di Rudinì, l’incarico fu ricoperto da Giolitti; la sua linea politica era radicalmente diversa da quella di Crispi. Giolitti, infatti, era contrario al militarismo e alla politica di potenza; si proponeva poi di controllare rigorosamente le finanze statali e di impiegare le risorse del Paese per elevare il tenore di vita dei cittadini.
In quel periodo ci furono diversi moti popolari soprattutto in Sicilia; Giolitti decise di non reprimere con la forza queste agitazioni. Per questo motivo e per l’esplosione dello scandalo della Banca Romana, fu costretto a dimettersi: era, infatti, accusato di speculazioni finanziarie illecite con uomini politici. Esistevano già da tempo società di mutuo soccorso che svolgevano attività di tipo assistenziale e organizzazioni anarchiche che puntavano più alle insurrezioni che agli scioperi. Con lo sviluppo industriale cambiarono anche le organizzazioni operaie: si diffondeva il socialismo.
Dal 1891 nacque il Partito dei lavoratori italiani che nel 1892 diverrà il Partito Socialista Italiano.
Per ulteriori informazioni sugli eventi successivi all'unificazione italiana, vedi anche qua
Domande da interrogazione
- Quali furono le principali sfide affrontate dal Regno d'Italia appena unificato tra il 1861 e il 1871?
- Come si è evoluta la situazione politica italiana tra il 1871 e il 1876 durante le guerre di indipendenza?
- Quali furono le riforme principali introdotte dalla Sinistra storica dopo il 1876?
- In che modo la vita politica italiana fu caratterizzata durante il periodo della Sinistra storica?
- Quali furono le conseguenze della politica di Giolitti e quali eventi portarono alle sue dimissioni?
Il Regno d'Italia dovette affrontare questioni risorgimentali come il completamento dell'unità territoriale, con Venezia e Roma ancora fuori dal controllo italiano. Inoltre, ci furono tensioni politiche interne e conflitti con Napoleone III.
L'Italia si alleò con la Prussia contro l'Austria, ottenendo il Veneto grazie alle vittorie prussiane. Internamente, il governo cercò di ridurre il potere della Chiesa e affrontò problemi economici e sociali, come il brigantaggio nel Mezzogiorno.
La Sinistra storica introdusse riforme come la riforma elettorale, il decentramento amministrativo, l'abolizione della tassa sul macinato e l'istruzione elementare obbligatoria, anche se con risultati modesti.
La vita politica fu segnata da mediazioni e compromessi, con una progressiva fusione tra Destra e Sinistra storiche, portando al fenomeno del trasformismo e a una politica di divisioni e ricomposizioni interne.
Giolitti si oppose al militarismo e cercò di migliorare il tenore di vita dei cittadini, ma fu costretto a dimettersi a causa dei moti popolari in Sicilia e dello scandalo della Banca Romana, che lo coinvolse in accuse di speculazioni finanziarie illecite.

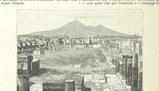





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo