Concetti Chiave
- Jan Van Eyck's painting "I coniugi Arnolfini" is known for its hyperrealistic detail, showcasing the texture of materials like wood, fabrics, and silverware.
- The artwork depicts a marriage vow, possibly misunderstood identities, with Van Eyck potentially portraying himself and his wife, rather than Giovanni Arnolfini and Giovanna.
- The painting is a hallmark of Flemish art, emphasizing private, non-religious subjects, with intricate details reflecting wealth and cultural diversity.
- Symbolic elements like oranges, a cherry tree, and Santa Margherita's image convey themes of fertility, wealth, and religious respect.
- Van Eyck's use of oil painting and multiple vanishing points distinguishes his work, providing a sense of realism and inviting the viewer into the scene.
In questo appunto di Storia dell'Arte si descrive il dipinto di Jan Van Eyck: I coniugi Arnolfini, con riferimento alla pittura fiamminga e le sue regole.
Indice
I coniugi Arnolfini - Jan Van Eyck
L'autore di I coniugi Arnolfini è Jan Van Eyck. L'opera fu mostrata nel 1434 a Londra, dove risiede tutt'ora. Le dimensioni del dipinto sono 82x60 cm.Il dipinto raffigura una coppia di sposi che si scambiano con la mano la promessa di matrimonio, com'era l'usanza dell'epoca: l'ipotesi finora ritenuta più probabile era che si trattasse del mercante lucchese Giovanni Arnolfini, stabilitosi a Bruges, nelle Fiandre, nel 1420, e della moglie Giovanna. Ma uno studio recente sembra confermare con prove convincenti che si tratti di Van Eyck stesso, il quale si auto-ritrae con la moglie Margareta e si firma, anche sopra lo specchio convesso in fondo alla parete. "johannes de Eyck fuit hic 1434" cioè "Jan van Eyck è stato qui nel 1434". C'è chi pensa che la giovane sia incinta, e se così fosse verrebbe confermata la tesi che non si tratta dei coniugi Arnolfini, che non ebbero figli, a differenza dal Van Eyck. Nella stanza sono presenti i due sposi, che occupano la maggior parte del quadro. Gli oggetti raffigurati rendono il quadro iperrealista: creano un'illusione sulle superfici.
Possiamo percepire la materia di cui sono composti, del legno, dei tessuti, dell'argenteria. Si nota in particolare uno specchio. All'interno dello specchio vediamo la presenza, di spalle, dei due coniugi e altre due figure, una è l'artista, l'altro rappresenta le persone, come noi, che stanno guardando il quadro. C'è un riferimento alla Bibbia, quando Dio dice a Mosè di togliere i sandali in suo cospetto. La moglie sembra incita perché ha una postura tenuta dalle donne dell'epoca per dare l'idea di fertilità. Nessun oggetto è messo a caso, tutto ha significato.
Considerazioni su I coniugi Arnolfini
L'opera è uno dei massimi esempi di pittura fiamminga. Complesso ed enigmatico, anche per via delle diverse ipotesi sull'identità dei soggetti del ritratto, il dipinto appare inusuale perché rappresenta personaggi non inventati e soprattutto privati, mettendo da parte le solite scene religiose. Nonostante ciò l'azione è quasi sicuramente quella del matrimonio, o meglio del giuramento che anticipa l'arrivo del sacerdote, e il gesto dell'uomo che sembra di gratitudine o benevolenza lo dimostra, così come la donna che porge la mano destra e con l'altra si tocca il ventre. Gli abbigliamenti di entrambi dimostrano ricchezza e cerimoniosità, sono tipicamente invernali e ricercati: lui ha una tunica nera con un mantello che la copre di pelliccia di marmotta e il cappello è enorme e di ottima fattura, in feltro. Lei invece ha un meraviglioso abito verde (simbolo di fertilità) con pelliccia di ermellino. I gioielli non passano inosservati: una cintura d'oro, vari anelli e una collana anch'essa in oro. Entrambi sono scalzi (per segnalare il rispetto della sacralità del luogo) ma hanno vicino due paia di zoccoli che servivano per proteggere le scarpe di ottima fattura quando si usciva all'esterno. Ma anche l'oggettistica delle stanze dimostra che siamo di fronte a una stanza inusuale e piuttosto preziosa: basti guardare il vetro alle finestre, cosa rarissima all'epoca. Ci sono poi il tappeto, dono che sicuramente proveniva dalla Turchia, la pelliccia dalla Russia e altri oggetti presi da diverse parti d'Europa (Italia, Inghilterra, Francia). Per questo si pensa che il soggetto uomo fosse un mercante che intratteneva i clienti da ogni parte del mondo. La passione per il dettaglio, che si nota in ogni oggetto contenuta in questa stanza, fanno di Van Eyck il caposcuola dei pittori fiamminghi. L'utilizzo della pittura ad olio permise all'artista una maggiore manipolazione e attenzione al particolare, rispetto alla tempera o all'affresco.La camera è una camera matrimoniale ma in realtà anche un salone dove accogliere gli ospiti, specie quando la donna ha appena partorito e mostra il suo pargolo ai familiari. I tessuti rossi simboleggiano la passione e creano un bel contrasto con il verde della fertilità della donna. Sulla testiera del letto c'è l'immagine di Santa Margherita, padrona dei partorienti.
Vicino alle finestre e alle tende ci sono delle arance, simbolo di ricchezza anche queste perché provenivano sicuramente da regioni del Sud ma soprattutto richiamano alla storia del peccato originale di Adamo ed Eva perché avevano lo stesso significato delle mele: un invito a non cedere alla peccaminosità, a celebrare la sacralità e il rispetto per l'evento matrimoniale. Dalla finestra sempre si intravede un ciliegio, simbolo della primavera che stona rispetto all'abbigliamento utilizzato dai coniugi. Probabilmente l'artista rimase fedele al significato del dipinto e non alla sua fedeltà.
Particolare attenzione merita lo specchietto di 5,5 cm che viene rappresentato da Van Eyck con particolare minuziosità perché la sua cornice presenta in ordine i dieci episodi della Passione di Cristo: l'Orazione nell'orto, la Cattura di Cristo, il Giudizio di Pilato, la Flagellazione di Cristo, la Salita al Calvario, la Crocefissione (in alto al centro), la Deposizione, il Compianto, la Discesa al Limbo e infine la Resurrezione.
Inoltre, tramite lo specchio, l'autore dell'opera garantisce all'osservatore due punti di vista differenti: il primo è quello che vediamo ovvero i due coniugi, il secondo è quello che vediamo all'interno dello specchio che ritrae personaggi non visibili immediatamente. Oltre a ciò, la luce che emana lo specchio, insieme alle finestre e ad altri oggetti luminosi, permette all'artista di esprimere al meglio le sue capacità della pittura fiamminga e del Rinascimento.
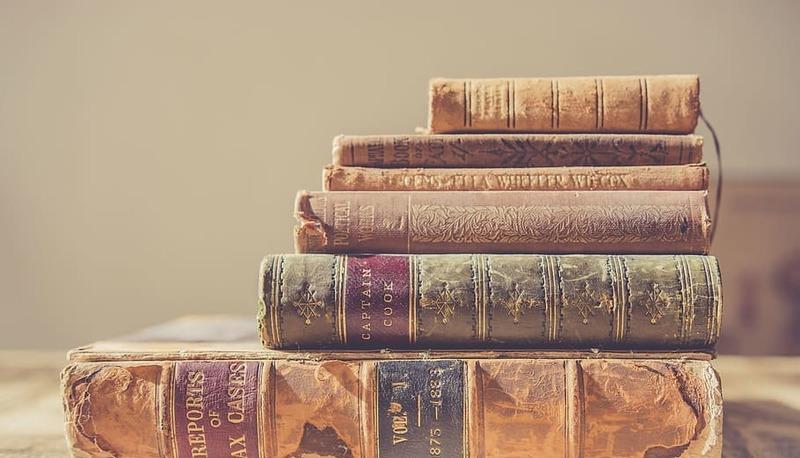
Lo stile dei coniugi Arnolfini
Per quanto riguarda lo stile, come già indicato sopra, l'attenzione verso il dettaglio e la presenza di una certa ricchezza emanata dall'oggettistica della camera, insieme alla pittura ad olio che permette maggiore cura dei particolari, sono tipici elementi della pittura fiamminga.L'uso di più punti di fuga (al contrario di quanto si faceva nel Rinascimento fiorentino e in particolare nei dipinti degli italiani in cui c'era un solo punto di fuga nello spazio e ciò garantiva struttura e ordine totali) permettono all'osservatore di sentirsi parte del dipinto e la linea orizzontale alta fa sembrare l'ambiente maggiormente accogliente e confortevole, nonostante la luce sia fredda e la scena piuttosto cerimoniosa.
Anche quest'ultimo punto è parte integrante della pittura dei fiamminghi: la rigidità dei gesti, delle espressioni umane e dell'aria che si respira osservandoli è tipica della scuola fiamminga.
Per ulteriori approfondimenti sui Coniugi Arnolfini vedi anche qua
Domande da interrogazione
- Chi è l'autore del dipinto "I coniugi Arnolfini" e dove si trova attualmente?
- Quali sono le ipotesi sull'identità dei soggetti nel dipinto?
- Quali elementi del dipinto indicano la ricchezza e la cerimoniosità dei soggetti?
- Qual è il significato simbolico degli oggetti presenti nella stanza?
- Come viene utilizzato lo specchio nel dipinto e quale significato ha?
L'autore del dipinto "I coniugi Arnolfini" è Jan Van Eyck, e l'opera si trova attualmente a Londra.
Le ipotesi principali sono che i soggetti siano il mercante Giovanni Arnolfini e sua moglie Giovanna, oppure Jan Van Eyck stesso con sua moglie Margareta.
Gli abbigliamenti invernali e ricercati, i gioielli, e gli oggetti preziosi nella stanza, come il vetro alle finestre e il tappeto turco, indicano la ricchezza e la cerimoniosità dei soggetti.
Gli oggetti, come le arance e il ciliegio, simboleggiano la ricchezza e la sacralità del matrimonio, mentre i tessuti rossi e verdi rappresentano la passione e la fertilità.
Lo specchio offre due punti di vista differenti e rappresenta episodi della Passione di Cristo, mostrando la maestria di Van Eyck nella pittura fiamminga.








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo