Concetti Chiave
- Il Settecento è caratterizzato dall'Illuminismo, un movimento culturale che promuove la ragione e i diritti naturali, e vede il declino della Spagna a favore di Inghilterra e Austria.
- In Italia, il secolo è segnato da una divisione politica e geografica, con i Borbone al sud e l'influenza degli Asburgo al nord, mentre l'Illuminismo si manifesta diversamente tra nord e sud.
- Significativi progressi igienico-sanitari includono il vaccino del vaiolo e l'editto di Saint Cloud in Francia, che migliorarono le condizioni di vita e ridussero le epidemie.
- L'economia italiana è arretrata, con una discrepanza tra il nord industrializzato sotto gli Asburgo e il sud dominato da latifondisti, portando a problemi come la questione meridionale.
- Il melodramma evolve con Metastasio, che cerca di dare maggiore importanza al libretto, mentre l'opera buffa e la commedia dell'arte di Goldoni introducono personaggi borghesi e comici.
Indice
Il Settecento e l'Illuminismo
Quando si parla di Settecento, si pensa all’Illuminismo, il fenomeno culturale più rilevante del secolo (epoca dei lumi). Il Settecento è stato secolo di grandi guerre, e si assiste al declino della potenza spagnola, mentre Inghilterra e Austria hanno il predominio. Nelle varie nazioni si rafforzano i poteri del re (ancienne régime), ritornando alla concezione della monarchia di origine divina. I re si avvalevano dell’aiuto di uomini di fiducia (a discapito di nobili ed aristocratici, che finirono fuori dalla vita politica), dando vita al concetto di burocrazia. Le classi umili, come al solito, restarono nella loro condizione di povertà. Con l’affermazione di queste grandi monarchie, si diffusero i criteri di Giusnaturalismo (si ribadisce l’esistenza diritti naturali, come l’uguaglianza, la vita…) e Giurisdizionalismo (si affermava la precedenza della legislazione civile su quella ecclesiastica, questo significava che anche il clero dovesse sottostare alle giurisdizioni dei laici).
Situazione politica in Italia
L’Italia aveva una situazione pressoché uguale al Seicento, eccetto per le questioni dei conquistatori: al nord gli spagnoli furono sostituiti dagli Asburgo, il centro rimase sotto il controllo dello Stato Pontificio, Genova e Venezia (ex repubbliche marinare) restarono separate, e il sud inizialmente passò nelle mani degli austriaci, ma poi si imposero i Borbone (spagnoli) in Sicilia e Campania. Il regno di Sardegna era in mano ai Savoia (piemontesi), che presero il titolo di re di Sardegna. Il fenomeno dell’Illuminismo in Italia si divide in Illuminismo del Nord (più vicino a quello europeo) e di Napoli (teso a studi di carattere giuridico). Lo splendore di Napoli in campo giuridico rimase isolato e destinato a morire. Nel 1700 l’Italia era ancora frazionata politicamente e geograficamente; solo alla fine del secolo inizieranno a manifestarsi i primi intenti di unità.
Miglioramenti igienico-sanitari e agricoli
La vita in Europa migliora, in quanto si impongono delle leggi/norme di carattere igienico-sanitario (in passato la popolazione era decimata dalle epidemie). I francesi, ad esempio, con l’editto di Saint Cloud, imposero che la sepoltura dei defunti dovesse avvenire fuori dalle mura cittadine, e che i pavimenti delle chiese non fossero pieni di morti. Nel Settecento si poneva il problema scorrimento delle acque nere e bianche (si ipotizzava un sistema di canalizzazioni); si scoprì il vaccino del vaiolo. Parini, scrittore milanese, scrisse un’ode ai vaccini. Accanto alle migliorate condizioni igienico-sanitarie, in Inghilterra nacque la rivoluzione agricola, che consentì una maggior produzione di beni alimentari, facendo muovere il commercio (i capitali serviranno poi a finanziare la Rivoluzione Industriale); in questo periodo si assiste ad un vero e proprio spopolamento delle campagne e alla nascita del proletariato urbano.
Economia italiana e questione meridionale
L’Italia, dal punto di vista economico, era in una condizione di estrema arretratezza, soprattutto al Sud, che era ancora in mano a pochi latifondisti spagnoli che facevano lavorare i contadini. Nei primi decenni dell’Ottocento il Sud non poté più competere con gli altri paesi, e così venne abbandonato a sé stesso. Nell’Italia centrale si diffuse la pratica della mezzadria (i proprietari terrieri danno la cura delle terre a dei mezzadri, che si prendono il 50% della produzione). Un caso a sé è il Nord-Est (Lombardia e Veneto), dominato dagli austriaci (Maria Teresa e Giuseppe d’Austria), che diedero vita a riforme di carattere industriale, con le prime fabbriche e industrie, decretando il divario con il Sud. L’inchiesta di Franchetti e Sonnino (nella prima metà dell’Ottocento) fece presente al governo italiano la questione meridionale; lo stato rispose con una politica di sussidi e con la fondazione della Cassa del Mezzogiorno, così iniziarono a nascere le mafie e il fenomeno dell’immigrazione, problemi presenti fino a oggi.
Arcadia e la poetica barocca
Prima di parlare di Illuminismo, bisogna parlare di Arcadia. Dal punto di vista culturale in quel periodo predominava la poetica barocca, tesa alla meraviglia. Gabriello Chiabrera era un antimarinista. Nel Settecento si vede l’affermazione delle accademie; tra queste, che si opponevano al Barocco, va ricordata l’Arcadia, che si impose di superare il cattivo gusto del Barocco. È un’accademia romana, che si rifà alla regione della Grecia, alla quale si rifanno artisti come Virgilio e Teocrito (inventore del genere bucolico). L’Arcadia aveva riuniti i poeti che prendevano il nome di pastori; il loro simbolo era il flauto di Pan. Vennero fondate altre succursali dell’Arcadia, chiamate colonie. Furono particolarmente attivi nel mondo dell’Arcadia Mario Crescimbeni e Vincenzo Gravina, che ne sono anche i fondatori. Crescimbeni era un classicista, Gravina aveva una concezione della poesia più moderata (secondo lui era una manifestazione primitiva di filosofia). In un ambiente conservatore ebbe più successo la concezione di Crescimbeni, infatti Gravina se ne dovette andare, e fondò l’accademia dei Quirini; Gravina fu il tutore di un grande letterato italiano, Pietro Metastasio (pseudonimo di Pietro Trapassi). Metastasio nacque a Roma, e sin da giovane si dedica a studi umanistici. Quando Gravina abbandonò l’Arcadia, Metastasio lasciò Roma per recarsi a Napoli, dove vi erano gli austriaci, e lì apprese lezioni di musica; nasce così in Metastasio l’idea di fare componimenti che poi saranno rappresentati in musica (i cosiddetti libretti). Nel Settecento il melodramma era già molto diffuso a teatro. Nella composizione delle opere teatrali vi erano gli addetti alla musica e gli addetti ai libretti; nel Settecento avevano molta più importanza le musiche rispetto ai libretti (l’attività del librettista era messa in secondo piano). Il librettista di Mozart era Lorenzo da Ponte. Il melodramma risulta più pacato della tragedia, che seguiva ancora il modello greco (il fine era suscitare la catarsi). Sulla scena potevano cantare solo figure maschili, infatti uno dei provvedimenti dell’Illuminismo fu quello di proibire la pratica della castrazione maschile (veniva fatta in gioventù, per rimanere soprani). Parini scrisse “La Musica”, dove viene criticata questa pratica.
Metastasio e la riforma del melodramma
Metastasio tentò di riformare il melodramma, dando maggiore importanza al libretto. Egli scrisse libretti che dovevano essere recitati da attori accompagnati solo da uno strumento musicale, il clavicembalo (nel clavicembalo le corde non vengono percosse, ma bensì pizzicate). La parte in cui l’orchestra è al massimo è chiamata aria (che è anche la parte che più viene suonata e ricordata, e che finirono per circolare in maniera autonoma). Metastasio si rifiutò di attingere alla tragedia greca, ma attinse dal mito e da parti di tragedia poco conosciute (ad esempio, Didone Innamorata). Dopo essere stato a Napoli, Metastasio si reca a Vienna, dove visse il resto della sua vita (egli è considerato un poeta cesareo, perché visse all’interno della corte austriaca). La riforma del melodramma resse per un piccolo periodo, ma poi si finì per dimenticare il libretto.
Evoluzione del melodramma e opera buffa
Nel corso del Settecento ci fu un’evoluzione per quanto riguarda i personaggi: i personaggi non dovevano più essere per forza seri, ma che si adeguassero più alla commedia rispetto che alla tragedia; nasce così l’opera buffa, dove i personaggi sono borghesi, comici e che recitano con un linguaggio dialettale. Questo genere divenne poi commedia dell’arte (con Carlo Goldoni), dove i protagonisti sono comici e stereotipati.
Domande da interrogazione
- Quali furono le principali potenze politiche del Settecento e come influenzarono l'Italia?
- Quali furono i miglioramenti igienico-sanitari e agricoli nel Settecento?
- Come si manifestò l'Illuminismo in Italia e quali furono le sue caratteristiche principali?
- Chi furono i protagonisti dell'Arcadia e quale fu il loro contributo alla cultura del Settecento?
- In che modo si evolse il melodramma nel Settecento e quale nuovo genere emerse?
Nel Settecento, Inghilterra e Austria emersero come potenze predominanti, mentre la Spagna declinò. In Italia, gli Asburgo sostituirono gli spagnoli al nord, mentre i Borbone presero il controllo del sud, influenzando la situazione politica e sociale del paese.
Durante il Settecento, furono introdotte leggi igienico-sanitarie come l'editto di Saint Cloud in Francia, e si scoprì il vaccino del vaiolo. In Inghilterra, la rivoluzione agricola aumentò la produzione alimentare, contribuendo allo sviluppo economico e al commercio.
L'Illuminismo in Italia si divise in due correnti: quella del Nord, più vicina all'Europa, e quella di Napoli, focalizzata su studi giuridici. Tuttavia, l'Italia rimase politicamente frammentata, e solo alla fine del secolo si iniziarono a vedere i primi segnali di unità.
L'Arcadia, un'accademia romana, cercò di superare il Barocco. Tra i suoi protagonisti vi furono Mario Crescimbeni e Vincenzo Gravina. Metastasio, allievo di Gravina, contribuì alla riforma del melodramma, dando maggiore importanza ai libretti.
Nel Settecento, il melodramma si evolse con l'introduzione dell'opera buffa, caratterizzata da personaggi borghesi e comici che utilizzavano un linguaggio dialettale. Questo genere si sviluppò ulteriormente nella commedia dell'arte, con protagonisti comici e stereotipati.

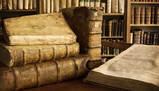





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo