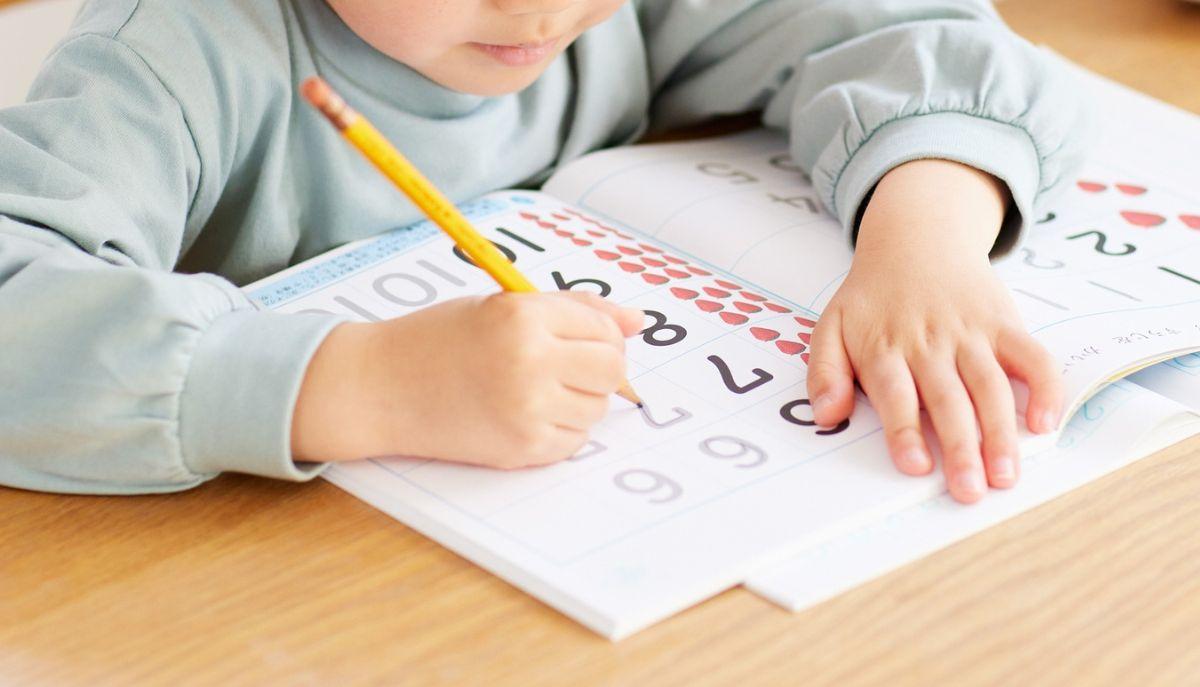
Quando si parla di DSA, strumenti compensativi e misure dispensative, è fondamentale avere ben chiaro su cosa siano, quando si usano e perché.
Innanzitutto, lo scopo di questi strumenti non è facilitare il compito di questi studenti, ma di rendere accessibile l’apprendimento a chi, per una difficoltà specifica certificata, non può affrontare lo studio con gli stessi mezzi dei coetanei.
Secondo la Legge 170/2010, che regola proprio i Disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), ogni studente con DSA riconosciuto ha diritto a un percorso personalizzato di studio. Tale percorso si basa sul Piano Didattico Personalizzato (PDP), documento in cui vengono indicati strumenti compensativi e misure dispensative utili al singolo alunno.
Indice
Cosa sono gli strumenti compensativi
Gli strumenti compensativi sono mezzi che sostituiscono o facilitano le abilità compromesse, consentendo allo studente con DSA di raggiungere gli stessi obiettivi dei compagni. Non sono semplificazioni dei contenuti, ma strumenti che permettono di accedere in modo alternativo all’informazione, migliorando l’efficacia dell’apprendimento.
Sono previsti esplicitamente dall’articolo 5 della Legge 170, che garantisce il diritto a “provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica”. La loro applicazione deve essere però coerente con quanto previsto dal PDP (Piano Didattico Personalizzato), che viene redatto sulla base della diagnosi di DSA presentata dalla famiglia.
Tali strumenti possono essere a bassa tecnologia (come mappe cartacee, righelli segnalibro o formulari) oppure a tecnologia avanzata, come software per la sintesi vocale, editor di matematica e libri digitali. L’obiettivo, in ogni caso, è compensare l’abilità deficitaria, che può riguardare la lettura, la scrittura o il calcolo.
Esempi di strumenti compensativi per dislessia e altri DSA
Nel caso della dislessia, ad esempio, gli strumenti compensativi più comuni sono:
- testi con caratteri ad alta leggibilità o spaziatura aumentata;
- sintesi vocale, che consente allo studente di "leggere con le orecchie";
- C-Pen e penne digitali, per ascoltare i testi direttamente mentre vengono acquisiti;
- programmi come Geco o ePico!, che integrano lettura, sintesi vocale, creazione di mappe concettuali e calcolatrici con voce;
- libri scolastici in formato digitale, richiesti attraverso il servizio LibroAID;
- software per creare e usare mappe concettuali multimediali, come SuperMappe EVO o SuperMappeX LAB.
Per la disgrafia o la disortografia, si può ricorrere a:
- computer con correttore ortografico;
- registratori vocali per evitare la presa di appunti a mano;
- software di riconoscimento vocale.
Nel caso della discalculia, invece, sono utili:
- calcolatrici, anche parlanti;
- tabelle dei numeri o tavole pitagoriche;
- editor matematici come MateMitica;
- fogli di calcolo elettronici per organizzare dati e operazioni.
Sintesi vocale: come funziona e perché è utile
Tra gli strumenti più noti e utilizzati in caso di dislessia c’è la sintesi vocale. Che avviene attraverso programmi che leggono ad alta voce il testo digitale, facilitando la comprensione e riducendo l’affaticamento. Si parla infatti di “lettura con le orecchie”, un’espressione che rende bene il concetto di compensazione.
Un esempio diffuso è la sintesi vocale Loquendo, che offre voci naturali in italiano e in altre lingue, quindi utile anche per lo studio delle lingue straniere. La qualità della voce e la fluidità nella lettura rendono questo strumento particolarmente efficace.
Quando si usano gli strumenti compensativi
Dal punto di vista pratico, gli strumenti compensativi devono essere utilizzati ogni volta che lo studente deve affrontare una prestazione legata all’abilità deficitaria. La loro applicazione è, perciò, raccomandata non solo durante le verifiche, ma anche nello studio quotidiano, per favorire l’autonomia e l’inclusione.
La scelta degli strumenti, come detto, deve essere coerente con quanto riportato nel PDP e deve essere condivisa da docenti, famiglia e studente. È inoltre importante che questi vengano sperimentati in modo continuativo, così da verificarne l’efficacia.
Durante le prove d’esame (compresi gli Esami di Stato), invece, gli strumenti compensativi sono autorizzati solo se già previsti nel PDP e già regolarmente utilizzati durante l’anno scolastico che culmina con l'esame.
Le misure dispensative DSA
Altra cosa sono, invece, le misure dispensative DSA, che però si affiancano agli strumenti compensativi. Sono interventi che liberano lo studente da alcune prestazioni particolarmente difficili per lui, senza che ciò ne comprometta l’apprendimento. Esempi di misure dispensative possono essere:
- non leggere ad alta voce in classe;
- non copiare dalla lavagna;
- non scrivere a mano sotto dettatura;
- evitare l’uso del corsivo o dello stampato minuscolo;
- esonero dallo studio delle lingue straniere in forma scritta;
- interrogazioni programmate o verifiche in formato digitale;
- tempi più lunghi per svolgere prove scritte.
Anche queste misure devono essere previste nel Piano Didattico Personalizzato e adottate in modo coerente lungo tutto il percorso scolastico.
DSA e PDP: perché è fondamentale
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP), dunque, è un documento centrale nella gestione scolastica degli alunni con DSA. Viene redatto a seguito della consegna della diagnosi e rappresenta un impegno condiviso tra scuola, famiglia e studente.
Nel PDP vengono indicati:
- gli strumenti compensativi da usare regolarmente;
- le misure dispensative da applicare;
- le strategie didattiche più efficaci;
- le modalità di verifica e valutazione personalizzate.
Senza PDP, non è possibile applicare strumenti o misure durante esami e verifiche ufficiali.
Ogni studente ha bisogno del proprio strumento
Infine, va tenuto ben presente che non esiste uno strumento “migliore in assoluto”. Ogni studente con DSA ha caratteristiche uniche e necessita di strumenti specifici, scelti sulla base del proprio stile di apprendimento. È perciò importante testare più soluzioni, in un percorso che stimoli l’autonomia e la consapevolezza dell'alunno.
L’obiettivo è che lo studente impari a conoscere i propri punti di forza e a compensare le difficoltà con gli strumenti adeguati, senza dipendere costantemente dall’adulto. In questo senso, i laboratori specialistici, i campus per DSA e le attività delle sezioni territoriali AID (Associazione Italiana Dislessia) possono offrire un supporto concreto.







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo