Concetti Chiave
- Il Romanticismo si divide in due forme: uno psicologico legato all'inquietudine umana e uno storico nato in Germania, che ha influenzato tutta Europa tra il '700 e l'800.
- Il termine "romantico" ha subito un'evoluzione, passando da significato dispregiativo a poetico, rappresentando una reazione alla razionalità illuministica.
- Il Romanticismo esalta la creatività e il sentimento, opponendosi all'intellettualismo illuminista, e promuove l'originalità e la libertà espressiva in letteratura e arte.
- Le novità del Romanticismo includono un approccio più emozionale e meno formale alla critica letteraria, con una preferenza per l'espressione spontanea e appassionata.
- Il Romanticismo italiano, influenzato dalla tradizione classica e dalla situazione politica, ha assunto un carattere civile e patriottico, esaltando il sentimento nazionale e l'unità.
Indice
Il romanticismo
Si distingue un romanticismo perenne o psicologico, inteso come stato d’animo dello spirito umano e un Romanticismo storico, inteso come fenomeno culturale che sorge in Germania e si sviluppa in tutta Europa verso la fine del ‘700 e durante tutto l’800. Il romanticismo perenne è costituito da atteggiamenti che lo spirito umano ha sempre assunto in passato come: l’inquietudine e l’insoddisfazione, il contrasto tra reale e ideale, l’abbandono al sogno, al fascino del diverso, dell’ignoto, le avventure dei cavalieri, il senso dinamico della realtà mutevole, senso del divenire, introspezione, analisi acuta di stati d’animo.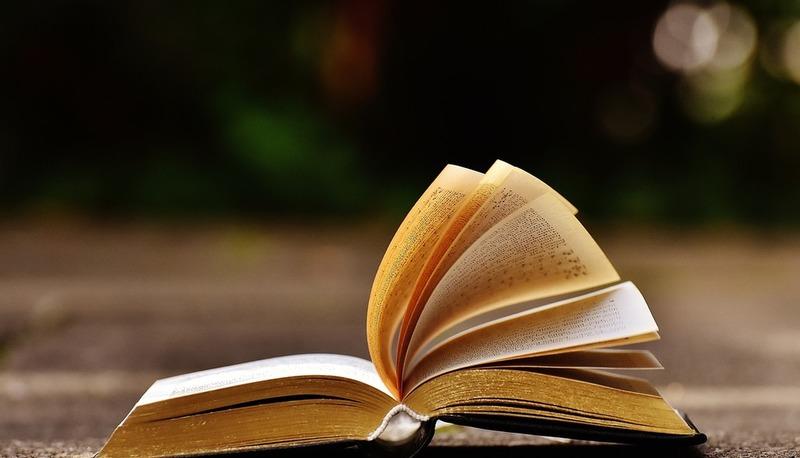 Il Romanticismo storico si ha quando l’uomo acquista una coscienza critica e le traduce in filosofia, in una poetica e gusto e in un costume di vita politica e sociale. Il Romanticismo si adattò alla storia e alla cultura dei vari popoli, assumendo particolari caratteristiche nazionali. Come l’Illuminismo, ebbe il suo centro in Germania, dove ebbe più ampio sviluppo. A fare della Germania la patria del Romanticismo concorse la natura dello spirito tedesco, proteso alla vita del sentimento, della fantasia, del sogno. I tedeschi sono consapevoli che la realtà non può dare e per loro risulta meschina, limitata e deludente. Simbolo di questa felicità lontana e irraggiungibile è il “fiore azzurro” di cui parla Novàlis. Il “fiore azzurro” è il simbolo della felicità che cerchiamo, ma invano, per i limiti della realtà in cui viviamo. La possiamo trovare solo nel mondo dei sogni o intravista in qualche circostanza, come nell’amore. Questo stato d’animo ha conferito alla cultura della Germania un carattere genuinamente romantico, che fa prevalere il sentimento sulla ragione. Tuttavia l’immagine di questa Germania romantica è poco conosciuta e contrastata dal suo noto aspetto militarista e aggressivo. Così si presenta con un doppio volto: da un lato come la patria di grandi poeti, musicisti, filosofi, storici, dall’altro come la patria della guerra, dei demoniaci inventori dei lager, camere a gas, forni crematori, del genocidio degli Ebrei. La prima è la Germania di Weimar (ammirata e amata), la seconda è la Germania di Potsdam (quella che ci fa terrore). Gli storici hanno voluto spiegare l’enigma del bifrontismo tedesco e hanno individuato due cause: una di natura politica e l’altra di natura religiosa. Quando nel ‘500 scoppio la Riforma protestante contro la Chiesa di Roma, i contadini tedeschi si ribellarono ai loro padroni e Lutero, per timore di vedere compromessa la sua riforma, si schierò dalla parte dei prìncipi e li invitò a schiacciare i ribelli. Furono uccisi 130 mila contadini. Sul piano religioso Lutero predicava il rifiuto del mondo come regno del male e spingeva l’anima tedesca alla fuga nel mondo del sogno e del sentimento. Nel richieder, infine, la sottomissione assoluta all’autorità, conferiva allo Stato una struttura autoritaria e totalitaria. Risale perciò a Lutero il bifrontismo dell’anima tedesca, divisa dalla possibilità di coltivare liberamente la vita interiore e la sua rinuncia alla vita politica e sociale che lo portò a essere un suddito obbediente. Pertanto sorsero in molti europei perplessità derivanti dal timore di un risorgere della vecchia Germania distruttiva, quella di Potsdam. Pertanto, dopo del dure esperienze della storia recente, quando la Germania dell’ovest risorse dalle proprie ceneri e raggiunse in pochi anni il primato dell’economia europea, i Tedeschi si resero conto che possono essere ugualmente una grande potenza Europea senza sparare un solo colpo di fucile, ma con la sola forza della cultura e del lavoro. A conferma del valore universale della Germania, Benedetto Croce nel suo scritto “Goethe e la Germania”, ripropone la grande funzione di civiltà della nazione tedesca. Per l’autore la Germania vanta celebrazioni primitive della sua potente originalità e creatività; basta pensare a poeti come Goethe e pensatori che ancora sono attuali e maestri come Kant, Hegel e storici e filologi che rinnovarono lo studio della lingua. Dell’Europa la Germania fu la figlia maggiore. Essa ha il merito di aver saputo cogliere, in quel dato periodo storico, i nuovi bisogni del genere umano.
Il Romanticismo storico si ha quando l’uomo acquista una coscienza critica e le traduce in filosofia, in una poetica e gusto e in un costume di vita politica e sociale. Il Romanticismo si adattò alla storia e alla cultura dei vari popoli, assumendo particolari caratteristiche nazionali. Come l’Illuminismo, ebbe il suo centro in Germania, dove ebbe più ampio sviluppo. A fare della Germania la patria del Romanticismo concorse la natura dello spirito tedesco, proteso alla vita del sentimento, della fantasia, del sogno. I tedeschi sono consapevoli che la realtà non può dare e per loro risulta meschina, limitata e deludente. Simbolo di questa felicità lontana e irraggiungibile è il “fiore azzurro” di cui parla Novàlis. Il “fiore azzurro” è il simbolo della felicità che cerchiamo, ma invano, per i limiti della realtà in cui viviamo. La possiamo trovare solo nel mondo dei sogni o intravista in qualche circostanza, come nell’amore. Questo stato d’animo ha conferito alla cultura della Germania un carattere genuinamente romantico, che fa prevalere il sentimento sulla ragione. Tuttavia l’immagine di questa Germania romantica è poco conosciuta e contrastata dal suo noto aspetto militarista e aggressivo. Così si presenta con un doppio volto: da un lato come la patria di grandi poeti, musicisti, filosofi, storici, dall’altro come la patria della guerra, dei demoniaci inventori dei lager, camere a gas, forni crematori, del genocidio degli Ebrei. La prima è la Germania di Weimar (ammirata e amata), la seconda è la Germania di Potsdam (quella che ci fa terrore). Gli storici hanno voluto spiegare l’enigma del bifrontismo tedesco e hanno individuato due cause: una di natura politica e l’altra di natura religiosa. Quando nel ‘500 scoppio la Riforma protestante contro la Chiesa di Roma, i contadini tedeschi si ribellarono ai loro padroni e Lutero, per timore di vedere compromessa la sua riforma, si schierò dalla parte dei prìncipi e li invitò a schiacciare i ribelli. Furono uccisi 130 mila contadini. Sul piano religioso Lutero predicava il rifiuto del mondo come regno del male e spingeva l’anima tedesca alla fuga nel mondo del sogno e del sentimento. Nel richieder, infine, la sottomissione assoluta all’autorità, conferiva allo Stato una struttura autoritaria e totalitaria. Risale perciò a Lutero il bifrontismo dell’anima tedesca, divisa dalla possibilità di coltivare liberamente la vita interiore e la sua rinuncia alla vita politica e sociale che lo portò a essere un suddito obbediente. Pertanto sorsero in molti europei perplessità derivanti dal timore di un risorgere della vecchia Germania distruttiva, quella di Potsdam. Pertanto, dopo del dure esperienze della storia recente, quando la Germania dell’ovest risorse dalle proprie ceneri e raggiunse in pochi anni il primato dell’economia europea, i Tedeschi si resero conto che possono essere ugualmente una grande potenza Europea senza sparare un solo colpo di fucile, ma con la sola forza della cultura e del lavoro. A conferma del valore universale della Germania, Benedetto Croce nel suo scritto “Goethe e la Germania”, ripropone la grande funzione di civiltà della nazione tedesca. Per l’autore la Germania vanta celebrazioni primitive della sua potente originalità e creatività; basta pensare a poeti come Goethe e pensatori che ancora sono attuali e maestri come Kant, Hegel e storici e filologi che rinnovarono lo studio della lingua. Dell’Europa la Germania fu la figlia maggiore. Essa ha il merito di aver saputo cogliere, in quel dato periodo storico, i nuovi bisogni del genere umano.Altre caratteristiche
Il termine “romantico” fu usato per la prima volta in Inghilterra dai razionalisti, con significato dispregiativo. Significava, infatti, cosa irreale, assurda, fantastica. Il termine ricompare nel ‘700, ma questa volta con note positive. Viene riferito al paesaggio, e significa piacevole, attraente, pittoresco. Verso la fine del ‘700 Novàlis da a “romantico” il significato di poetico, per identificare una poetica conforme alla nuova sensibilità malinconica e sognante, di imitazione classica. Il Romanticismo si manifesta quando entra in crisi l’ideologia illuministica e si sviluppa in tutto l’800, ma rimane anche nel ‘900, perché il Decadentismo non fa che riprendere il soggettivismo romantico, ridotto a puro irrazionalismo. Riesce difficile definire il Romanticismo, perché è un movimento complesso che interessò tutti i campi dell’attività umana e perché c’è una mancanza di una prospettiva storica. Infatti, mentre del Rinascimento e Illuminismo si può fare una valutazione critica esauriente, il Romanticismo è un movimento ancora aperto e arriva fino alla nostra età. Però di esso di possono dare definizioni parziali: nel campo filosofico, il Romanticismo reagisce all’intellettualismo illuministico e propone la creatività dello spirito; nel campo letterario e artistico, esso rifiuta il concetto della poesia e dell’arte come imitazione, e introduce il concetto dell’arte come originalità, libertà di espressione; nel campo religioso, esso contrappone all’ateismo e al materialismo dell’Illuminismo, il ritorno allo spiritualismo e ai valori della religione tradizionale; nel campo morale, esso respinge l’ideale di vita degli illuministi, sulla ricerca della felicità, appagata dalla ragione. I romantici considerano questa “felicità naturale” piatta, mediocre, insignificante. Anch’essi aspirano alla felicità, ma la vogliono assoluta, totale; nel campo politico, esso rifiuta il cosmopolitismo degli illuministi, il concetto di “cittadino del mondo” e contrappone il concetto di nazione, una comunità che ha una propria fisionomia, lingua, storia, pensiero e ideali. Inoltre promuove gli ideali di democratici di libertà, eguaglianza e giustizia; nel campo storiografico, esso reagisce all’antistoricismo illuminista. Gli illuministi valorizzavano il Rinascimento e giudicavano barbare le età lontane dal loro ideale di vita razionale e naturale, come il Medioevo. I romantici, invece, nello studio del passato ricercano gli elementi comuni e universali, le caratteristiche proprie dei singoli popoli e delle singole epoche. Tra quelle che suscitano interesse ai romantici vi troviamo il Medioevo, considerato come periodo di formazione dei nuovi popoli e letterature europee, e la civiltà della Grecia classica dove essi svalutano la letteratura latina considerata imitazione di quella greca, e così più vicina al loro concetto di poesia; nel campo sociale, esso reagisce alla sfiducia dell’Illuminismo verso ogni iniziativa popolare; nel campo scientifico, esso reagisce al culto della scienza considerata come il solo strumento di progresso. Al di fuori di questo compito, per i romantici, essa ha il merito di risolvere problemi spirituali dell’uomo, soddisfare la sete di assoluto mediante l’intuizione del sentimento; nel campo linguistico, esso reagisce al cosmopolitismo linguistico illuminista, all’idea cioè di una lingua universale. Esso riconosce il valore di ogni lingua nazionale; nella concezione dell’individuo, mentre la filosofia illuministica valorizzava la ragione, che doveva frenare e correggere le passioni, l’uomo romantico tende ad emergere, spinto dalla coscienza della propria individualità ed esalta il sentimento, molla che lo spinge all’azione. Riassumendo il Romanticismo, movimento culturale che esalta la libertà e creatività dello spirito, valorizza: il sentimento, l’originalità, i dialetti, la Nazione, il popolo e il divenire dell’umanità e della storia in senso progressivo.Il Romanticismo ha una genesi filosofica e una storica. Sul piano filosofico esso sorge come reazione alla filosofia illuminista. I romantici rifiutano la concezione della natura come una macchina che si muove secondo leggi inesorabili e l’uomo che è destinato, con la morte, ad annullarsi nella materia. Accusano poi gli illuministi di astrattezza; l’uomo non è solo ragione, ma ci sono facoltà dello spirito come sentimento e fantasia che l’Illuminismo ha represso e disprezzato. Ci sono poi dei problemi esistenziali, sull’origine dell’uomo e del suo destino e infine esigenze dello spirito, come l’ansia religiosa, cioè l’ansia di credere in qualcuno o qualcosa. La genesi storica nasce dalla comprensione che gli ideali illuministici (età napoleonica) erano delle pure e semplici astrazioni, ben difficili da tradursi in pratica. Quindi da un primo momento di entusiasmo, subentrò quello di delusione, e quindi di reazione all’Illuminismo: nacque così il Romanticismo. Oggi, però, gli storici riconoscono il valore positivo della Rivoluzione francese e della politica napoleonica, che diede comunque un assestamento all’Europa. All’Europa ancora feudale del ‘700, socialmente chiusa, succedeva nell’800 un’Europa liberale e borghese, socialmente aperta e progressiva.
Quando si dice che il Romanticismo si oppone all’Illuminismo non bisogna intendere, però, che tra questi movimenti ci sia una frattura netta. Anche se c’è nel modo di concepire la vita, la natura, l’uomo, la storia, la poesia e l’arte, sul piano politico-sociale molte idee illuministiche si ritrovano nel Romanticismo, in quanto, il Romanticismo allo stesso tempo si impegna di calare gli ideali politici e sociali illuministi nella propria realtà, adattandoli alle condizioni del popolo. Visto sotto questo aspetto, il Romanticismo si può considerare l’antitesi e la naturale continuazione dell’Illuminismo.
Lo stato d’animo romantico è inquieto, malinconico, cupo, sempre insoddisfatto. Una tale concezione meccanicistica della natura e dell’uomo era motivo di serenità per gli illuministi, perché li liberava dalle superstizioni; per i romantici è, invece, motivo di infelicità, in quanto comporta il senso del nulla eterno dopo la morte. Per i romantici l’uomo illuminista non differisce da una pianta o da una bestia, con la grave consapevolezza di ciò che li attende dopo la morte: il nulla eterno. L’assoluta felicità che gli illuministi vedevano nel passato, i romantici la proiettano nel futuro, come una meta verso cui l’uomo è diretto. Inizialmente i romantici pensano di poter raggiungere questa meta, ma poiché il loro spirito si sente infinito non viene mai soddisfatto pienamente. Perciò lo spirito romantico si abbandona ad esperienze come l’esotismo, cioè la fuga sentimentale alla ricerca di paesi felici e lontani; il rifugio nel mondo del sogno; la natura; l’arte e l’amore. Da questo sentimenti di tristezza derivò la famosa “malattia del secolo”. Per gli spiriti più forti, pur avendo la coscienza dell’infelicità umana, non soccombono alla tristezza e dice il Croce che per essi la malattia romantica fu una nobile malattia. I modi con cui gli spiriti romantici cercano di superare il pessimismo sono vari. Molti ritornano alla fede cristiana e ritrovano il significato della vita in Dio. Non tutti, però, ritornano alla religione tradizionale, ma si creano un tipo di religiosità laica ugualmente fervida ed efficace, stimolatrice di una vita attiva e operosa. In tutte le maniere con cui il Romanticismo reagì all’Illuminismo, è importante il senso religioso, attivo e costruttivo della vita, che fece dell’800 uno dei secoli più operosi della storia: il secolo del liberalismo che promosse la religione della libertà e il progresso scientifico e il secolo del socialismo che si impegnò a estendere alle classi sociali più umili i benefici di libertà e progresso.
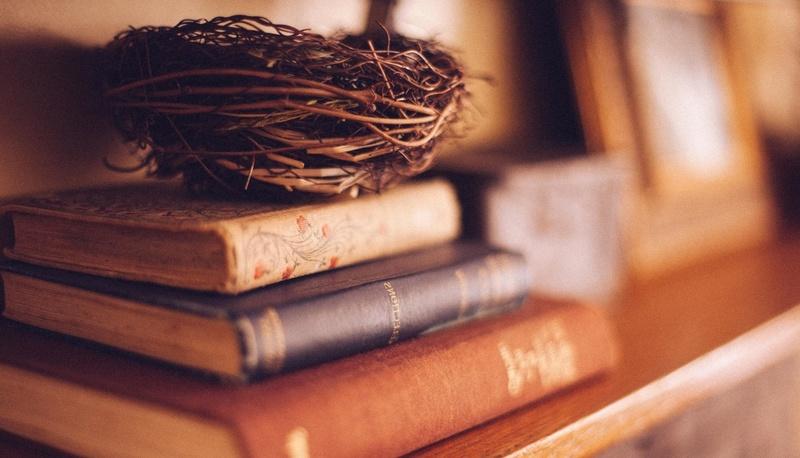
Aspetti negativi del romanticismo
Gli aspetti negativi del Romanticismo:• L’esaltazione del sentimento degenera nel sentimentalismo che porta all’inerzia;
• L’esaltazione dell’individualità degenera nel velleitarismo, ossia ispirazione alla grandezza senza avere le qualità sufficienti o nel superomismo, cioè rifiuto di ogni fine morale;
• Il sentimento nazionale nel nazionalismo che poi darà origine al fascismo e nazismo;
• Il senso del mistero e del dolore degenera nel vittimismo;
• L’ansia religiosa nel misticismo estetizzante, cioè religiosità da salotto o panismo, il vagheggiare della natura;
• Il liberalismo, con l’affermazione della borghesia si svuota dei suoi valori. Infatti la borghesia, per difendere la sua supremazia nei confronti del nuovo proletariato socialista, diventa repressiva e non più progressiva;
• La Rivoluzione Industriale da origine al fenomeno dell’urbanesimo con conseguenze quali lo sfruttamento e l’alienazione;
• L’attivismo romantico, inteso come impegno morale e civile, degenera nel bel gesto fine a se stesso.
La poetica
Il mondo classico ha una visione statica della vita, poiché la concepisce come continuità di valori universali ed eterni, ereditati quali: la saggezza, spirito critico, il senso dell’ordine, della disciplina, l’armonia. L’arte è imitazione della natura, per cui nel Rinascimento si imitano gli scrittori classici, considerati profondi conoscitori delle regole letterarie. Per il Romanticismo, invece, la vita è dinamica e quindi l’arte è intesa come continuo divenire. Essa non solo cambia da epoca a epoca ma anche da individuo a individuo, essendo non imitazione ma creatività e spontaneità. Le conseguenze di questa concezione sono: la libertà di ispirazione ed espressione; rifiuto delle regole retoriche del mondo classico e della mitologia; rifiuto di modelli precostituiti perché nemici della spontaneità; rifiuto classicistico del bello ideale a cui si contrappone il bello reale, come il vero interiore e psicologico dell’individuo e quello della realtà, volto ad evidenziare la vita sociale di un dato tempo e luogo. La poesia deve essere, inoltre, popolare ed il poeta, facendo suoi gli ideali e le aspirazioni della gente, deve essere guida della nazione. Nasce dunque la poesia pura, non erudita e oratoria, ma aderente al sentimento.Le novità del romanticismo
Le novità del Romanticismo sono:• Il critico romantico è sensibile, ricco di sentimenti e umanità e cerca di penetrare nel mondo spirituale del poeta per mettere in evidenza l’originalità, l’individualità e storicità della sua opera;
• Il gusto è meno colto ed elegante del classicismo. Si preferiscono poeti rozzi e ingenui ma ricchi di impeti e passioni;
• Lo stile è meno controllato e letterario del mondo classico. Esso è spontaneo e vibrante e rispecchia le passioni e il sentimento;
• I generi letterari diventano liberi; la tragedia perde le tre famose unità (tempo, luogo e azione) e si arricchisce di elementi filosofici. Nascono nuovi generi letterari, quali la novella in prosa e versi, le romanze, storie d’amore e di armi, ma il genere letterario più diffuso è il romanzo, epistolare, storico, psicologico e sociale;
• Muta anche il sentimento della natura e il gusto del paesaggio. Alla natura controllata e luminosa dell’Ariosto, si preferiscono i paesaggi notturni, favorevoli alla meditazione ed effusione sentimentale.
I temi della poetica romantica
I temi della poetica romantica sono:• Il tema del dolore, che deriva dal contrasto tra le aspirazioni dell’individuo all’infinito e assoluto e la realtà banale e meschina. Talvolta il dolore è paradossalmente amato come segno di nobiltà e distinzione dai bruti. Il dolore genera due atteggiamenti contrastanti: il titanismo (lotta tra i titani e Zeus), che celebra la lotta degli eroi contro ciò che opprime la libertà umana; il vittimismo, sofferenza senza ribellione avvertita come segno di nobiltà e distinzione;
• Il senso del mistero e la brama dell’assoluto;
• La poesia della memoria, come nostalgia e rievocazione del passato.
I romanticismi europei
Il Romanticismo sorto in Germania si diffuse in tutt’Europa con caratteristiche proprie. Il Romanticismo tedesco ebbe un carattere filosofico-mistico fondato sulla convinzione della realtà come divenire e conquista dell’assoluto. Quello inglese, un carattere panico-nostalgico, volto a fondare la propria individualità con la natura. Quello francese ha carattere umanitario e sociale, volto alla fratellanza e riscatto degli oppressi.il romanticismo italiano
Il Romanticismo italiano ebbe un carattere moderato ed equilibrato per diverse ragioni. La prima fu l’influenza della tradizione classica che operò da freno, purificando il Romanticismo da aspetti torbidi e irrazionali. L’altra ragione fu la situazione politica italiana, uscita dal congresso di Vienna divisa e tuttavia volta all0indipendenza e unità. Perciò gli scrittori romantici italiani esaltarono il sentimento nazionale, la libertà e spontaneità dei popoli oppressi. Essi assunsero il compito di risvegliare la coscienza nazionale e l’amor patrio. Questo spiega il carattere civile eroico ed educativo del romanticismo italiano. Foscolo, Manzoni e Leopardi trattarono nelle loro opere temi fondamentali, quali il sentimento drammatico e doloroso della vita, l’ansia religiosa e la ricerca di un valore universale e il significato dell’esistenza. Essi, però, svolsero queste tematiche in modo così lucido ed equilibrato che ancora oggi si discute se furono scrittori romantici o classici. Altro elemento frenante fu la cultura illuministica e il realismo degli scrittori del Caffè, la poesia civile e morale del Parini, la passione libertaria dell’Alfieri e del neoclassicismo di Foscolo. Ebbe due indirizzi: realistico oggettivo che rappresentò la realtà esteriore politica e sociale e diede luogo alla letteratura patriottica del Risorgimento (Manzoni); indirizzo lirico, espressione del mondo interiore e del sentimento (Leopardi).la critica
Goethe chiama: classico ciò che è sano perché il classicismo era sanità morale, equilibro e armonia; malato ciò che è romantico a causa della morbosità sentimentale, gusto dell’irrazionalità e dell’orrido.Per B. Croce il Romanticismo si divide in teorico-speculativo e morale-pratico. Il primo è quello delle conquiste ideali, quali la religione della libertà, lotta contro ogni servitù economica e intellettuale; il secondo è quello della fiacchezza e languori sentimentali. Per lui il Romanticismo è il momento passionale presente nell’opera d’arte, mentre il classicismo è il momento formale. La perfezione artistica si raggiunge quando l’opera d’arte realizza la sintesi dei due momenti creativi, quello romantico-passionale e quello classico-formale.
Domande da interrogazione
- Qual è la distinzione tra Romanticismo perenne e Romanticismo storico?
- Come si è sviluppato il Romanticismo in Germania e quali sono le sue caratteristiche principali?
- Quali sono gli aspetti negativi del Romanticismo?
- Quali sono le novità introdotte dal Romanticismo nella letteratura e nell'arte?
- In che modo il Romanticismo italiano si differenzia dagli altri romanticismi europei?
Il Romanticismo perenne è uno stato d'animo umano caratterizzato da inquietudine e insoddisfazione, mentre il Romanticismo storico è un fenomeno culturale nato in Germania e diffuso in Europa tra la fine del '700 e l'800.
In Germania, il Romanticismo si è sviluppato grazie alla natura dello spirito tedesco, incline al sentimento e al sogno, e si caratterizza per la prevalenza del sentimento sulla ragione, simboleggiato dal "fiore azzurro" di Novàlis.
Gli aspetti negativi includono il sentimentalismo che porta all'inerzia, il velleitarismo, il nazionalismo, il vittimismo, il misticismo estetizzante, e la degenerazione del liberalismo borghese.
Il Romanticismo ha introdotto la libertà di ispirazione ed espressione, il rifiuto delle regole classiche, la valorizzazione del bello reale e la poesia popolare, promuovendo nuovi generi letterari come il romanzo.
Il Romanticismo italiano è caratterizzato da un equilibrio moderato, influenzato dalla tradizione classica e dalla situazione politica, esaltando il sentimento nazionale e la libertà, con un carattere civile ed educativo.






 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo