
. Considerato il padre di una nuova disciplina scientifica – la paleogenomica - Pääbo ha dedicato la sua vita allo studio della storia del genoma umano.
I suoi studi nel campo della genetica, tra i più importanti degli ultimi 30 anni, hanno permesso di rilevare i geni di ominidi esistiti oltre 70mila anni fa, ancora oggi presenti nel DNA della specie umana. A Pääbo, infatti, si deve la mappatura completa del DNA dei nostri “parenti” più diretti: i Neanderthal.
-
Leggi anche:
- L'incredibile video del ciclista che si sdraia sul sellino e supera tutti
- Che giorno è Halloween 2022? Ecco quando cade la data
- Quando scatta l'ora solare a Ottobre 2022
Il problema del DNA dei Neanderthal
Il contributo di Pääbo è stato fondamentale per comprendere la storia passata della razza umana.Oggi sappiamo che la nostra specie (Homo Sapiens) apparve in Africa circa 300mila anni fa, mentre i nostri parenti più stretti – i Neanderthal – si svilupparono fuori dall’Africa e popolarono principalmente l’Europa - e parte dell’Asia occidentale - più di 400mila anni fa, rimanendo nei paraggi fino a 30mila anni fa, fino alla loro estinzione. Per un lungo periodo di tempo la nostra specie convisse con i Neanderthal, come testimoniano le migrazioni dell'Homo Sapiens verso l'area del Medio Oriente, instaurando relazioni tra loro. Alla fine degli anni '90 alcuni studiosi erano riusciti a decifrare quasi tutto il genoma umano, rendendo possibile il confronto tra i genomi di diverse popolazioni di esseri umani esistite nelle ere geologiche.
Studi che però si erano bloccati davanti al complesso DNA dell'uomo di Neanderthal. Dopo migliaia di anni infatti, le tracce di DNA che rimangono su un reperto sono poche e spesso contaminate, dalla presenza di materiale genetico di altri organismi come i batteri. Pääbo, da sempre affascinato dalla possibilità di studiare il DNA dei Neanderthal, lavorò per anni ad un sistema in grado di aggirare lo scoglio. Negli anni '90 quindi si concentrò sullo studio dei mitocondri contenuti nel DNA dei Neanderthal. I mitocondri sono delle strutture microscopiche presenti in una cellula dotati di un loro DNA, quindi un genoma relativamente piccolo: se ne contano migliaia all'interno di una singola cellula. E proprio questa caratteristica permetteva di trovare porzioni intatte di DNA per il lavoro di analisi.
La svolta di Pääbo
L'intuizione si rivelò corretta: Pääbo riuscì a mappare il DNA da un reperto di 40mila anni fa, portando nuovi importanti elementi per dimostrare come i Neanderthal si distinguessero, dal punto di vista genetico, dagli esseri umani e dagli scimpanzé. Così, dopo i primi successi ottenuti, il biologo provò a mappare il genoma dei Neanderthal. Insieme al suo gruppo di ricerca al "Max Planck Institute" di Lipsia (Germania) perfezionò nuove tecniche di analisi su ossa molto antiche, riuscendo a pubblicare il primo genoma di un Neanderthal nel 2010.
Dallo studio emerse che il più recente antenato comune ai Neanderthal e all'Homo Sapiens fosse vissuto circa 800mila anni fa. L'indagine portò ad una conferma: nei loro millenni di coesistenza, i Neanderthal e gli Homo Sapiens si incrociarono tra loro portando la nostra specie a ereditare caratteristiche genetiche di entrambe le specie. Ad oggi si stima infatti che il genoma degli umani dell'epoca in corso, con discendenza europea o asiatica, sia per un 1% comune ai Neanderthal.
La scoperta dei Denisoviani
Al biologo svedese si deve poi un altro importante contributo: l'identificazione di una razza mai rinvenuta fino al 2008, i denisoviani. Con il proprio gruppo di ricerca, Pääbo si occupò dell’analisi di alcuni resti ossei trovati nel 2008 in alcune grotte di Denisova nei Monti Altaj, in Siberia. Fu così che seguì un'altra importante scoperta. Quando i primi Homo Sapiens migrarono fuori dall’Africa, in Europa e in Asia c'erano già due distinte popolazioni di ominidi esistenti. A ovest vivevano soprattutto i Neanderthal, mentre a est i denisoviani. Al loro arrivo sul continente, gli Homo Sapiens si incrociarono non solo con i Neanderthal, ma anche con i denisoviani, ereditando parte del loro materiale genetico.





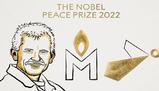

 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo